The Project Gutenberg eBook of La vita in Palermo cento e più anni fa, Volume 2
Title: La vita in Palermo cento e più anni fa, Volume 2
Author: Giuseppe Pitrè
Release date: October 11, 2011 [eBook #37720]
Language: Italian
Credits: Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli, Barbara Magni, and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
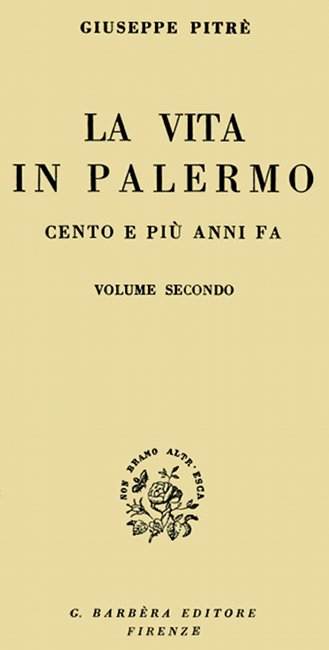
INDICE
- I. Feste sacre e profane, civili e religiose.
- II. Spettacoli e Passatempi.
- III. I Teatri e le Artiste; i partigiani di esse. Lotte tra il S.a Cecilia ed il S.a Lucia.
- IV. Il «Casotto delle Vastasate», ossia il teatro popolare.
- V. I Musici e la loro Unione. Musicate, Oratorii, Cantate, Dialoghi.
- VI. La Bolla della Crociata.
- VII. Quaresimali e Quaresimalisti. Esercizi spirituali.
- VIII. Frati, Monaci e Conventi.
- IX. La professione di una monaca.
- X. Le Monache e la loro vita nei Monasteri.
- XI. Di preminenze in giurisdizioni.
- XII. Impeti e ragazzate.
- XIII. Indelicatezze, fallimenti, malversazioni.
- XIV. Asilo sacro, o Immunità ecclesiastica.
- XV. Oziosi, vagabondi, accattoni, «cassariote». Carestia.
- XVI. Liti, Avvocati, foro.
- XVII. Carceri e carcerati.
- XVIII. Il boia e le esecuzioni di giustizia. Grazia di vita. Dolorosa statistica di giustiziati.
- XIX. I giornali e la pubblicità.
- XX. Il Conte Cagliostro.
- XXI. L'Ab. Vella e la sua famosa impostura.
- XXII. I Medici e la loro vita. Nobili esempi di carità. L'Accademia dei medici e la prima Condotta medica.
- XXIII. Accademie e accademici. Genus irritabile...
- XXIV. Patriottismo degli studiosi. L'Ab. Cannella. Dispute filosofiche e teologiche. Storici, letterati, poeti.
- XXV. L'Accademia (Università) degli studi e gli studenti.
- XXVI. Scuole inferiori pubbliche e private, maschili e femminili. Castighi, monellerie, usanze vecchie e pratiche nuove.
- Conclusione.
- Ragguaglio tra i pesi e le monete del secolo XVIII e i pesi e le monete d'oggi.
CAP. I.
FESTE SACRE E PROFANE, CIVILI E RELIGIOSE.
Gli spettacoli si alternavano con le feste, e le une e gli altri si succedevano con inalterata puntualità. Titolati, civili, popolani vi prendevano parte e se le godevano in ragione del loro grado, della loro inclinazione e dell'uso tradizionale.
La rassegna di quegli spettacoli e di quelle feste sarebbe essa sola materia d'un libro: tanti e così multiformi sono i gruppi nei quali, per funzioni civili e cerimonie religiose, per passatempi ordinarî e scene occasionali, per divertimenti continui e giuochi periodici, essa potrebbe scompartirsi e classificarsi.
Nei brevi cenni che la economia del lavoro ci consente, in questo e nel seguente capitolo il lettore potrà conoscere le principali feste delle varie specie.
Procediamo con ordine.
La impresa di Carlo V, che tolse al dominio turco le isole di Malta e del Gozzo e Tripoli, segna un fatto importante nella storia di Sicilia. Per compensare i Cavalieri di S. Giovanni della perdita dell'isola di Rodi, passata, dopo lunghissimo possesso, a Solimano imperatore, Carlo concedette loro Malta e Gozzo (1530). Per ciò dovevano i Cavalieri attestare la loro gratitudine e rinnovar la conferma della loro soggezione al Monarca di Sicilia con un formale tributo al suo rappresentante in Palermo.
Eseguita con un cerimoniale tutto proprio, questa funzione dal 1º novembre venne portata al 1º gennaio e verso la fine del secolo, per omaggio a Ferdinando, al 12, compleanno di lui.
In che consistesse il tributo, è presto detto: nella presentazione di un falcone per mano del Gran Maestro della Religione di Malta. Egli, partendo da quell'isola, veniva ossequiosamente a compiere nella Cappella del R. Palazzo l'atto, non pur di devozione, ma anche di vassallaggio. E poichè in Palermo era il Balio e Ricevitore di Malta, così sovente la funzione veniva da esso compiuta in forma di ambasceria: e per lungo tempo Gioacchino Requesenz dei Principi di Pantelleria rappresentò l'Ordine in faccia al Caramanico Vicerè ed al Lopez Presidente del Regno.
La straordinaria solennità della ricorrenza era fatta più clamorosa dall'assordante sparo dei cannoni del forte di Castellammare; ma nel 1779 questo era già, per economia, abolito: ed il Ministro di Napoli per la Sicilia, autore della riforma, l'aveva così motivata: «Dovranno parlar meglio siffatte lingue di fuoco nelle occasioni di far portare rispetto e far temere la maestà del Principe»1: ragione più cortigiana che coraggiosa: e certo antipatriottica, come quella che volea far temere il Re a furia di cannonate!
In tal modo si apriva il ciclo delle feste sacre e profane dell'anno.
Tra le ridde della tubiana e le ebbrezze dei ridotti, tra lo scompiglio dei carri e le misurate movenze del Mastro di campo, correva sbrigliato, frenetico, il Carnevale. Un paio di tamburini, qualche piffero, uno, due uomini che battevan le castagnette, raccoglievano intorno a loro una folla disordinata di maschere popolari: re, regine, caprai, pulcinelli, orsi, mastini, inglesi ubbriachi, dottori e baroni imparruccati, turchi neri come pece, vecchie armate di fusi e di conocchie. Al ripicchiar degli strumenti i sonatori eccitavano a balli paesani, a salti mortali, a corse sfrenate ed a smorfie e sdilinquimenti. Con un arnese formato da una serie di regoli a X mobili di legno una maschera faceva giungere fino ai secondi piani lumie e fiori ad amiche ed a parenti: era lu scalittaru. Un'altra offriva in un elegante cartoccio confetti e in una nastrata boccettina sorsate di liquore delizioso: era un azzimato spagnuolo. Altra maschera si affaticava a guadagnare i gradini d'una scaletta a piuoli, sostenuta da due compagni: e dopo mille contorcimenti e dinoccolature stramazzava goffamente per terra: era il pappiribella. Quest'accolta di maschere, guidata dalla infernale orchestra, era appunto la tubiana; la quale per lazzari, mammelucie, papere, ammucca-baddottuli, e d'ogni strana maniera travestimenti accrescevasi all'infinito.
Tutto un dramma comico svolgevasi alla Fieravecchia e in altre piazze: il Castello, parodia del Conte di Modica Bernardo Cabrera, che diede la scalata allo Steri (oggi Palazzo Tribunali in piazza Marina) per impadronirsi (gennaio 1412), vecchio libidinoso, della giovane e bella Regina Bianca di Navarra, vedova di Ferdinando: era il Mastro di campo2.
Mentre siffatti spettacoli animavano i quartieri dell'Albergaria e della Loggia, di Siracaldi e della Kalsa, sontuosi carri salivano e scendevano pel Cassaro e per la Strada Nuova, gremiti di altre maschere raffiguranti scene mitologiche, storiche od anche fantastiche. Il Trionfo d'amore, secondo Petrarca, meritò il plauso dell'unico giornale del tempo. Cosa non mai vista le carrozzate del Principe di Pietraperzia e del Principe di Paternò, del Principe di Gangi Valguarnera e del Marchese Spaccaforno Statella, del Duca di Caccamo Amato e del Duca di Sperlinga Oneto. Precedute da strumentisti a piedi e da soldati a cavallo, lanciavano alle aristocratiche spettatrici sui terrazzini (balconi) scatolette ed alberelli, ed a larghe mani sulla folla plaudente confetti gessati3. Appena principiato il secolo XIX, nel Martedì grasso del 1802, anche Ferdinando volle prender parte ad una di cotali carrozzate spargendo confetti di eccellente fattura, mentre gli altri che lo accompagnavano ne lanciavano finti4.
Altre maschere di altra levatura popolavano le case private con le eterne distinzioni di classi; chè, tra le nobili non erano ammesse le civili, e queste non avrebbero osato invitar quelle. Solo per eccezione il Principe di Paternò Moncada, che nella sua sconfinata grandezza aveva slanci fuori la propria cerchia, ammise alcune volte maschere del medio ceto nel suo palazzo; come la sua villa (quella che era intesa «Flora di Caltanissetta») non isdegnò di aprire, oltre che ad esso, al ceto dei plebei: il che ci fa ricordare del Vicerè Colonna di Stigliano, che migliaia di maschere d'ogni classe accolse nel Regio Palazzo e tutte volle servite da camerieri e da credenzieri vestiti da pulcinelli5.
Anche pel Carnevale il secolo si chiudeva in forma eccezionalmente sontuosa. Erano i Sovrani in Palermo, e la eccezionale sontuosità partiva appunto da loro.
La sera del 18 febbraio a nome del Re il Capitan Giustiziere Principe di Fitalia invitava la più alta Nobiltà della Capitale ad una festa da ballo al R. Palazzo. Nell'invito si permetteva «qualunque sorte di maschera di carattere, dominò, e bautta», sotto la quale sarebbe stato «lecito portare dei fiacchi», o giamberghe, aggiungeva uno di coloro che ricevettero la partecipazione.
La festa doveva principiare alle 2, ma potè esser popolata solo alle 4 dopo mezzanotte, tale fu la difficoltà degli invitati di farsi strada pel piano del Palazzo.
Che eleganza di maschere! Che splendore di costumi! Che varietà di figure, l'una più bella, più curiosa dell'altra! L'occhio si confonde nel seguirne le mosse e gli atteggiamenti solenni, irrequieti, civettuoli. Questa che fa da pacchiana di Ischia è la Contessa di Belforte, Isabella Paternò, moglie del Marchesino di Villabianca. Con che grazia regge ella il suo cestino di frutta... della Martorana!6 E con che profondo, dignitoso inchino ne presenta al Re!... E le son compagne altre pacchiane di Napoli: la Principessa di S. Giuseppe, Barlotta; la Principessa di Iaci, Reggio; la Principessa di Valdina, Papè; la Principessa di Sciara, Rosalia Notarbartolo. Altre, attempatelle, sono Costanza Pilo, terza moglie di Benedetto di Villabianca, ed Annetta Vanni, parente di lei.
Ecco i quattro Elementi della Natura: l'Aria è la Duchessa di Ciminna, Grifeo; l'Acqua, la Marchesa di S.a Croce, Celestre; la Terra, la Marchesa delle Favare, Ugo; il Fuoco, la Principessa di Castelforte, Mazza. Ma non procedono sole; tien loro compagnia Eolo, il cav. D. Antonio Chacon; Nettuno, il Marchese Salines Chacon; Titano, il marito della Celestre; Vulcano, il Principe di Cattolica, Giuseppe Bonanno; il Ciclope Sterope, D. Andrea Reggio, ed altri ed altri ancora. Con i quattro elementi della Natura sono anche le Quattro Stagioni dell'anno e tutte le deità dell'Olimpo pagano. Dove più fervon le danze piovono cartellini in onore quando di questa e quando di quella deità. Prendiamone uno: è in versi francesi in onore di una vaghissima mascherina di Cerere, che non si riesce a indovinare, ed alla quale tengon dietro un Sileno, un Pane e pastori e pastorelle che intonano note d'amore:
Cerés vient de quitter ses riants campagnes,Elle arrive au milieu de ses belles compagnes;La déesse des fleurs, et celle des jardins,Elle vient prendre part à ces brillantes Festins.Silène, ausi que Pan, et bergers et bergères,Ont délaissé leurs bois, leurs rustiques caumières:Tous chantent de concert, par un élans d'amour7.
A periodici ridotti carnevaleschi si aprivano sempre i teatri: e poche delle persone che il potessero vi mancavano. La varietà dei travestimenti non era da meno dello sfoggio degli abiti d'entrambi i sessi. I balli si succedevano ai balli, non turbati mai da poveri mortali, che con la origine modesta ne tentassero le sublimità inaccessibili.
Quei ridotti si ripetevano a brevi intervalli, e se ne contarono fino a una dozzina in una sola stagione. Molto prima del tramontare del secolo il costante buon successo di questi divertimenti persuase certo Cristoforo Di Maggio a costruire nel piano della Marina, rimpetto la Casa Calderone (una volta Castelluzzo, ora Fatta), una grande baracca di tavole solo per balli e spettacoli del tutto carnevaleschi. Era un teatro con ampia platea, con posto per due orchestre, ottantaquattro comodi palchi e logge in due ordini, parati con velluto cremisi, specchi e fiorami d'argento, a spese di ciascuno dei signori che s'erano impegnati per proprio conto. Vi si tennero da quindici tra veglioni e giuochi cavallereschi, ed una specie di circo equestre, con campeggiamenti di dame accorsevi fin dentro la platea con quattro carri tirati da mule bianche e assedî e assalti di torri tra cristiani e turchi. I forestieri «non poterono fare a meno di confessare che la veduta di tal ridotto fu sorprendente, a segno che in tutto il mondo non può darsi l'eguale». Lo afferma il Villabianca, che non uscì mai dalla Sicilia, e non abbiam modo di controllare i giudizî ch'egli raccolse dagli stranieri residenti allora a Palermo.
L'intervento di persone non titolate, consentito dalle Autorità e dalla natura dello spettacolo, allontanava qualche anno la vera e genuina Nobiltà; ma i veglioni si mantennero nel costante favore del pubblico, recando non lieve vantaggio alla cassa del Comune, che pur ne destinava gl'introiti alla Villa Giulia8. Il Santa Cecilia godè anche per questo speciale rinomanza, e non fu persona di riguardo che non ammirasse maschere e danze elette, non indegne della presenza di Vicerè e di grandi dignitarî. Ma così al Santa Cecilia come al Santa Caterina la sera del Martedì grasso era una gazzarra indiavolata di strumenti da scherno per l'accompagnamento tradizionale del canto e della recita degli artisti.
Secondo gli umori del Vicerè e le inclinazioni spenderecce o parsimoniose di Capitani Giustizieri abolito ripreso, il giuoco del toro trionfava nel classico piano della Marina, suscitando indimenticabili emozioni in tutta la cittadinanza9.
Più clamorosa ancora, anzi vero baccanale, l'impiccagione del Nannu nella Piazza Vigliena: giustizia sommaria del Carnevale, personificato in un vecchio stecchito, che si menava al supplizio col corteo di popolani camuffati da Bianchi: altra parodia delle esecuzioni criminali con finto corrotto e con nenie, che volevan ritrarre le reputatrici o prefiche10.
Scenate funebri simili, ma con particolari più strani, si perpetravano prima, a mezza Quaresima, nella Piazza di Ballarò segandosi il fantoccio di una megera mostruosa, fetida. Era l'immagine della magra, uggiosa, insopportabile Quaresima, tiranna impositrice di sacrifizi corporali, motteggiata in satire, indovinelli, giuochi di parole, e seguita, vedi contrasto! da una fioritura di devozioni e di spettacoli religiosi vuoi pubblici, vuoi privati11. Imperciocchè nella Settimana santa inacerbivasi nelle penitenze, e battuti e disciplinanti si flagellavano dentro le rispettive congreghe; e per quarantott'ore continue si digiunava in pane ed acqua, ed assistevasi alla processione dell'Addolorata tutta di servitori in abito da penitenti, a quella dei cocchieri padronali in parrucche e gallonati, all'altra della Soledad tutta di militari della guarnigione: e giudei in antiche armature, terrore e ribrezzo degli astanti, fiancheggiavano la veneranda effigie del Cristo morto.
E poichè la secolare costumanza non consentiva, come non consente, il passaggio delle carrozze per la città, «le dame della più alta aristocrazia, mescolate alle grisettes delle più umili classi, prendeansi lo spasso di correr le vie in grandi manti neri», come de Borch le vide, in portantine o a piedi, girando per le chiese e per le strade e visitando i così detti Sepolcri.
La Fiera dei crasti era sempre un lieto avvenimento pasquale, che dal piano di S. Erasmo con gran piacere del pubblico passava nel piano di S.a Oliva, lunghesso i muri del Firriato di Villafranca, ora compreso tra le due piazze Castelnuovo e Ruggiero Settimo,
Centinaia, migliaia i castrati che si sgozzavano per divozione gastronomica presso le urne d'acqua sotto la piramide commemorativa della Giostra (oggi imboccatura di via Paternostro, in via Villafranca). Bene avrebbe voluto qualche Senatore restituir queste fiere all'antico posto: e ne fece prova, anche alla Marina; ma nè la musica dei virtuosi, nè i giuochi d'antenna introdottivi ad allettamento dei cittadini, valsero a mantenervela12.
Altra Fiera, più composta e di genere diverso, nei primi di maggio allegrava la ricorrenza annuale di S.a Cristina, ex-patrona di Palermo.
Nel largo della Cattedrale, in forma d'anfiteatro, con il monumento di S.a Rosalia e, finchè non le tolse l'architetto Fuga, le fontane laterali nel mezzo, sorgevano durante alcuni giorni belle logge con botteghe di rinomati mercanti e con quella ricca lotteria di minuterie che prendeva nome di Beneficiata di S.a Cristina e portava al Comune, per via di coloro che ne assumevano l'impresa, guadagni cospicui. Gradevolmente favorito ne rendevano il movimento le principali signore, come a proprio ritrovo recantivisi in tutto lo sfoggio delle vesti all'uso di Parigi. Da ciò quell'eccellente uomo che fu Jean Houel, visitatore con esse, trasse compiacimento a scrivere: «La città nella quale le donne godono della maggior libertà, nella quale esse son le meglio circondate da artisti, da amatori, da gente industriosa, dev'esser quella del tatto più fine, del gusto meglio esercitato, delle idee più sicure. Benchè naturalissima, l'arte di piacere ha come qualsiasi altra arte i suoi principî e le sue leggi»13.
Accanto alla grande beneficiata per la haute era la piccola pel popolino; ove per attirar gente ad acquistar polizze abbandonavasi a mille smorfie il pestaceci, maschera coperta di sonaglini da capo a piedi.
Il Pretore vi esercitava autorità suprema di giustizia: e vi fece qualche volta prendere e mandare al carcere di sua giurisdizione ladruncoli e perturbatori dell'ordine pubblico, quantunque non riuscisse mai a scoprire gli autori d'un grosso furto nel 179314.
Ora che cosa è rimasto di quella Fiera?
Nient'altro che il mercato degli animali ovini, bovini ed equini nel gran piano dei Porrazzi. S.a Rosalia andò a poco a poco soppiantando S.a Cristina e tutte le sante patrone della Città, confinandole con commemorazioni a sistema ridotto nella Cattedrale.
Qui non è inopportuna una breve corsa attraverso l'immenso campo delle pratiche tradizionali dell'anno; e lo faremo rapidamente, guardando appena poche particolarità di costumi, al presente non del tutto scomparsi.
Come in tutta la Sicilia così anche in Palermo dalla mezzanotte alle prime ore del giorno della Ascensione era un vociare confuso di pastori, un rumoreggiare assordante di campanacci, un belare di pecore, un mugghiare di vacche. Capre, buoi, interi armenti dalle montagne si menavano (e l'uso è sempre vivo oggidì) alla marina pel lavacro che dovea renderli immuni da mali durante l'anno: e capre e vacche, condotte in giro per la città, andavano ornate di fettucce e di fazzoletti di seta e le corna fiorate; ed i vaccai vestiti dei loro abiti migliori e i pifferai li accompagnavano lietamente.
La bizzarra costumanza15 richiama quella della benedizione degli animali da tiro e da sella, carichi di nastri e di campanelli, nella chiesa di S. Antonio Abate.
Tra pratiche superstiziose passava il giorno di S. Giovanni Battista (24 giugno); tra ghiottonerie culinarie di pescatori quello di S. Pietro (29 giugno), chiuso con allegre cene a base di frutti di mare sulla spiaggia ed in barchette per gli abitanti nel quartiere della Loggia. Tra burle ed innocenti furti di bambini e di oggetti di vestiari o di ornamento, che si andavano a mettere in pegno e che poi gli interessati disimpegnavano, era consumato il giorno di S. Pietro in Vincoli: onde il motto che raccomandava di evitare liti il 1º di agosto.
'Ntra festi e FerragustuNun cci jiri si si' 'n disgustu
In baccanali simili a quelli dell'antica Calata di Baida nello scomparso medio evo, trascorrevano le quaranta ore nella grotta di S.a Rosalia (4 sett.), pretesto a chiassate di quanti fossero spensierati popolani, ed alle solite pompe del Senato, il quale vi si recava in portantina e vi veniva solennemente ricevuto dalla Collegiata dei canonici istituita dal Marchese Regalmici, che anche a S.a Rosalia volse le sue cure.
Di gradita consuetudine era una gita della Nobiltà, nella più sontuosa mise en scène, a Monreale per la vigilia della nascita di Maria: consuetudine la quale (facile cosa è il supporlo conoscendosi l'indole del nostro popolo) riusciva sommamente chiassosa per l'accorrervi della città tutta; come per la immediata ricorrenza della Esaltazione della Croce, della quale diremo alla fine del presente capitolo.
Quello spensierato dei re, o quel re degli spensierati che fu Ferdinando III, l'8 settembre del 1801 ebbe gran piacere di recarsi anche lui nella storica cittadina. Discesone, volle da una villa, forse quella di S.a Croce, già Velluti, godere sul Corso di Mezzo Monreale «il passaggio del pubblico, i bei tiri di cavalli e le corse dei barberi»16. Chi più contento di lui allora, dopo la recente nascita del futuro erede del trono, il figlio di Francesco I?17.
Una delle tre nobili compagnie, quella della Carità, soleva ogni anno, pel giorno sacro a S. Bartolomeo, apostolo, tenere una processione per compiere un atto di beneficenza. Vestiti del loro sacco, a due a due, quei confrati portavano ceste piene di camicie e di filacicche all'Ospedale grande e nuovo. Quivi giunti, toglievano a ciascun infermo la propria camicia, gli indossavano la nuova e gli donavano delle filacicche per le piaghe.
Il pietoso costume ci fa pensare al difetto che i poveri ammalati di chirurgia pativano di mezzi di medicatura18: e dovette essere tanto celebre da far nascere altro costume del ciclo nuziale, ora del tutto dimenticato come questo della processione. Le ragazze del popolo promesse spose, nel medesimo giorno di S. Bartolomeo, regalavano ai loro dami una piccolissima camicia ed una manata di filacicche. «Oh che volessero intendere, chiede scherzando un letterato, che dall'amore all'ospedale non è molta la distanza?»19 O non piuttosto, chiediamo noi, che si dovesse pensare operosamente agli infelici?
Senza confronti, come funzione religiosa, era la processione del Corpus Domini ai primi di giugno. Celebravasi di mattina, e si bruciava dal sole; un rescritto del Caracciolo la volle nelle ore pomeridiane (1782), e così fu fatto. Quanti soldati erano in Palermo, tutti in ordine di parata, stavano sotto le armi lungo le vie che il Divinissimo dovea percorrere. Dalla chiesa della Magione, dell'Ordine teutonico, alla Cattedrale, la soldatesca in doppia fila teneva in riga dietro di sè la folla nella via Porta di Termini, alla Fieravecchia, ai Cintorinai, alla Loggia, alla Bocceria, nel Cassaro, nella Strada Nuova. La cavalleria concorreva al buon ufficio di custodia, di ordine e di omaggio: ed avea appoggio nelle compagnie dei dragoni e dei granatieri. Il Generale, splendente di galloni e di armi, comandava tutti. Ov'era un balcone od una finestra, lì pendeva un arazzo, un drappo, un tappeto, un ornamento qualsiasi, e dietro o sopra erano donne ed uomini, attratti al consueto, immenso spettacolo, erano devoti o curiosi inginocchiati allo appressarsi dell'Ostia santa portata dal maggior dignitario del Duomo. La grande solennità esigeva l'intervento delle Autorità politiche e civili, e quindi della magistratura ufficiale. S. E. il Vicerè col Sacro Consiglio, il Senato con gli ufficiali nobili e la truppa pretoria, erano l'ammirazione di tutti; e di viva curiosità cittadina l'Eccellentissimo Pretore col suo giudice a latere e col suo ambito bastone di comando; giacchè in questo giorno, come in quello della Fiera di S.a Cristina, egli rappresentava l'alto grado di Capitan d'armi, Vicario Generale viceregio. Figurarsi quindi l'interesse del pubblico nel vederlo dalle truppe salutato con gli onori di Maresciallo di campo! E, come militare e sacra era la festa, così due ultime scene, militare l'una, sacra l'altra, la coronavano: erano queste, nel piano del Palazzo, l'assembramento di tutti i corpi dell'esercito compiuto a marcia forzata lungo le vie, fino a comporsi a mezza luna in parata di battaglia, e nella Cattedrale provvisoria (a Casa Professa) la benedizione del popolo20.
La festa dell'Assunta non era più quella d'una volta; pure serbava avanzi stupendi, che la rendevano una delle principali del calendario cittadino.
Il Marchese Caracciolo diede, come abbiam veduto, un colpo mortale alle Maestranze, che ne formavano la parte attiva: quindi dal 1783 in poi, ridotto il loro numero, ridotti si vedevano anche i loro cilii21.
Erano questi delle macchinette, rappresentanti scene della vita di santi, opere talvolta fini d'arte, portate a spalle da socî delle singole corporazioni; e prendevano il nome di cilii, dai colossali ceri che non solo esse ma anche le corporazioni maggiori dei farmacisti, dei medici, dei forensi, oltrechè il Clero ed il Senato, offerivano alla Madonna. La processione già di sera, fu imposta di giorno, ed anche per ciò perdette della sua gaiezza primitiva.
Lasciando le cerimonie che la ricorrenza avea di comune con altre dell'anno, non è da trascurarne una che rimase nelle costumanze pubbliche ed ufficiali: vogliam dire la visita alle carceri pubbliche della Vicaria. Per lungo volger di anni, anzi per secoli, la fece il Vicerè in gala, con cavalcata della Nobiltà e del corpo del Ministero e del Sacro Consiglio, in carrozze parate di fiocchi e in pompa tutta sovrana. Giunto alle prigioni, liberava carcerati, rimetteva, riduceva condanne, pagava anche per integrum debiti, faceva, insomma, tutto il bene che il cuore in armonia con le esigenze dello Stato gli consentissero. Ma appunto perchè ci andava spesso di mezzo la tasca, i Vicerè non erano sempre teneri di questa funzione: sicchè prendeva il loro posto il Capitan di Giustizia col Presidente della Gran Corte, e i rispettivi giudici e ministri fiscali delle loro corti, insieme con gli algozini armati di verghe e gli alabardieri di lance. Certo non era tutto: ma qualche cosa era, che nelle cause civili confortava di libertà molti infelici, graziati per virtù degli alti funzionarî.
Altro spettacolo le regate, che partivano dalla Arenella e giungevano alla Cala: lunghissimo tratto di mare che dava la misura delle forze fisiche e dell'agilità dei pescatori.
V'erano pure le corse dei cavalli, ripetizione di quelle di S.a Rosalia, per le quali il concorso della gente soperchiava qualunque spazio; v'erano cuccagne di mare e di terra per gare di giovani nel salire antenne verticalmente piantate, o nel percorrerne altre sporgenti sulla spiaggia, entrambe sparse di materia che le rendeva sdrucciolevoli. E v'erano altresì corse di fanciulli a piede libero, e corse di giovani insaccati o impastoiati, prove che suscitavano l'ilarità, ma che riuscivano talvolta pericolose.
In un pensiero, in un affetto si confondevano i cittadini tutti per la solennità della Immacolata.
Il 27 luglio del 1624, sotto l'incubo d'una pestilenza, il Pretore Vincenzo Del Bosco, Principe della Cattolica, avea convocato il popolo e proposto che riconoscesse Maria, pura del peccato originale, liberatrice della Città. Il popolo acclamò fervoroso, ed il Senato si obbligò ad un'annuale festa, la quale poi, sulla fine del secolo, assunse speciale carattere per il così detto voto sanguinario, giuramento formale del Senato medesimo di sostenere, anche a costo del proprio sangue, la verginità della Madre di Dio.
Di questo voto molti si occuparono pro e contro fuori Sicilia, e non benevolmente il Muratori; ma il Senato ed il Clero anch'esso giurò, senza versare una goccia di sangue, per quanto lo sostenesse o lo facesse sostenere a furia d'inchiostro, e rinnovava ogni anno, con costante fervore, la promessa.
Dopo un mese di pratiche divote, la sera del 7 dicembre, dentro le sue famose carrozze, circondato da paggi e da valletti con fiaccole accese, seguito dalle sue guardie, il Corpo senatorio si recava alla Chiesa di S. Francesco dei Chiodari, cioè di Assisi. La costumanza delle fiaccole, cominciata per necessità del tempo in cui la notturna illuminazione mancava, rimase come manifestazione di giubilo anche dopo gli eleganti fanali collocati nelle principali vie, e si associò a quella dei mazzuna, che anche noi abbiamo veduti fino a una trentina d'anni fa. Eran questi delle fascine di saracchio così colossali che a reggerne una ci volevano parecchi uomini: e tra le acclamazioni festose della folla si riducevano avanti la chiesa, vi stesse o no dentro la Rappresentanza della città. Allegri suoni di pifferi e di cornamuse, preludenti al prossimo Natale, e lancio di razzi, e sparo di moschetti riempivan di gioia i quartieri man mano che dai Cintorinai si riuscisse nel Cassaro e da questo, a destra ed a sinistra, s'imboccassero le vie più popolose.
La funzione del Vespro cantato era occasione alla tradizionale offerta delle cent'onze da parte del Magistrato civico. Sopra splendido vassoio il Pretore, salito sui gradini dell'altare, vuotava un sacco pieno di grosse monete d'argento, le quali rumorosamente cadendo suscitavano nei presenti un senso ineffabile di soddisfazione e di... desiderio: erano dugencinquanta scudi sonanti con le effigi di Carlo III e di Ferdinando IV, destinati al culto della chiesa.
Straordinariamente drammatico, al domani, lo spettacolo. I Gesuiti una volta, finchè ci furono, gli ecclesiastici, i chierici, gli scolari poi, quando i Gesuiti non c'erano più (1768-1805), processionando con granate in mano, venivano spazzando il Cassaro che la Madonna dovea percorrere.
Nella chiesa, con un cerimoniale che sarebbe stato delitto di leso privilegio il trascurare e che tutto studiavansi di osservare scrupolosamente, si passava al voto. Primo il Vicerè, genuflesso a piè dell'altare, confermava il giuramento; poi il Pretore ed il Senato: e l'uno dopo l'altro soscrivevano la formula del compiuto giuramento.
Assiso con regale dignità sopra un soglio, di fronte al Senato, il Vicerè medesimo teneva Cappello reale: assisteva alla messa e coprivasi il capo nel momento che riceveva l'incenso: prerogativa del Legato apostolico in Sicilia rappresentato dal Re, e pel Re da lui. Quella messa, in virtù di un breve pontificio, che faceva parte dei privilegi della ricorrenza, poteva celebrarsi fuori le ore canoniche.
E la processione si apriva coi soliti tamburi e si formava con le solite confraternite, con le solite corporazioni religiose, coi soliti corpi dei parroci, dei seminaristi dell'Arcivescovato, del Clero della Cattedrale: e, sul ferculo, l'artistico, prezioso simulacro d'argento della Madonna, coperto di gioielli, scintillante all'irreqieto tremolio delle fiammelle, lento nel muoversi, misurato nel fermarsi, raccoglieva la venerazione di centomila teste piegantisi riverenti, poichè ad inginocchiarsi ogni spazio mancava.
Maestoso anche qui il Vicerè, che, coi grandi dignitarî dello Stato, alla sacra immagine teneva dietro; maestoso col suo invidiabile toson d'oro, il Pretore, circondato dai Senatori, ed il Giustiziere con la sua Corte capitaniale, ed i magistrati, ed i nobili e quanti avessero carattere ufficiale. Mazzieri e servitori in livree sontuose, guardie pretoriane in vivide uniformi, soldati dagli alti berretti, dalle corte giacchettine, dalle larghe strisce di cuoio incrociantisi loro sul petto, dai grossi archibugi, completavano l'accompagnamento, civile e religioso insieme, come quello del Corpus Domini22.
Ma la festa non finiva qui. Per otto sere e notti consecutive i devoti, uomini e donne, in peduli od anche, secondo il voto fatto, a piedi ignudi, dalla chiesa della Madonna si recavano alla metropolitana recitando di continuo orazioni e rosari. Questa pratica chiamavasi viaggio: e, quantunque compiuta dai singoli fedeli col maggior raccoglimento, pure riusciva delle più gradite per tutti. Il Cassaro rosseggiava di mazzuna e di torce a vento; i pifferai coprivano col loro suono il mormorio indistinto dei recitanti le preci. Avvolti nei tradizionali mantelli o nelle grandi fasce di lana, i venditori ambulanti gridavano: Mmiscu, petrafènnula e zammù!... Zammùu!... liquori e dolci del mese di Natale, che mettevano a prova le più forti dentature e le digestioni più vigorose23.
Torniamo ora un poco indietro nel calendario per sorprendere la maggior solennità dell'anno palermitano, vogliam dire il Festino di S.a Rosalia.
Descrivere quella festività, è un far cosa superflua come il «raccontare i cinque giorni del Festino» secondo il notissimo adagio siciliano per esso nato.
Chi non la conosce? Chi, pur non conoscendola per tradizione, non ne ha letto delle descrizioni di viaggiatori che la videro o ne sentirono a parlare? Brydone, il 21 maggio 1770, scriveva da Messina esser considerata a Palermo «lo spettacolo più bello d'Europa»; e quando la vide, ne scrisse con la massima accuratezza24. Houel nel 1776 ne diede le particolarità più minute ricordando che «per questa solennità si accorre a Palermo da ogni parte della Sicilia, del Regno di Napoli ed anche dell'Europa», e che «per lo meno la maggior parte dei forestieri che sono in Italia non lasciano di passare lo Stretto per godersela25. L'ab. de Saint-Non ne riportò, per mezzo dei suoi artisti, disegni fedelissimi, degni «dell'entusiasmo devoto, unico anzichè raro che egli trovò nel luglio del 178526; e Goethe, recatosi a visitare la madre e la sorella di Cagliostro nel quartiere dell'Albergaria, ebbe da esse raccomandato di tornare nei «giorni maravigliosi delle feste, non essendo possibile veder cosa più bella al mondo»27.
Lasciamo dunque gli spettacoli che le resero famose. Noi non ci fermeremo neanche a prendere una polizza d'un baiocco della Beneficiata che le precede e le segue. Noi non vedremo il carro trionfale salire dalla Marina a Porta Nuova, brillante ai raggi dall'ardente sole di luglio, e scendere da Porta Nuova alla Marina illuminato da mille torce sotto il cielo di quelle incantevoli sere. Noi non assisteremo alle emozionanti corse dei cavalli nel Cassaro, alla solenne Cappella reale nel Duomo, alla lunga processione delle cento confraternite, delle cento bare e cilii, degli ordini religiosi, e dell'urna con le reliquie della Patrona della Capitale. Lasciamola, quest'urna, a percorrere un anno l'una, un anno l'altra metà di Palermo; lasciamo che i monasteri aprano i loro parlatorî maggiori al Senato, o lo trattino di lauti rinfreschi e di dolci squisitissimi; che il Pretore dia nel Palazzo senatorio il consueto ricevimento, ed il Vicerè nel Palazzo reale e l'Arcivescovo nell'arcivescovile diano il loro. Il Principe Conte di S. Marco, il Duca di Cannizzaro, il Principe di Trabia, Pretori dei varî anni che si occupano, sanno bene come vadano trattati i nobili loro pari. Caramanico, da uomo di governo e di lettere, sa armonizzare la dignità di Vicerè con la squisitezza del cittadino colto, e Monsignor Sanseverino non dimentica che il primo prelato dell'Isola dev'essere anche perfetto cavaliere non pur coi cavalieri, ma anche con le dame recantisi nella sua residenza a godervi lo spettacolo del carro e del palio. Se per tre anni il suo successore, più fortunato di lui, e come Arcivescovo e come Presidente del Regno e Capitan generale delle armi, riceve tutt'altro che signorilmente, lasciamolo al giudizio severo che ne porta la città, la diocesi, il Regno, questo Don Filippo Lopez!
Ciò che delle feste è poco noto si riduce a certe particolarità, minime, se si vuole, ma piccanti.
E, per esempio, il Caracciolo non potè mai persuadersi che per festeggiare S.a Rosalia si dovessero impiegare cinque giorni; e se ne arrabbiava sempre, e all'appressarsi di luglio più che mai. Una volta, non potendola mandar giù, decretò che i cinque giorni si riducessero a tre. Fu una scintilla scoccata sulla polveriera: la polvere, asciutta da un pezzo, scoppiò; Senato e cittadinanza conturbati, protestarono gridando, ed uno dei tanti cartelli attaccati per le strade minacciava: o festa o testa! ma il Caracciolo rimase impassibile. Riuscito vano ogni tentativo, il Senato mandò al Re in Napoli un memoriale del Segretario del magistrato della città D. Emanuele La Placa, un vero prodigio di erudizione patria municipale. Le feste, diceva il memoriale, si son sempre fatte per cinque giorni; esse rispondono al sentimento religioso della città; danno lavoro agli artisti ed agli artigiani, guadagno ai commercianti, lustro alla Capitale, allietata da numero considerevole di regnicoli e di forestieri; errore il ridurle; necessario, invece, il mantenerle come pel passato.
Frattanto la trepidazione dei Palermitani cresceva ogni giorno più. Caracciolo, benchè sicuro del fatto suo, non senza inquietudine aspettava le sovrane risoluzioni: e col suo indispensabile occhialino, da uno dei grandi balconi del palazzo non si stancava di lanciare sguardi di fuoco sui passanti nella Piazza, napolitanescamente mormorando parole di sprezzo contro questi incoscienti del progresso filosofico d'oltralpe, indegni de' tempi.
Quando il suo decreto venne tacitamente abrogato, fu visto mordersi le labbra e giurare di farla costar cara al Pretore, ai Senatori, ai nobili, al Clero, ai commercianti, a tutte le classi di Palermo non risparmiando neppure Sua Maestà.
Se non che, il tempo di costruire il carro non c'era più, ed egli si veniva fregando le mani pensando che non se ne sarebbe fatto di nulla.
Vano pensiero! La festa si volle e si fece: si centuplicarono le braccia, si lavorò di giorno e di notte e nelle prime ore pomeridiane dell'11 luglio il carro saliva glorioso; e più glorioso ancora tornava la sera del 14 a Porta Felice; e giammai grida di popolo festante echeggiarono più alte, e l'autorità venne più arditamente bravata.
Il lato comico delle feste patronali fu sempre il corteo de' Contestabili del Senato. I tamburini battevano un colpo a destra, un colpo a sinistra sui due tamburi che essi portavano a cavallo; e la loro battuta, comicamente nota, suscitava ilarità e motteggi. Siffatti Contestabili, dai cappelli a tegoli e dai lunghi ed ampî mantelli abbandonati sul dorso dei ronzinanti, erano lo zimbello del monellume, che avrebbe creduto di non passare allegramente lo spettacolo senza tirarsi dietro con le redini gli sbonzolati quadrupedi.
Muli perquisiti per la città e le campagne tiravano la macchina gigantesca, ed alla loro bolsaggine ed allo scarso loro numero s'attribuivano sovente gl'insuccessi dell'andare e del ritornare di essa. Non fu mai mistero per nessuno che gl'impresarî del trasporto per guadagnare di più sulla somma convenuta ad hoc, accettassero qualunque mulo anche avariato, e ne impiegassero meno del necessario. Nel 1791 il Barone D. Giuseppe Malvica e varî ortolani imploravano da S. E. che non volesse obbligarli a prestare i loro animali per questo faticoso servizio28.
O per eccessiva sproporzione dello scafo, o pel pessimo lastricato del Cassaro, mal rispondevano i poveri animali alla solenne cerimonia. La macchina, sorpassante dalla cima le più alte terrazze della via, ora trasportava con sè una ringhiera, ora urtava contro il muro di un palazzo, ed ora sprofondava dall'un dei lati del mal basolato Corso. I ricordi di ruote sconquassate od uscite fuori dell'asse, di fermate d'interi giorni, abilmente poi superate per immani sforzi d'esperti marinai, son sempre vivi29.
Presso il Carro in movimento era un pandemonio: facchini che non lasciavano un minuto di vuotare buglioli d'acqua sugli affusti delle ruote in pericolo di prender fuoco per l'intenso attrito; giovinastri schiamazzanti alle manovre d'innaffiamento ond'essi rimanevano bagnati fradici; alabardieri che con le culatte dei loro scopettoni scacciavano la ragazzaglia audace e molesta; musicanti che sonavano e perdifiato; fiori pioventi dai balconi, dalle finestre, dai tetti, e battimani scroscianti ed evviva prolungate fino ad assordare.
Non men chiassose, nè men pericolose le corse, attrattiva magica, affascinante pel popolo specialmente delle campagne e dei comuni. Per quante precauzioni si prendessero ad evitar disgrazie, queste non mancavano mai. Lungo le catene del Cassaro, a destra ed a sinistra, per molto spazio, addossati a palazzi ed a botteghe sorgevano palchi per chi volesse sottrarsi agli urtoni della folla. Ai Quattro Canti, dal Palazzo Costantini al palazzo Jurato (Rudini), dal palazzo Guggino (Bordonaro) a S. Giuseppe dei Teatini, altri palchi ostruivano i due sbocchi della via Macqueda. A Porta Nuova i palchi si moltiplicavano sotto il bastione che è ora il quartiere de' Carabinieri, e la gente pullulava, formicolava sopra e di fronte a questo, in alto, sotto i portici, sulla terrazza, fin sopra il cupolino della Porta, dove bandiere ed orifiamme sventolavano.
Nella interminabile, ma non continua processione dell'ultima sera, la curiosità veniva stuzzicata dalla corsa dei pescatori della Kalsa e dallo intervento dei caprai: ragione, questo, di burle, che con allusioni menelaiche, suscitate dal ricordo di bestie cornute, punzecchiavano la congrega, mal sofferente gli amari motti. Laonde il Pretore, per evitare disordini, dovette proibire che la confratria partecipasse alla festa; e così la statua del protettore San Pasquale fu alcuna volta messa da canto30.
Descrivendo la pericolosa corsa dei pescatori, Houel, che la vide, raccontava:
«Ciò che fissa di più gli sguardi del forestiere è la coppia sacra dei Santi Cosimo e Damiano, entrambi al naturale, entrambi dorati da capo a piedi, l'uno a lato dell'altro... Sono piantati su di una specie di barella a quattro aste in croce, sotto ciascuna delle quali stanno otto persone. Se non che, i trentadue uomini non portano le due statue d'un passo grave e maestoso, ma corrono a tutta lena gettando grida spaventevoli. Una grossa e lunga fune legata alla macchina, è tenuta da quante persone possono, poichè con la prestezza che corrono, se per poco si urtassero, la macchina rovescerebbero. Giunti in mezzo al Cassaro, con una celerità incredibile staccano la fune e fanno girare la macchina fino a restare sudati e trafelati. Per sostenerli in questo pio esercizio e rinfrescarli, un numero straordinario di ragazze e di donne li accompagnano, girano con essi e, agitando in aria i bordi dei grembiuli, soffiano a perdibraccia sui loro visi. Il giro cessa quando i portatori sono del tutto spossati, e mentre girano, tutti lanciano per aria berretti, cappelli e pezzuole e saltano attorno ad essi e gridano a più non posso: Viva i Santi Cosimo e Damiano! senza pensare che questi santi son morti da più secoli. Dopo un po' di sosta, riprendono i Santi, vi riattaccano la fune e si rimettono a correre come inseguiti»31.
Tronchiamo senz'altro la rassegna ed usciamo un poco dalla città.
La celebre festa monrealese di maggio avea di tanto in tanto un'appendice non meno celebre, nella prima quindicina di settembre, per la Esaltazione della S. Croce: era la Dimostranza.
Che cosa fosse una dimostranza, nessuno vocabolario siciliano o italiano lo dice; ma nell'uso comune risponde ad una processione figurata, una sacra, simbolica rappresentazione muta. Essa percorreva le vie e le piazze principali d'una città o d'un comunello, fermandosi tutta o parte in dati posti a riprodurre con atti e gesti un fatto biblico o qualche episodio della vita di Gesù, e particolarmente la crocifissione; le vicende più drammatiche, più commoventi, d'un martire, d'un confessore, d'un santo, d'una santa patrona qualsiasi. Lo componevano centinaia di persone, attori da strapazzo, presi dalle più modeste classi del popolo, e soprattutto dai maestri e dai contadini, precedentemente addestrati da qualche ecclesiastico. Costui era insieme autore del dramma mimico da rappresentarsi, direttore della effimera compagnia, maestro e censore di tutte quelle teste, spesso tutt'altro che buone a dimostrare. Vestiva ciascuno il costume del personaggio che dovea raffigurare, altri da imperatore o da re, altri da sacerdote o da levita, altri da apostolo, da martire, da vergine; questi da centurione o da soldato, quegli da littore o da carnefice, con costumi quando splendidi e quando ordinarî, ma tutti a fogge antiche diverse da quelle d'oggidì. Procedevano a due, a quattro, alla spicciolata, a gruppi, fermandosi in luoghi designati a riprodurre scene del tale e tal'altro avvenimento sia della Scrittura, sia del Martirologio, sia, in generale, del Leggendario dei Santi. Nessuno parlava, e da qui la qualificazione di muta, ed anche di ideale (il popolo con un qui pro quo, che risponde alla grandezza e magnificenza della messa in iscena, pronunzia reale) applicata alla processione; dove però alcuni personaggi portavano scritti a lettere cubitali su cartelli, dei motti, titoli, nomi che servivano a chiarire chi fossero e che cosa volessero significare.
Una di queste ricorrenze si ebbe nel settembre del 1783: ne sappiamo qualche cosa perchè vi si recò un signore lombardo oramai noto ai nostri lettori, il Rezzonico, giunto allora per visitare la Sicilia. Sentiamo la sua relazione.
«La prima volta (10 sett.) vi andai solo, e la seconda (15) in compagnia della Principessa di Belvedere e dell'amabile sua figlia donna Giovannina [questa donna Giovannina è la Giovannella, la quale, uscita di recente da un monastero, si disponeva ad andare sposa al Principe di Paternò, Giovanni Luigi Moncada, e dovea poi far parlare tanto di sè nei circoli nobiliari palermitani], e della Duchessa di Montalto. Pranzammo in buona compagnia di circa 24 fra dame e cavalieri, nel palazzo del pubblico; ma il caldo era eccessivo. La gente accorsavi da Palermo era infinita e fu bellissimo spettacolo il vederla ire e tornare in la gran folla ed occupare tutte le vie e le rivolte sul monte, e formare vari gruppi intorno alle pubbliche fontane che ad ogni passo s'incontrano32. Chi a piè, chi a cavallo, chi sulle carrette, chi dentro le lettighe accorreva da ogni banda e sprezzava i caldissimi raggi del sole e l'incomodo polverio da tanti piedi d'uomini e di animali eccitato. Le carrozze poi, le mute, i birocci, e le canestre s'affoltavano d'ogni intorno e discendevano in lunghissime file che dalle porte di Palermo a quella di Monreale non erano discontinuate; laonde conveniva aspettarne lo sviluppo pazientemente»33.
La dimostranza, tutta popolare, concepita ed eseguita, come altre simili, per edificazione e svago della folla, non ebbe il plauso dell'illustre gentiluomo: e non poteva averlo, vivendo egli in mezzo a nobili e signori, e con principî severamente classici. Così il Rezzonico si lasciò andare a malinconiche riflessioni «sul bello dell'arte imitatrice e degli spettacoli, la cui perfezione indica più d'ogni altra cosa la cultura dello spirito e del cuore negli uomini assembrati».
Non importa però: lo spettacolo piacque a tutti, e tanto basta.
Dai punti principali del Vecchio Testamento, riferentisi alle tristi condizioni della Umanità pel peccato di Adamo, si passava a quelli del Nuovo, che mano mano conducevano alla Redenzione per opera del Dio-Uomo, venuto sulla terra a scontare la colpa del mondo. Il distacco tra gli uni e gli altri era notevole, e dove tra i primi, patriarchi e profeti si alternavano con le immagini dei fenomeni tellurici e meteorologici e delle entità astratte, tra i secondi la Passione coronava in forma tragica l'opera. Il simbolismo prevaleva «con molte prosopopee bizzarre come il Tremuoto, che gonfiando le guance e tirando gran calci e vibrando qua e là le braccia argomentavasi di figurare le desolazioni e i danni che reca ad incutere altrui spavento. La morte, la peste, l'idolatria, il peccato, la guerra altresì v'erano personificate».
La crocifissione svolgevasi crudamente realistica, e alcune circostanze di essa dovettero concorrere alla sgradita impressione ricevutane dal dotto visitatore.
Di più facile contentatura, Ferdinando III si divertì moltissimo della processione figurata del 4 maggio 1801, ripetuta nella medesima Monreale34.
CAP. II.
SPETTACOLI E PASSATEMPI.
Le notizie della stupefacente ascensione dei fratelli Montgolfier col loro pallone aerostatico giunsero in Palermo per mezzo delle gazzette: e fu un gran discorrerne per tutta la città.
Un libro francese stampato a Losanna venne ad accrescere lo stupore non solo con le particolarità maravigliose che accompagnarono la riuscita dei varî preparativi dell'avvenimento, ma anche coi disegni che parvero fatti a posta per fomentare l'ansiosa curiosità dei Palermitani35.
«Le piazze, le conversazioni, i caffè risonavano globi volanti, navigazioni celesti, aerei viaggiatori Tutti volevano riprodotto lo spettacolo, e non fu persona che non s'interessasse di quegli esperimenti, creduti utili alla riuscita della non mai tentata impresa. Non è già che si volesse come a Parigi vedere un uomo salire in aria; perchè nessuno si sarebbe arrischiato se pure l'avesse saputo fare, a riprodurre la macchina con la relativa cesta o navicella e con un essere in carne e in ossa a dirigerla. Insofferente tuttavia era la curiosità di veder andare in alto un gran globo secondo le indicazioni dei giornali francesi, ed instancabile l'agitarsi di dotti e di indotti per l'attuazione del descritto disegno.
Si chiamarono i più periti macchinisti del tempo, si misero a parte del poco e del molto che si sapeva del meccanismo dell'opera e si fecero quanti più tentativi si poterono. E poichè le relazioni parlavano di taffetà, di taffetà rimbombava ogni angolo del paese: «ed ecco il taffetevole pallone, il quale, messo a prova, arrossendo di poggiar alto e sceso umiliato al suolo, fece arrossirne ma non umiliarne gli autori. La gravezza del peso in quel globo, abbenchè di picciol diametro, impedì che si innalzasse nell'aria atmosferica». Le prove si ripeterono col sussidio della chimica e della dinamica quali erano allora conosciute; ma i risultati furon sempre nulli, ed il ridicolo cadeva a larghe mani sopra gl'inesperti attori.
Un signore di molto ingegno si fermò sulla inanità degli sforzi della scienza e della pratica del tempo; e andando più in là che non fossero andati i suoi concittadini, trovò modo di risolvere il problema del peso, della misura, della struttura del pallone in guisa da renderlo buono a sollevarsi da terra ed a prendere le vie aeree fino allora non tentate in Sicilia. Questo signore fu D. Ercole Michele Branciforti, Principe di Pietraperzia e futuro Principe di Butera: persona di grande perspicacia e di non comune disposizione alla fisica, dei cui segreti, del resto, era affatto ignaro. Egli lavorò indefessamente per la riuscita dei suoi disegni, e quando si credette sicuro di sè, invitò nel paterno palazzo Butera la Nobiltà siciliana di Palermo, e l'11 marzo del 1784 fece le prime fortunate prove, preludio a quelle stupende del 14. Spettatori i nobili più riputati e le autorità civili e militari, egli presentò il suo pallone, lo riempì di ossigeno, ne chiuse la bocca e quando gli parve buono ad affrontare la prova lo fece andar libero per mano del Vicerè. Il pallone si levò maestoso di mezzo all'ampia terrazza; e forte, solenne, non mai più sincero, fu lo scoppiettar di mani, l'applaudire degli astanti del palazzo, del popolo della Marina a così nuovo miracolo dello umano ingegno36.
Il Vicerè Caracciolo non potè nascondere la sua grande soddisfazione ed espresse il maggior compiacimento a D. Ercole; ma certamente vivo dovett'essere il suo rincrescimento di trovarsi ospite e lodatore di colui che, pochi mesi innanzi aveva, per una fisima, tenuto abusivamente in prigione: e quando si congedò per ritornare alla Reggia, tirò il più lungo dei sospiri come liberato da un incubo per la mortificazione di aver dovuto festeggiare l'uomo che avea per tredici mesi soperchiato.
I lettori ufficiali dell'Accademia degli studî (i professori della Università) riflettendo sopra gli splendidi risultati del Branciforti, e non sapendo rassegnarsi a passare in seconda linea di fronte ad una persona la quale, priva della cultura tecnica, era arrivata là dove i maggiori di loro non avean sognato, pensarono di affermarsi ripetendo per proprio conto lo spettacolo del patrizio palermitano. Il dì 21 dello stesso mese l'abate basiliano p. Eutichio Barone, insegnante di storia naturale e botanica nell'Accademia, volle mandar su un suo pallone dalla loggia della Casa degli studî (l'ex-Collegio dei Gesuiti); ma ahimè! l'esito non poteva essere più disastroso: ed appena il pallone si alzò dal fabbricato, andò a cadere a pochi passi, nel giardino del monastero della Badia Nuova, sì che il vanitoso maestro ne restò con il danno e le beffe37.
Da queste prove potè avere incremento, se non origine, l'uso dei palloni di carta velina che in estate si mandano in aria, specialmente in Palermo; il quale sospetto esprimiamo in forma dubitativa mancandoci documenti scritti di proibizioni di siffatti divertimenti al biondeggiar delle messi nella Conca d'oro: dove il cadere di palloni accesi avrebbe potuto recare gravissimi incendî. E certo è da supporre che prima di quello del Branciforti nessun globo consimile si fosse veduto in Sicilia, per quanto la cosa possa ora sembrare, qual'è, ovvia e la più naturale di questo mondo.
Alcuni anni dopo, nel 1790, Vincenzo Lunardi, ardito aerostata lucchese, dopo varie ascensioni, incominciate con quelle di Edimburgo e di Glasgow (1784), immediatamente dopo le famose dei Montgolfier (1783), pensionato da Ferdinando in Napoli e col grado di capitano onorario, venne a rinnovare i miracoli Montgolfieriani tra noi. La cittadinanza vi si apprestò come alla più grande festa della sua vita: e il dì 15 marzo la Villa Filippina, dentro e fuori, fu stivata di spettatori impazienti di una vista non mai da essi immaginata. Le terrazze, i balconi più alti delle case e dei palazzi, le logge dei monasteri, i campanili, le cupole delle chiese si videro occupate da persone d'ogni condizione, e da monache, da preti, da frati, da militari. Si parlava del Lunardi come di essere soprannaturale, e la leggenda particolareggiava di opere e di atti di lui e delle ragioni e dei mezzi delle sue aeree escursioni.
Aspetta, aspetta: l'ascensione non ebbe luogo. Il vento impetuoso non lo permise. Ma il popolo, stanco del lungo, penoso attendere, del digiuno e della sete nella Villa, nella campagna di S. Francesco di Paola, ne' dintorni del vecchio Cimitero, presso i baluardi, esplose in grida e minacce violente contro il Lunardi, bollandolo per giuntatore volgare, venuto in Palermo ad imbrogliare i cittadini. Il brav'uomo fu a un pelo di essere accoppato: e se sfuggì alla collera del pubblico, dovette andarne debitore al Vicerè ed alla Nobiltà, che lo protessero.
Ma il Lunardi non era un giuntatore: ben tredici volte avea tentato le vie de' cieli in tutta Europa: e teneva molto alla sua reputazione, perchè la smentisse nella Capitale della Sicilia.
Nei primi di luglio un avviso a stampa nelle Quattro Cantoniere e in varî posti del Cassaro e della Strada Nuova diceva che il capitano Lunardi avrebbe fatto la sua ascensione l'ultimo giorno del mese. Stavolta lo spettacolo sarebbe avvenuto a qualunque costo: dovesse andarci di mezzo anche la vita dell'attore.
Il 31 luglio tutta la città fu lì a S. Francesco di Paola: e chi non vi fu di persona, vi tenne sopra gli occhi tutta la giornata, da tutti i luoghi donde lo spettacolo fosse possibile.
Lunardi ascese col suo globo. Vicini e lontani sbalordirono, tremarono all'audacia di lui, il quale parve a chi un dio, a chi un demonio, sovrumano a tutti. Scomparso nello spazio, lo si rivide in capo ad alcune ore in trionfo per la città, lieto in mezzo al popolo tripudiante, acclamante; i nobili lo sovraccaricarono di doni, il Vicerè di danaro, le monache di dolci e di ghiottonerie. Onore supremo a quei tempi, il suo pallone venne disegnato; sparso per la città il suo ritratto, come quello di uno dei più grandi personaggi del tempo.
E come da quattro mesi correvan feroci le invettive in verso e in prosa contro il supposto inganno di lui, così da quel giorno cominciarono gli inni; e nacque subito e corse dappoi e si sente ancora dopo più d'un secolo una entusiastica canzone sulla mirabile impresa e sulle particolarità che la resero celebre. La canzone principiava così:
Nun si leggi 'ntra lunariaJiri un omu mai 'ntra l'aria;Liunardu sulu ha statuCa li nuvuli ha tuccatu;La sò forza a tantu arriva:Liunardu viva viva!Viva viva la sua virtù!Un omu di terra 'nta l'aria fu!
e ripeteva questi due versi intercalari, strofa per istrofa, fino all'ultima:
Stu prudigiu di munnuPri 'n eternu 'un tocca funnu;Liunardu lo sò nnomu;Resta sempri di grann'omu;Liunardu sulu ha statuCa li nuvuli ha tuccatu;La sò forza a tantu arriva.Liunardu viva viva!Viva viva la sua virtù!Un omu di terra 'nta l'aria fu!
La figura del Lunardi corse ammirata e ricercata per la città tutta: e venne ritratta nella mobilia e nei quadri.
Il 19 maggio del 1794 era in vendita nella bottega dell'orologiaio Giuseppe Mustica, dirimpetto il piano dei Bologni, dove ora è il palazzo Riso, «un oriuolo colla cassa di legno indorata, che ha la forma di un pallone volante e sostiene in una barchetta continuamente agitata Lunardi ed il suo compagno. Suona le ore, i quarti, il mezzogiorno, la mezzanotte, lo svegliarino, la ripetizione, mostra li giorni del mese, ha il sì e nò, e si carica pella parte del quadrante».
Così diceva il n. 7 del Giornale del Commercio.
Questo il più grande spettacolo fin de siècle. In faccia ad esso impallidirono i precedenti e quanti ne vennero in seguito. A che dunque dilungarsi in ricordi, anche interessanti, di altro genere?
Passiamo ad un divertimento ora del tutto dimenticato, e rifacciamoci dal 1770.
La mattina del 10 luglio di quell'anno Patrick Brydone scrivea da Palermo a Londra dover andare dopo colazione a giocare al pallone, al quale col suo compagno di viaggio Fullarton era stato invitato38.
In uno dei suoi opuscoli inediti il Villabianca diceva del giuoco: «Si fa in campo aperto, con un pallone di cuoio che batte e ribatte in aria, da più giocatori robusti, armati di guantone di legno al braccio destro, punteggiato (il guantone) dell'istesso legno per balestrare più in alto il pallone. Si fa da persone civili, e vi accorre gran popolo anche per vedere gente rispettabile a giocarlo. Si suole fare nella fossata di strada suburbana, che sta sotto il baluardo dello Spasimo, e appo il popolo rendere un virtuoso trattenimento di divertimenti estivi. Vi giocano per bizzarria parecchi nobili, sacerdoti e persone civili. Male a chi l'erra e per imperizia non ribatte il pallone e lo fa cadere in terra!»39.
Nello scorcio del settecento l'attrattiva divenne passione intensa: ed uno dei tanti che lo videro nel 1798 notava: «Si è quasi reso in furore il giuoco del pallone che si fa sotto il baluardo dello Spasimo con gran concorso di popolo e gente civile e nobiltà»40.
Pare vi sia stata una vera fioritura di giocatori, ma pare altresì che non tutti fossero i robusti dei quali parla il Villabianca; perchè, proprio in quell'anno, D. Francesco Carì componeva il seguente pepato sonetto:
— «Chi son costor che a piè d'un baluardoLe nerborute man menan con arte?Forse quel legno acuto arma è di Marte?Perchè muovono il piè[de] or presto, or tardo?«Quel diavolo di globo che qual dardoSpinto e respinto or sbalza, or torna, or parte.E quei minchion, parte seduta e parteRitta, ed in cocchio, gira avido sguardo?«Quei terminacci: fallo, passa, caccia,Quel ventoso cristero e quel lachino41.Che ci scaglia il pallon a tutti in facciaChe voglion dir? Cosa mai fanno, Elpino?» —Elpin ride e s'accosta, indi m'abbraccia:— «Semplicetto scioccon, chiede a Gazzino.» —
Gazzino, chiamato in ballo da quest'ultimo verso, risponde per le rime (e qui la frase vuole intendersi in significato letterale); ma la sua risposta è troppo vivace, e dobbiamo lasciarla nel manoscritto che la conserva42.
La fortuna del passatempo si tradusse in una specie di frenesia tanto negli attori quanto negli spettatori. V'era un certo Di Blasi, un certo Natoli, Fazello, Pampillonia, Agarbato, Spadaro, Mineo, Monteleone, Barone43 e non so quanti altri, che volevano parere agili e gagliardi, ed erano invece o pieni di velleità di ardimento, o slombati e fiacchi.
Anche su di essi si sbizzarrì la Musa: ed un anonimo dettò una lunga lettera in versi martelliani ad un ipotetico amico, nella quale, fingendosi straniero, conoscitore esperto del giuoco fuori Sicilia, metteva in canzonatura i guasta-giuoco di Palermo, de' quali dava brevi ma incisive notizie. Sentiamo un po' quel che egli scriveva:
Per darvi, amico, al solito, nova di quel che miroIn questo di Sicilia piccol'e grato giro,Vi dico che nel giungere in questa Capitale,Considerato avendola, non trovo tanto male.Vi scorgo il buono, il pessimo, il dotto, l'ignorante,L'onesto, il disonesto, il celibe, l'amante.A' pregi, a' mali insomma, a dirla come penso,In essa può abitarvi un uomo di buon senso.La sera sempre portomi in una compagnia,Ove ne godo al sommo di lecita allegria.Nel giorno, essendo libero, vado per divertirmiAl giuoco del pallone. Dovete qui soffrirmi.Dal darvi nuove serie, allontanar mi voglio:Queste ve le riservo scrivere in altro foglio,E conoscendo appieno qualunque giocatoreAvendo quasi un mese passato in questo l'ore,L'aspetto, il nome, il vizio d'ognun vi scrivo in questo:Sarò nel mio rapporto veridico ed onesto.Gente la più bisbetica qui si raduna, amico:Il giuoco, non v'inganno, a me non piace un fico.Veduti i giocatori dell'altre nazioniIn paragone, questi, mi sembran cordoni44.
E fa la rassegna minuta, particolareggiata di essi, che sono appunto quelli dianzi ricordati.
Nonostante, il giuoco proseguì con tale assiduità che al giungere di Ferdinando III in Palermo, i più appassionati pensarono di assicurarsi il possesso avvenire del terreno nel quale si divertivano tanto, presentando al Re un Memoriale, che dice assai più di quello che noi possiam dire:
«Li giocatori e dilettanti di pallone di questa città di Palermo espongono che sin da tempi immemorabili il luogo pubblico ove si è sempre fatto esercizio del gioco del pallone è stato tutto il pianterreno, che corrisponde sotto il baluardo nominato dello Spasimo, vicino alla Marina, ed oggi rimpetto all'Orto Botanico. Questo gioco incontra tanto il piacere di questa popolazione quanto in tempo di gioco concorre in quel sito una strabocchevole quantità di cittadini d'ogni classe o per giocare o per essere spettatrice del gioco; a segno tale che li dilettanti fanno continuamente delle spese per mantenere il cennato sito adatto alle giocate: ed anni due addietro, quanto a dire nell'a. 1797 e 1798, vi erogavano la somma di onze settanta circa... Vi abbisognano intanto delle altre spese e per la decenza del luogo, e per renderlo più commodo ai giocatori. Ma siccome questo gioco non porta una pubblica istituzione, e temono i dilettanti che un giorno all'altro dovrebbero avere impedito l'uso del terreno al presente addetto al riferito gioco per impiegarlo ad altro destino, così per potere impiegare con sicurezza il loro denaro, pregano affinchè si degni ordinare, che atteso il tempo immemorabile in cui il pianterreno che corrisponde sotto il baluardo dello Spasimo, che porta la longitudine di tutto il baluardo e la larghezza di canne 10 circa, è stato lasciato per commodo dei giocatori del pallone, resti il luogo suddetto addetto a tale uso, e non possano li giocatori essere molestati per qualunque causa nell'uso del suddetto terreno.
«Si tratta di un gioco di pubblico divertimento e di decoro per altro di questa città, che incontra l'approvazione d'ogni classe di cittadini, e quindi sperano i ricorrenti dalla Clemenza Vostra che loro sarà accordata tal grazia».
Il Re, abituato ad altri divertimenti meno leciti, non capì questo: e, senza punto scomporsi, rimise per mezzo del suo ministro Principe del Cassaro la istanza al Senato perchè ne facesse «l'uso che conviene». Ed il Senato la mandò, come in linguaggio burocratico si dice, agli atti, e concesse invece all'Orto Botanico quello spazio di terreno che fronteggia l'Orto medesimo45.
Una cosa non potè impedire, cioè che la contrada nella quale «da tempo immemorabile» si era giocato, si chiamasse, come in quel tempo si chiamava ed oggi si chiama tuttavia, Il Pallone; al quale battesimo non ebbe nessuna parte.
La lapide che non murò allora il Senato (perchè le prime lapidi state apposte son di poco anteriori all'anno 1802: e celebre fu quella del Cassaro morto, di fronte all'Ospedale di S. Bartolomeo, oggi S. Spirito), l'ha murata testè il Consiglio Comunale.
Se nobili e civili si divertivano sotto lo Spasimo al pallone, adulti e giovani non lasciavano passare giorno senza giocare alle bocce.
Questo passatempo, così diffuso dentro e fuori città, piaceva a tutti gli sfaccendati, e divenne una vera frenesia; di che non si saprebbe nulla oggi se i viaggiatori non avessero deplorato l'abuso pericolosissimo pei passanti. Fu notato infatti, che nei viali fiancheggianti la Villa Giulia si faceva a chi lanciasse più lontana la palla e a chi riuscisse al miglior colpo. Se il Capitan Giustiziere se ne occupasse, ed il Pretore vi mettesse gli occhi sopra, non appare dalle carte del tempo, perchè certe cose andavano allora un po' sommariamente, e ad alcuni inconvenienti, che ora metton sossopra la stampa giornaliera, non si guardava nè tanto nè quanto, quasi fossero le più naturali di questo mondo. Il medesimo passatempo, del resto, occupava nelle ore pomeridiane di alcuni giorni della settimana gli ascritti alle congregazioni della Villa Filippina, della Villa de Fervore, della Villa di S. Luigi; ma lì era innocuo, e vorremmo dire disciplinato.
La passione della caccia chiamava sul mare e lungo la spiaggia all'autunnale «passa delle allodole». Spettatore cotidiano di queste scene, Bartels, ne provava infinito piacere. In centinaia di barchette migliaia di cacciatori scorrevano il golfo. All'appressarsi d'uno stormo di quegli uccelli facevan silenzio; alla calma seguiva improvvisa tempesta, scariche di schioppi, e concitato abbaiar di cani tuffantisi in acqua a raggiunger la calda preda, ed alte voci pei colpi buoni46.
Ma la passione fu qualche volta contrariata. Essendo in Palermo, Re Ferdinando, abile ed irritabile cacciatore, ebbe da non pochi proprietari aperti i loro fondi perchè vi cacceggiasse a tutto suo agio e diletto. Fu una processione di omaggi al Sovrano, ma fu anche un'astuzia degli offerenti per liberarsi dei tanti seccatori che per quel gusto si permettevano di scorrazzare in lungo e in largo le loro tenute; perchè, fatta la offerta, si affrettavano a proibire a qualsiasi persona lo accesso, col pretesto della caccia riserbata al Re.
I cacciatori ne furono desolati, ed a sua Maestà si rivolsero con un indirizzo, supplicandola di voler loro concedere libertà di cacceggiare nelle private proprietà47: domanda, in apparenza molto semplice, ma in sostanza stranissima, perchè rivela in che concetto si avesse l'autorità regia, dalla quale si reclamava il disporre come di roba di nessuno della roba altrui bastando l'ordine del Re.
CAP. III.
I TEATRI E LE ARTISTE; I PARTIGIANI DI ESSE. LOTTE TRA IL S.a CECILIA ED IL S.a LUCIA.
Gli spettacoli teatrali, qualunque fosse la loro natura, costituirono sempre una delle passioni predominanti nei Palermitani; l'«opera però era sempre la più favorita»48 per la quale venivano sempre con periodiche esecuzioni aperti i teatri di S.a Cecilia e di S.a Caterina, i maggiori del tempo.
S.a Cecilia era della Unione dei Musici: e vi aveano palchi di loro proprietà sontuosamente addobbati la Marchesa di Regalmici, Caterina La Grua Talamanca e la Principessa del Cassaro, Maria Cristina Gaetani. Dopo la riforma che ne fu fatta sotto il Vicerè Principe di Caramanico, non mancava ad esso nulla per esser degno di accogliere l'aristocrazia siciliana con opere musicali eroiche, di stile di cappa e spada e qualche volta comiche. I signori ne eran contentissimi, anche perchè ne era stato tolto il pericoloso ingombro del tamburo in legno, sostituito con altro in muratura49.
Col S.a Cecilia, ma a certa rispettosa distanza, andava il S.a Caterina, o S.a Lucia; così chiamato per la vicinanza del Monastero di S.a Caterina e perchè apparteneva ai Marchesi di S.a Lucia Valguarnera, che vi aveano addossata la loro casa e da privato e domestico l'avean reso pubblico50.
Come più piccolo, non potea esso pretenderla alla magnificenza del fratello maggiore, ed avea ricordi non alti nelle rappresentazioni comiche di antichi artisti buffi, giunti fino a noi col titolo di Travaglini; onde il nome che ne serbò lungamente. Ma a volte, la elevatezza degli spettatori veniva quasi indistintamente condivisa da entrambi i teatri, dei quali il S.a Caterina offriva d'ordinario opere comiche.
Un giorno il Vicerè Caracciolo, scontento anche dei teatri, persuase i patrizî a costruirne di sana pianta uno nuovo fuori Porta Macqueda. Tra quei patrizî erano Senatori: e fu appunto il Senato l'interprete o esecutore dei desiderî di S. E. Si fece il disegno, si stabilì il luogo dell'edificio e fu anche detto più tardi che le somme occorrenti sarebbero state prese dai fondi amministrati dalla Deputazione per le strade di Sicilia51. Ma all'ultima ora, quando si trattò dell'attuazione, nessuno osò avventurare il Comune in una opera non creduta necessaria. Se non che, quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini: ed i Barberini o barbarini furono gli allegri amministratori della città cent'anni dopo, quando demolirono quattro chiese e due monasteri per edificare un Teatro Massimo, proprio in quei medesimi paraggi nei quali fin gli spensierati signori del secolo XVIII non avevano avuto il coraggio di farlo.
Vicende dei tempi! Megalomania degli uomini!
Per Carnevale si aprivano non solo tutti e due i teatri, ma anche gli altri privati, permanenti ed occasionali, di Casa Abbate di Lungarini, del Marchese Roccaforte (a Mezzo Monreale), del Conservatorio degli Spersi turchini del Buompastore, del R. Convitto San Ferdinando, del Marchese di Salines Tommaso Chacon52.
Quell'uomo scrupoloso (!) che fu Ferdinando III un giorno s'accorse o venne informato che questi teatrini di famiglia non dovevano lasciarsi liberi di rappresentare quel che ai padroni piacesse: e con un dispaccio li volle sottoposti alla comune censura53: quasichè negli istituti di educazione si potessero rappresentare cose contro o il Governo, o la religione, o la morale!
Le più riputate compagnie d'Italia interpretavano drammi in musica e in prosa non prima qui uditi. Gustosissima la commedia musicale Giannina e Bernardone del Cimarosa, della quale nel 1784 si interessò personalmente il Caracciolo54, e che con grave errore si è detto essere stata la prima volta eseguita nel 1787 in Napoli55.
Per non dire degli anni anteriori alla ricostruzione del S.a Cecilia, costata tremila scudi, dal 1787 in poi, dame e cavalieri vi udirono, deliziandovisi, l'Ariarate del Tarchi, l'Arbace di Fr. Bianchi, l'Alceste del Portogeloclo, l'Amor contrastato (chi non ricorda questo celebre dramma in musica del Paisiello?), la Didone abbandonata, sul cui tema rivaleggiarono il palermitano Piticchio (1780), il massese Guglielmi (1785), il veneto Gazzaniga (1787), il pesarese Federici (1794), fino al Paisiello (1797); il Fanatico burlato del Cimarosa, l'Alzira di G. Niccolini56. E dame e cavalieri risero e lacrimarono (senza mai piangere) alle patetiche, attraentissime voci delle prime cantanti italiane e straniere Teresa Pogg (1789), Margherita Delicati e Marianna Vinci (1791), Anna Nara e Marianna Marioletti (1792 e 1794), Giuseppa Netlelet, Carolina Danti (1793), e Teresa Marioletti Blasi (1794) e Carolina Bassi e Caterina Fiorentino (1797) e Teresa Bertinotti e Carolina Miller (1799) e Carolina Scaramelli (1800)57.
Quando la musica veniva alternata con la prosa, e due compagnie si dividevano gli allori ed i quattrini del privilegiato teatro, la Morte di Carlo XII re di Svezia con altre tragedie dell'Alfieri vi ricompariva con sempre nuova simpatia, ed è notevole che in mezzo a tanta mollezza di costumi e svenevolezza maliziosa di operette serie e buffe potesse questa simpatia farsi strada e mantenersi in aperto contrasto con la natura dei componimenti tragici del sommo astigiano. Perchè, mentre le operette erano tessute d'intrecci strani, a base di pensieri e di affetti leziosi con linguaggio misuratamente appassionato, le tragedie dell'Alfieri si svolgevano con la massima semplicità d'intreccio, con la forza di pensieri magnanimi, con la robustezza, anche retorica, del linguaggio, con la frequente durezza dei versi.
La stagione classica era quella del Carnevale; ma vi erano anche altre stagioni dell'anno: e nel 1797 si principiò a gennaio e si finì a dicembre: un carnevale continuo: anno nei fasti del teatro in Palermo memorabile per i ridotti, gli svariati trattenimenti, gli artisti di cartello, la successione ininterrotta di rappresentazioni e per molte altre circostanze.
Il 28 gennaio andava in iscena col nuovo tenore Emanuele Caruso la Pietra simpatica del maestro di cappella palermitano D. Salvatore Palma58: e contemporaneamente, o quasi immediatamente dopo, parecchie opere musicali non eroiche, disimpegnate dalla Compagnia che dal primo suo buffo prendeva nome di Trabalza. La fiorentina Anna Andreozzi, prima donna, già nota e cara al paese, vi faceva miracoli d'arte, eguagliata qualche volta non superata mai dalla seconda donna Maddalena Menini.
Ecco la Quaresima con le sue penitenze e gli spettatori non erano ancor sazî di rappresentazioni. «Oh! pensavano essi, non sarebbe egli bello fare fermare, gli artisti in Palermo, ed eseguire opere sacre?». L'idea piacque e si espose all'Autorità politica ed ecclesiastica; la quale, poichè in assenza del Vicerè era accentrata nella persona dell'Arcivescovo Lopez, l'accolse benevolmente; ma sotto una condizione, cioè, che si dovesse stare strettamente alle opere sacre; che oratorio dovesse chiamarsi il teatro, e che al domani di una rappresentazione, lo spettatore dovesse andare a udir messa: fanciulleschi ripieghi, nei quali i nomi mal coonestavano le cose, e l'esercizio d'un atto religioso serviva di passaporto ad uno spettacolo mondano.
La Giuditta era tra le opere più accette59; il teatro fu sempre pieno zeppo, e «non vi fu sedia, gradetta o palco vuoto. Gli impresarî (Corrado Nicolaci Principe di Villadorata, Gaetano Campo ed altri) vi guadagnarono centinaia d'onze. Il teatro fu convertito in Oratorio e così chiamato, e chiesa e luogo sacro». L'esempio degli oratorî produsse effetto maraviglioso nel clero secolare e regolare. Poichè il teatro è stato convertito in chiesa — dissero molti — con sacri oratorî, perchè non si può andare anche a teatro per assistervi?... E poichè si assiste ad opere sacre, perchè non si può anche assistere ad opere profane?
Il ragionamento non faceva una grinza: ed ecco ecclesiastici d'ogni ordine accorrere al teatro. L'impresario, che non cercava di meglio, allargò la mano con opere musicali di giorno, per preti e regolari: «cosa, confessa il Villabianca, vergognosa, quasi sacrilega», spiegabile solo con «la mutazione dei tempi»60.
Scorsa con questi mezzucci la Quaresima, la passione del teatro diventò febbre. Dopo il sacro venne il profano. Pel maggio apparecchiossi, con un'altra compagnia, Il trionfo di Diana in costumi così scollacciati che la Nobiltà fuggì inorridita, e l'impresario, responsabile dello scandalo, fu mandato in carcere, donde potè uscire solo per intercessione di quei medesimi nobili che aveano ricorso contro di lui. Il dramma musicale fu ripresentato con radicale riforma di costumi61.
Così giungevasi alla estate, e con la compagnia Tassini si assisteva alla rappresentazione del Pimmalione di Bonifazio Asioli o del Sirotti in luglio, della Morte di Cleopatra del Nasolini in agosto: opera grandiosa, nella quale sul palcoscenico appariva un carro tirato da quattro cavalli; dei Tre eredi in settembre. Assunta la impresa da Pietro e Bartolomeo D'Affronti, ritornava il sempre desiderato Giuseppe Trabalza con le sue lepidissime commedie per musica; ma la diva Andreozzi non compariva, e in sua vece veniva la Cecilia Bolognesi, che nei Puntigli per equivoco del Fioravanti62 faceva le parti di Bettina figlia di D. Fronimo, mentre Ludovico Brizzi rappresentava D. Eugenio, amante prima di Dorina, poi di Bettina. Così proseguivasi sino alla fine con l'Astuto in amore, che dopo due esecuzioni doveva mettersi da parte; con la Donna sensibile di Giacomo Tritto e con altre opere, tutte a lode anche del maestro di cappella D. Giuseppe Bracci, stato abilmente al cembalo, dei pittori delle scene D. Filippo Ferreri, D. Vincenzo Vulturi e D. Baldassare Pace, ed anche un po' del vestiarista D. Gaspare Siragusa, che fu il Settimo Cane del secolo XVIII.
Noi rivedremo tra poco l'Andreozzi nella Vergine del Sole del Cimarosa, ed intanto proseguiamo la nostra rapida descrizione.
Al S.a Lucia non si faceva da meno: e dove negli anni anteriori le opere comiche in musica vi avevano attirato uditori e spettatori, amici incondizionati, o con la Teresa Corisoli della compagnia comica Pinetti (1794), o con l'Agata Rubini (1795 e 1801), nel 1797 era una sequela di opere comiche e tragiche nuove per esso. Il Carnevale di gennaio e febbraio aveva una ripresa in autunno col Pirro re d'Epiro del Zingarelli, con La Serva padrona e con gli Zingari in fiera del Paisiello; e nel Carnevale seguente, passato clamoroso per gli applausi riscossi dalla prima donna Anna Davì o Davya piemontese, la quale, benchè attempatella, nella Zenobia in Palmira di Pasquale Anfossi cantava con grazia ed eccellenza singolare. Onde il Meli, attempatello anche lui, improvvisava la odicina intitolata:
Li Grazj.Sai, bella Veneri,Sai tu pirchìLi Grazj currinuA la Davì?Pri fari vidiriChi ad idda staRendiri amabiliQualunque età;E chi tu propriaTu stissa tu,S'iddi ti lassanuNun cunti cchiù63.
Lucrezia Nicodemi nell'anno successivo non ebbe per la Finta amante del Paisiello i versi di un Meli; ma portò via i regali di parecchi giovani ed il cuore di più d'un adoratore: storia vecchia, e pratica sempre nuova!
Noi non abbiamo tempo di fermarci sulle opere musicali che si eseguivano tra noi; ma se per un momento potessimo farlo, ne vedremmo ogni tanto una siciliana o di Siciliani. Tutte o quasi tutte venivano da fuori e per lo più da Napoli, la cui scuola primeggiava, e donde il passaggio a Palermo era come una tappa geografica naturale. A Palermo facevan capo, come una volta le opere del Pergolese e dello Scarlatti, i recenti lavori del Paisiello, del Cimarosa, del Guglielmi; e le fresche ed eterne loro ispirazioni giocondavano una società che li comprendeva e li sentiva.
Nel resto però le opere teatrali erano melodrammi artificiosi, dai temi obbligati, dagl'intrecci unitipici, dalle situazioni imbarazzanti, dagli amori apparentemente divisi a più aspiranti, dai cuori a pani di zucchero, dalle sinfonie solo buone a solleticare senza commuovere, a pungere senza penetrare, a vellicare senza premere, a muovere a sdilinquimenti senza eccitare ad un fremito.
I partiti in teatro turbavano sovente la calma della rappresentazione, il godimento dello spettacolo, l'ordine della città.
«Nei primi tempi della mia età, racconta il Villabianca, fiorirono al Travaglini... la Turcotta con la Manfrè. Queste due donne attrassero talmente alcuni nobili che essi prendendosi a partito arrivarono a profondervi delle migliaia con molto danno delle loro famiglie. Profittando di queste gare, le due donne tornarono a casa con le tasche piene d'oro e argento palermitano. Giunse a tal segno la loro follia che per distinguersi gli uni dagli altri nella possanza di partitarî, feronsi leciti pubblicamente di portare in petto pendenti, dei nastri vermiglio e verde, le amorose insegne del gelsomino e dell'ancora non altrimenti che fossero state divise onorevoli dì ordini cavallereschi».
Più tardi, avvenne un vero scandalo per altre due donne del S.a Cecilia, protette da due gruppi contrarî, accalorati nell'ammirazione della mimica di esse, le quali gareggiando si contendevano il primato nell'arte di Europa; onde ebbero luogo scandalose ragazzate dei parteggiatori64.
In questo tempo (1778) era al S.a Cecilia la più grande artista d'Italia, madama la Gabriella, detta la Cochetta. Non si sa come anche lei fosse entrata nella briga, lei donna di alto merito e di sconfinato orgoglio; fatto è che ci entrò. E di essa si racconta che in una sera del Carnevale 1771, essendosi rifiutata di cantare, il Capitano di Giustizia, stimando metterla a dovere col mandarla in carcere, n'ebbe in risposta: Piuttosto piangere mi posson fare che cantare65.
Questo è nulla a petto di quello che accadeva molto più tardi con l'Andreozzi.
Siamo nello scorcio del 1797 e nei primordî del 1798. Il partitario (impresario) Toti fa andare sulle scene del S.a Cecilia la nuova opera Vergine del Sole del Cimarosa con questa prima donna seria. Ma c'è in Palermo la prima donna buffa, Cecilia Bolognesi, alla quale il Capitano della città Principe di Torremuzza ha assegnato il grado e le mansioni di seconda donna. Offesa nell'amor proprio, essa riesce per via di aderenze a prendere parte alla rappresentazione vestita da Alonso. È una vittoria, questa della Bolognesi, che però non basta a soddisfare gli amici di lei, mentre lascia scontenta la Andreozzi e sconcertati i suoi partigiani. Le due artiste sono al colmo della rabbia, e i loro sostenitori, l'un contro l'altro armato, s'attendono al varco. La prima sera è sfavorevole all'Andreozzi; i suoi ammiratori vengono sopraffatti da quelli della Bolognesi. Il Principe di Torremuzza ordina la sospensione dello spettacolo; il pubblico se ne impermalisce, e al riaprirsi del teatro, senza tanti complimenti, conferma la sua opposizione; onde la Andreozzi, perduta la pazienza, gli rende un certo saluto retrospettivo che fa andare su tutte le furie lo spazientito pubblico. Dalle parole si passa ai fatti; dai fischi e dagli urli ai limoni ed ai gozzi di polli pieni d'acqua. Gli avversarî non la vogliono più sul palcoscenico: gli amici non possono più far nulla per lei; ed il Capitano, con indicibile risentimento della Nobiltà, che all'indecente saluto aspetta una ammenda, fa abbassare la tela. E che cosa dovrebbe egli fare il Torremuzza? — «Mandarla alla Carboniera!» gridano i più. — «Lasciarla stare!» dicono i meno. Si vuol trovare un accomodamento, e non si trova. Si cerca invano di fare sbollire la collera degli offesi. E se non fosse per l'alto ufficiale di giustizia Leone, che, capito il dietroscena di questa commedia, mostra i denti, chi sa dove si andrebbe a finire! Il paglietta ha ordinato l'esecuzione d'un'altra opera con la sola Bolognesi; ha fatto catturare due parrucchieri, e, a capo di alcuni giorni, ha permesso, con pace di tutti, la rappresentazione della Vergine del Sole: pace ottenuta in una maniera semplicissima: facendo circondare il teatro da sbirraglia e da truppa sotto il comando del brigadiere svizzero Xiudi. L'impresario Toti, che pel danno che gli è venuto dalla chiusura del teatro, ha messo sossopra tutte le autorità, tira un gran sospirone66.
Ora chi sono essi questi parrucchieri, e perchè catturati?
Cherchez la femme, se la femme non si vede anche troppo.
Perchè, è da sapere che la Andreozzi ha una certa amicizia col Pretore, ed il Pretore, che le vuole un gran bene, poco curante dalla sua alta dignità e del suo stato civile, la colma di regali, e le passa cinquant'onze al mese e la carrozza di casa sua ogni giorno, con quanto dolore della Pretoressa e scandalo de' Palermitani, si può immaginare...
A proposito di che si richiama l'aperta protezione accordata dal Vicerè Caracciolo (febbraio del 1782) alla cantante Marina Balducci, che egli avea conosciuta a Parigi; e si rifà la storia dei suoi inviti a pranzo e dei mormorii che destò nei nobili la presenza di una commensale rotta alla facile vita delle scene67.
L'Arcivescovo e Presidente del Regno Lopez potrebbe metter fine allo scandalo, ma non volendo guastarsi col Pretore, ha legate le mani al Capitano, lasciando per tal modo crescere in arroganza la turbolenta artista. Contro di lei, come contro la sua rivale, pare sia stata ordita una congiura tra la Principessa di Belvedere, Caterina Del Bosco e la Duchessa di Montalbo, Marianna Ramondetta: congiura alla quale non sarebbe stata estranea la Capitanessa Maria Castello, Principessa di Torremuzza, interessata la parte sua a favore del marito. Ed ecco come c'entrano i due arrestati. I parrucchieri delle prime due dame sarebbero stati gli intermediarî ad esse ed ai più accaniti partigiani delle due artiste, e la loro cattura è stata seguita da quella del nobilotto Ignazio Costantino, che presto rivedremo. Il Governo ha fatto ingiungere alle tre dame di astenersi dall'andare a teatro; ma alcuni dicono di averle viste tutte e tre insieme nei palchi; e Pasquino, seccato dell'imbroglio e della temporanea sospensione dello spettacolo, si lascia andare a questo debole sfogo:
Montalbo, Ramondetta e BelvedereHan privato il teatro del piacere.
Alla Andreozzi, prima e dopo i tumulti, son piovuti dai palchi dei suoi ammiratori sonetti e canzoni: composizioni, come di consueto, al di sotto del mediocre. Tra tutte ve n'è una d'un benedettino cassinese, P. Bernardo Rossi, aio dei figli del Principe di Trabia, il quale nasconde la sua mondanità sotto il semi-anagramma di Luigi Dorisse: Egli «in atto di vero ossequio» così incomincia la sua ode:
Ecco già canta: uditelaOh come alterna il fiatoSeguito dalle GrazieA rapir l'alme usato!L'alata voce ed agileIn mille giri ondeggia,Ora con volo rapidoQuale usignol gorgheggia;Ora di luce etereaCinta dall'alto scende,E con bell'arte insolitaI cuor' di gioia accende68.
Contemporaneamente v'è chi canta le lodi di Maddalena Ammonini, prima donna assoluta del S.a Lucia; ed un tal Salvatore Pino ha il coraggio di offrirle un epigramma latino, che essa, s'intende, non avrà neanche guardato, ed un Giovanni Corifeo, pseudonimo, un sonetto, confortante nelle recenti lotte degli invidiosi, poi
Che dalla ruota e dal martel cadente,Mentre soffre l'acciar colpi ed offese,E più fino diventa e più lucente69.
Ogni nuova compagnia di prosa o di musica che giungesse era un avvenimento che suscitava nuovi ardori nell'animo dei nostri giovanotti. Come prima, così dopo, essi non sapevano nascondere la loro passione: e comiche e cantanti e ballerine ricevevano gl'isolani adoratori come avevano ricevuto quelli, forse meno ardenti, perchè men privi di cosiffatti incontri, di Terraferma. Meli vide nella passeggiata della Marina questi ganzerini, che perdevano la testa appena incontrassero una sacerdotessa di Tersicore; e
Beati primi
esclamava in una meschina poesia,
Ch'ànnu ddu brazzu!Cu quali sfrazzu!Si purtirà!
E in un'altra migliore:
Anche gli uomini serî e i grandi dignitarî di Stato non andavano esenti da cosiffatte debolezze. Nel 1799 l'Ambasciatore russo Puskin, alla Corte di Napoli in Palermo, marito della Contessa de Bruce, si accendeva per la bellissima cantante Miller, ed intrattenevasi volentieri con lei, alla cui abitazione si faceva precedere dal suo cacciatore: sistema non nuovo, perchè ordinariamente tenuto dal Re71, cacciatore d'ogni genere anche dopo sgradevoli sorprese.
Le gelosie, che non eran troppo forti tra mariti e mogli, divenivano ardenti tra gli uomini e le artiste, e spingevano quelli a sconsigliati passi, che reclamavano l'intervento della polizia. Il nobile Diego Sansone guastavasi un po' clamorosamente con una ballerina, e veniva chiuso nella Colombaia di Trapani; Placido Bonanno dei Principi di Linguaglossa, cavaliere gerosolimitano, poco cavallerescamente correva dietro ad una donna della Compagnia comica, e commetteva per essa tante discolerie da essere relegato in Siracusa72. Più grosse quelle di un signore, il cui titolo marchionale oggi due casati si contendono, e di Filippo Cordova Marchesino della Giostra. Costoro, o ingelositi del primo ballerino di S.a Cecilia, o contrariati dalla sua opposizione e dalle sue pretese, per certi loro innamoramenti teatrali si decidevano ad una buona lezione. Di notte lo facevan sorprendere da lor gente e gli facevano aggiustare delle bastonate da orbo; in seguito alle quali per ordine immediato e de mandato venivano chiusi, questi, il Marchesino, nel Castello di Siracusa; quegli, che alla fin fine, perchè trascinato dall'amico, avea sorbito a beneficio altrui l'amaro senza aver gustato il dolce, nel Castello di Milazzo.
V'eran poi gli eterni disturbatori de' teatri, tanto cari a certi codiciai moderni, nati fatti per proteggere i birbanti; ma la polizia del tempo, senza permesso nè ordine di nessuno, metteva loro addosso le mani e li mandava al Castello. Il giovane Marchese Costantino, capo di codesti sconsigliati nel 1797, informi. Qualche volta la polizia non bastava, e doveva ricorrersi ad un buon nerbo di truppa, e non per una sera soltanto!73.
Ed ora passiamo ad altro ordine di cose teatrali.
Le relazioni tra i due teatri erano quanto di più brutto possa immaginarsi. Il S.a Cecilia tirava sempre a deprimere il S.a Lucia: ed il S.a Lucia, insidiato, colpito ad ogni istante, reagiva con vigile energia. Gli è che l'uno si vedeva leso dall'altro: e Governo e privati non sapevano dissimulare la loro predilezione pel S.a Cecilia, convegno favorito dell'alta cittadinanza, al quale tutto si permetteva, fino alle cose più lontane dalla giustizia e dalla equità. E la buona Marchesa di S.a Lucia, Valguarnera Gentile, che era sola nell'amministrare il patrimonio della famiglia e quindi il suo teatro, e che non poteva contare sulla cooperazione degli scioperati figliuoli, mai non si stancava di chiedere la denegata giustizia, di lamentare diritti conculcati, di sventare trame contro la sua esistenza economica.
Le si voleva impedire di tenere aperto il teatro quando era aperto quello di S.a Cecilia, e non si teneva conto del regio dispaccio del 1746, che imponeva restassero «ambi li teatri senza distinzione aperti» correndo «egualmente la fortuna»; e poichè a pochi mesi di distanza erasi dimenticata la precedente sentenza dell'autorità: che «ogni impresario è libero; niuno attenta sul diritto dell'altro, nè cerca, nè ottiene tampoco proibitiva» (4 luglio 1792), lo impresario Giuseppe Azzalli per la Marchesa invocava a favor suo, presso il Sovrano, quella sentenza (21 ott. 1793).
La questione rimaneva sempre insoluta; anzi s'inaspriva volendosi al S.a Lucia vietare opere sacre e serie in Quaresima. Giacchè, dice un sovrano rescritto del 1793, richiamato dalla parte avversa, queste opere si prestano alle scurrilità. «Una cosa sola può concedersi: la esecuzione degli oratorî; ma gli oratorî non si fanno altro che a S.a Cecilia; perciò il S.a Lucia non ha ragion di dolersi».
Così alla ingiustizia si aggiungevan le beffe! (14 febbr. 1797): e si mettevano in non cale esempî contrarî all'affermazione, come quello della concessione ad altra impresaria del S.a Lucia, Teresa Consoli (9 febbr. 1795), la quale però, perchè giovane, poteva aver avuto mezzi più persuasivi della vecchia Marchesa.
Le sopraffazioni non si rimanevano qui. Un nuovo impresario dianzi citato, Andrea Toti, forte delle alte protezioni ceciliane, chiedeva (20 maggio 1797) la proibizione delle opere in musica al S.a Lucia. La Marchesa se ne appellava al solito Capitan Giustiziere, il Conte S. Marco, il quale non poteva darle torto; ma tra il sì ed il no, era il parere contrario, cioè che due teatri in musica non potevano stare, tanto che uno di essi era stato per varî anni senza musica74: risposta che non dice nulla ed ha tutta l'aria di dar ragione alle due parti, mentre non ne dà a nessuna. Toti non s'acquetava, e rivolgendosi al Re, tesseva un po' di storia delle condizioni teatrali del tempo. «In S.a Lucia — osservava — si è sempre rappresentato la prosa (bugia smentita dalle notizie sopra riferite). A S.a Cecilia, dove io ho preso la impresa per due anni, e che è il maggior teatro, si è sempre rappresentato la musica. Io, credendomi unico per le opere in musica, mi caricai di doppia compagnia, per opere serie e buffe. L'impresario non può calcolare sull'intervento dei forestieri, ma solamente deve sostenersi con quella poca nobiltà che rimane in Palermo, e con pochi individui del mezzo ceto, in guisa chè in tutte le sere non si vedono altri in teatro che le stesse persone. Se in un paese situato in questa maniera si apre un altro teatro di musica, sarebbe lo stesso che in quindici giorni serrarsi l'uno e l'altro con positivo svantaggio del pubblico, che resterebbe privo dell'onesto divertimento del teatro» (2 giugno 1797).
Stavolta il Re non poteva riconoscere un diritto proibitivo anche nelle opere da rappresentarsi; ma l'autorità locale, mortificata del ricorso, se la legava al dito e a breve scadenza se ne prendeva la rivalsa.
Siamo alla sera del 31 ottobre 1798, e deve andare in iscena la nuova opera buffa: Il Cartesiano fanatico del Tritto con la Nicodemi, prima donna. Il cartello della Piazza Vigliena annunzia il cominciamento ad un'ora di notte, consueta dell'opera. A quell'ora appunto il teatro ha principio. Il colto pubblico di dame e cavalieri manifesta il suo mal'animo verso la Nicodemi, e protesta che non vuol saperne, altro che per udire o riudire la Semiramide75. Al Capitan Giustiziere, Principe Carlo Gir. Castello, non par vero di cogliere la palla al balzo: e manda in carcere il messo ed il palchettiere. Ma come c'entrano questi disgraziati? chiede la Marchesa di S.a Lucia al Vicerè; ed il Capitan Giustiziere, che ha commesso un vero abuso di potere, posto tra l'uscio ed il muro, mendica per giustificarsi i più futili argomenti, e nasconde l'avversione al teatro di piazza S.a Caterina con questa magrissima scusa: A rispetto del digiuno, nelle vigilie, di estate si suole aprire il teatro a un'ora di notte; ma d'inverno non è così: le sere, le notti son lunghe, ed il pubblico non vuol esser congedato dal teatro presto. «Il moto che nelle vie cagiona il ritorno della gente dal teatro, tien desti i cittadini e rompe molti disegni nella città popolosa»76. Il messo ed il palchettiere — aggiunge — vennero subito rilasciati in libertà; ed in prova manda un certificato del carceriere capo della Vicaria, uno spagnuolo con quattro o cinque nomi e cognomi.
Un'altra per suggello dei due pesi e delle due misure nei due teatri.
Mentre ristrettissimo era il numero dei posti gratuiti ai quali obbligavasi il S.a Cecilia, illimitato era invece quello imposto al S.a Lucia. Noi non ne sapremmo forse nulla se la stanca proprietaria non l'avesse rotta con le camorre del tempo. Essendo Presidente del Regno il tante volte ricordato Arcivescovo Lopez, la Marchesa ricorreva a lui implorando la riduzione dei posti ch'ella, in un teatro piccolo come il suo, doveva mettere a disposizione delle Autorità e del personale ai servigi di esse. Facciamone la lista:
Palchettone di mezzo al Vicerè;Due palchi per la paggeria e servitù:Palco pel capitano della guardia;Palco per la servitù di lui:Palco pel capitano di Giustizia;Palco per la sua servitù.
Posti in platea:
Sedia pel vice-Capitano di Giustizia;Sedia per l'Aiutante reale del Vicerè;Sedia pel primo portiere della R. Segreteria77.
In mezzo a questo arruffio d'impresarî del S.a Cecilia e di impresarî e proprietarî del S.a Lucia, una cosa si vede chiara: che coloro i quali si occupavano di affari teatrali non nuotavano in un mare di ricchezze. La città era sempre la stessa, la popolazione sempre una, non accresciuta mai da forestieri, che sogliono portare un contingente di frequentatori dei pubblici spettacoli. Ai teatri andavano i due ceti principali: il nobile ed il civile, e con essi a grande stento poteva riuscirsi, quando vi si riusciva, a francar le spese per parte di coloro che assumevano la impresa della stagione. I piati che abbiamo visti partire quando dal piano di S.a Cecilia, quando da quello di S.a Caterina, accusano insistentemente questo difetto. Avveniva, in conclusione, quel che avviene sempre: si voleva assicurata parte della spesa; e, non potendosi al Comune, peraltro impoverito, si ricorreva all'aristocrazia dei titoli, che al far dei conti rappresentava sovente l'aristocrazia del denaro. E poi non dobbiamo dimenticare che se il S.a Lucia avea pesi gravi, non men gravi ne avea il S.a Cecilia; tra i quali per gl'impresarî quello di dovere per un anno dugent'onze all'Unione dei Musici, che solo a questa condizione poteva, secondo i vecchi Capitoli, cedere il teatro78.
Il 18 novembre 1793 il Principe di Trabia, che rivedremo nell'esercizio delle sue funzioni di Capitan Giustiziere della Città79, facea sapere che Cosimo Morelli nel dicembre dell'anno precedente aveva offerto per l'anno teatrale 1793-94 del S.a Cecilia spettacoli serî e buffi, balli e non so che altro, a patto che gli si assicurassero mille ducati di regalo e novemila altri ducati pei soli palchi. Il Principe da uomo liberale e generoso pagò di suo i mille ducati80.
Dieci anni prima (1782), con l'attrattiva dei successi ottenuti dalla Marina Balducci, avevano assunta l'impresa per le opere in musica della stagione, sessanta avvocati, sicurissimi di lauti guadagni. Al tirar dei conti, ci perdettero 10.000 scudi, cioè sessant'onze (L. 755) l'uno!
A tanto danno continuo, invincibile si cercavano rimedî, e si giunse alla concessione, chiesta ed ottenuta dal Duca di Belmurgo, Capitan Giustiziere, al Re, di «una festa di ballo, o sia ridotto comunale per dare un divertimento al popolo e formare nell'istesso tempo un fondo da potersi sostenere con decenza l'anzidetto teatro», concessione forse unica in tutto il secolo81, la quale dovette scandalizzare certuni, non abituati a veder l'infimo ceto profanare il tempio degli svaghi pei ceti superiori. Ma questo ed altri espedienti riuscirono infruttuosi.
Malgrado i partiti, malgrado i litigi continui e le altre miserie che abbiam dovuto purtroppo lamentare nei teatri della città, questi non sembravano indegni d'una Capitale. Il tedesco Hager ne diede un giudizio che deve rispondere perfettamente alla realtà se concorda con quello datone poco dopo dall'inglese Galt, testimonio oculare anche lui pel corso di tre anni.
«I due teatri di Palermo sono entrambi occupati dalle compagnie che di anno in anno circolano per l'Italia con nuovi cantanti, ballerine ed attori. Nessun arlecchino offende coi suoi scherzi le orecchie degli elevati spettatori, nessuna facezia la dignità del pubblico italiano. Rappresentazioni estetiche han soppiantato i lazzi, e caratteri perfetti a poco a poco le burle dei tempi passati.
«I prezzi d'entrata sono mitissimi. Costumi, orchestra, decorazioni non sono, è vero, da mettere a paragone di quelli del Teatro nazionale di Vienna o delle scene di Londra e di Parigi, ma in Palermo son forse migliori che in altre città popolose e ricche d'Europa. Gli artisti medesimi mettono bene in caricatura le parti dei rigidi Inglesi, dei piacevoli Francesi e dei Tedeschi. Io vidi a Palermo, l'una dopo l'altra, quattro rappresentazioni: Arianna di Nasso, Curzio, Coriolano innanzi la sua patria, l'Origine dello specchio»82.
E Galt, con particolari del tutto nuovi, raccontava agl'Inglesi che in Palermo gli spettatori più astuti portavano in tasca dei punteruoli, che, entrando in teatro, piantavano dietro le spalliere delle sedie innanzi a loro come per caviglie per appendervi i cappelli. A nessuna donna era permesso sedere in platea. I servitori della Impresa aveano cura di fornire, nei palchi, agli spettatori che ne richiedessero, sorbetti: e chi ne aveva la privativa (la privativa anche qui!), sorbetti in platea. Nessun obbligo all'artista, ripetutamente, anche fragorosamente applaudito, di ripetere la canzone, la cabaletta, il duetto richiesto, salvo che il Capitan Giustiziere, credendolo conveniente, con un cenno all'attore od all'attrice non l'ordinasse.
Per tal modo, tutto procedeva regolarmente83.
In mezzo a tante e sì strane vicende, noi siamo giunti alla soglia del secolo XIX, sulla quale dobbiamo arrestarci. Il varcarla ci obbligherebbe a seguire la fortuna dei due teatri anche nel nuovo secolo.
Il tanto combattuto S.a Lucia, nel 1809, sotto gli auspici della non lieta Regina, si trasformava, e da essa prendeva il titolo di Real Carolino, e dopo il 1860 di Bellini, col quale, imperturbabile e tranquillo, accoglie artisti di alto valore e cittadini d'ogni ceto; mentre il S.a Cecilia non è più che un nome, un nome sopravvissuto ai disastri finanziarî tra i quali è stato trascinato e travolto. L'eco fragorosa dei suoi solenni trionfi è stata soffocata dai piati della Compagnia dei musici e dai lamenti dello Spedale di S. Saverio; e nei palchi ove rifulsero ammalianti le più belle dame della Nobiltà del Regno domina triste, malinconico il silenzio, rotto soltanto dallo stridìo di luridi rosicchianti e dal sordo rumore del tarlo, che lavora, lavora a compiere l'opera devastatrice del tempo e.... degli uomini.
CAP. IV.
IL «CASOTTO DELLE VASTASATE», OSSIA IL TEATRO POPOLARE.
Deficienza di mezzi e umiltà di classe non consentivano al popolo di assistere alle rappresentazioni dei due teatri principali della città; necessarî quindi altri teatri ad esso confacenti, con rappresentazioni adatte alla sua intelligenza ed alle sue inclinazioni. Una volta c'era, come si è detto, quello dei Travaglini; ma, trasformato nel teatro di S.a Lucia (Bellini), il popolino non ebbe più un luogo di spettacoli pei suoi gusti e pei suoi limitati espedienti. Avea bensì, la parte infima di esso, quello che ha ora: i teatrini delle marionette per le leggende cavalleresche del ciclo carolingio (opra di li pupi), e solo da venti e più anni è scomparso di su la porta d'un magazzino di ferro attiguo al palazzo Partanna in Piazza Marina (magazzino che servì a rappresentazioni paladinesche) il titolo di Teatro di burattini. Un genere speciale di commedie era eseguito in modo divertente da pupattoli. Tofalo, che vi partecipava, parve ad uno straniero la personificazione dell'indole siciliana, come John Bull della inglese. Ma la parte più divertente dello spettacolo consisteva in certe scene nelle quali le marionette riproducevano esattamente i caratteri bizzarri della Città, in modo così sicuro che non isbagliava d'una linea la caricatura; il che non mancava mai di recare diletto indescrivibile ai Siciliani allegri e loquaci84. La città avea pure il suo pulcinella per rappresentare «la libera commedia pei passanti, col suo linguaggio abituale, che solo può imitarsi con un pezzetto di lamina sulla lingua»85, vogliam dire quello che noi chiamiamo ancora tutùi, i Napoletani guarrattelle ed i Toscani castello.
Siamo proprio nell'ultimo trentennio del settecento. Una brigata di popolani d'ingegno pronto, di facile e colorito linguaggio, si propone di mettere su un teatrino tutto siciliano.
La letteratura non avea un repertorio comico dialettale da svecchiare, o sul quale metter le mani. Il carattere burlesco del Travaglino di Palermo e del Giovannello di Messina non facea più pei tempi; il servo siciliano Tiberio o Nardo era sciupato; bisognava modificarlo, rifarlo addirittura.
La brigata trovò persona che facesse le prime spese, pronta ad avventurarsi a rappresentazioni della vita e dei costumi dell'Isola.
Chi erano essi questi nuovi attori? Il portiere nella corte del Giudice di Monarchia, D. Giuseppe Marotta, il più piacevole, il più arguto spirito che Palermo avesse dato da oltre un secolo; Giovanni Pizzarrone, mastro Giuseppe D'Angelo, Giuseppe Sarcì, portiere anch'esso, ma del Lotto, Gaetano Catarinicchia, basso curiale, Ignazio Richichi, orefice, che è forse da identificare con quel Giovanni Richichi tiratore d'argento, il quale poi entrò nella Compagnia dialettale del R. Teatro S. Ferdinando; Mario Frontieri, sarto, Fr. Corpora, guardaporta nel Conservatorio del Buompastore, e parecchi altri maestri e bassi curiali, tutti, dal più al meno, analfabeti. Il teatrino sorse in forma di baracca di legno o, come si dice ancora, di casotto (nome che poi rimase classico) nel piano della Marina, e diede quanto di strano, di triste, di lieto offrisse Palermo. Nel 1785 la popolana brigata era già famosa: e se dapprincipio improvvisava secondo un piano prestabilito dal capo di essa, che inventava la favola, la scompartiva, designava i personaggi, tracciava i dialoghi, lasciando alla facoltà ed abilità di ciascuno quel che dovessero dire e come dovessero dirlo, più tardi il capo di essa, D. Biagio Perez, anima intellettiva della Compagnia, ideava e scriveva le sue farse o commedie, le faceva imparare a memoria dagli indotti artisti e ne dirigeva la esecuzione. Fecondissimo compositore costui, che, aggirandosi di continuo per i cortili, i vicoli ed i luoghi dove l'elemento più modesto delle città, uomini e donne, viveva, chiacchierava, litigava, ad esso attingeva gli argomenti, gl'intrecci, le forme del suo teatro.
Il segreto della fortuna era riposto nella caricatura del benestante provinciale, stravolto ed avaro, detto Barone, nel ridicolo, a piene mani gettato sul notaio messinese e nella somma abilità del celebre Marotta (celebre lo dicono i diaristi d'allora), che con impareggiabile verve sosteneva le parti di Nòfriu, facchino sciocco e beone: tipo stupendo che, nella sua assoluta ignoranza, il Marotta, anche sarto a tempo perso, non cessava di perfezionare ogni giorno oziando presso la Posta dei facchini (Posta di li vastasi), all'angolo della via dei Chiavettieri, dove il nome di lui era in mal repressa avversione come quello che li metteva in continua berlina.
Di questa avversione dà la misura un aneddoto non mai fin qui scritto.
Era d'inverno. Piogge torrenziali aveano ingrossato la solita piena, che per la via Toledo correva al mare. Alla Piazza Vigliena, passaggi in legno molto primitivi attiravano uomini, che da un lato all'altro della catena (marciapiede) trasportassero gl'inabili a traversar la fiumana. Questi uomini erano dei facchini autentici86.
Ed ecco farsi innanzi un robusto omaccione con un uomo a spalla. Toccava già a mezzo la piazza, e la corrente gli giungeva furiosa fin sopra le ginocchia. A un tratto una voce stentorea e minacciosa gli grida: Infame! tu porti Marotta!... e la voce non era cessata, che il volgare san Cristoforo, poco cristianamente buttava giù nell'acqua l'ingrato peso. Il riconosciuto artista si ballottò per un momento tra la piena limacciosa, e dovette ringraziare il cielo se potè cavarsela con quel bagno d'inverno e con i fischi assordanti dei facchini del Cassaro.
Tornando ai personaggi, diremo che il Japicu, padre stupido, veniva a meraviglia disimpegnato dal Richichi, il quale vuolsi abbia sostenuto più tardi la parte di Nòfriu. Catarinicchia faceva da Laura, moglie di lui, vecchia ciarliera ma astuta. Altro giovane, che per la sua figura bionda e sbarbata e la voce muliebre figurava da donna (giacchè il sesso femminile era escluso dalla Compagnia) era il lepidissimo Sarcì, che a certo punto diè il nome alla Compagnia, e che ritraeva la nota Lisa, servetta scaltra e civettuola. Questo Sarcì, per la sua femminilità riuscì una volta ad innamorare un provinciale frequentatore del casotto, il quale però in una conversazione da lui sollecitata restò con un palmo di naso innanzi alla creduta e corteggiata donna. Mario Frontieri faceva da Tòfalu, facchino malizioso, degno riscontro di Nòfriu, dal quale non si scompagna mai nella tradizione. Corpora da Calòriu era un servitore provinciale torto e baggeo e più comunemente il ciancianisi; da Sabbedda, seconda servetta e imprudente, camuffavasi il merciaio Carmelo Ganguzza, che doveva passare poi a sostituire il Sarcì nelle parti di Lisa, quando questi trasformatasi in caratterista; e sosteneva, come non si sarebbe potuto meglio, l'ufficio del notaio messinese D. Litteriu Mario o Carlo Montera, a cui stava da presso altro servo accorto e raggiratore, Gaetano Gulotta, curiale.
Così composta, la Compagnia agiva nel casotto: e la gente accorreva numerosa, assai più che ai due maggiori teatri87, e si divertiva alle facezie, agli equivoci, ai frizzi che scoppiettavano in bocca a questi pittori del dialetto e, non ostante la parte loro prescritta, improvvisatori di dialoghi vivaci e sfolgoranti. Una recita il giorno non bastava più: e a quella, tanto comoda per coloro che avean finito di lavorare ed avevano libero l'intervallo tra la luce del giorno che declina ed il buio che comincia, se ne faceva seguire un'altra di sera. Venuta l'estate, il favore del non colto pubblico imponeva altro luogo più fresco, alla Marina, presso la Garita. Di questo modo il teatro popolaresco si continuava alternandosi per la estate fuori e per l'inverno dentro città.
La vastasata, titolo della rappresentazione, è il nome col quale farse, commedie ed altri componimenti simili, detti anche improntate, corsero fin d'allora, su temi volgari, sovente piazzaiuoli, con personaggi della plebe, a prevalenza di vastasi (facchini). Un esempio pratico e cortigianesco, ma ritraente del genere d'allora, a base di tipi consacrati dall'uso (Nòfriu, Tòfalu, lu Baruni di li Cianciani, Donna Lisa) ce lo diede il Meli (1799) nei Palermitani in festa, farsa che il sommo poeta chiamò vastasata dal genere in voga da un pezzo88.
I costumi eran sempre i medesimi, come i caratteri; non soggetto a molte novità l'intreccio e l'azione. Solo ogni tanto, per nuove vicende e per avvenimenti clamorosi, al tema ordinario se ne sostituiva uno occasionale. Il 30 luglio del 1789 la famigerata Anna Bonanno veniva strangolata nelle più alte forche alle Quattro Cantoniere, ed il 5 settembre seguente, in un casotto della Garita, si assisteva ad una rappresentazione sulla Vecchia dell'aceto, soprannome col quale dovea sinistramente passare alla posterità la infame propinatrice di aceto velenoso. Lo stesso era avvenuto della cattura e morte del famosissimo brigante Testalonga. Per la festa di S.a Rosalia poi era inibita qualunque rappresentazione d'argomento non sacro89 vacanza era il venerdì e riposo assoluto si prendeva nei mesi di ottobre, novembre e dicembre90.
Accadeva talvolta che nelle commedie fossero brevi cantate a due o tre voci; e allora ecco trovato un poeta che le sapeva scrivere secondo il gusto degli spettatori: l'ab. Catinella, a cui le Muse sorridevano lietamente.
Per mancanza di documenti un giudizio sulle vastasate non è possibile, quantunque sia stato affermato conservarsi gli scenoni o scenarî di ventinove di esse, parte inventate, parte rifatte da commedie scritte e adattate dal Perez al nostro teatro dialettale. Checchè ne sia, bisogna contentarsi dei soli titoli, dove è malagevole riconoscere la provenienza letteraria91; ma dove non è difficile indovinare l'assenza della prima, originaria forma del genere, la quale non venne mai scritta appunto perchè primo il Marotta non sapeva scrivere. Gli eruditi del tempo si limitarono a qualificarle, per la loro autenticità, come «le vere bastasate che da più tempo fra noi introdotte in Palermo, riescono accette al popolo»92. Hager, che le vide alla Marina, notò gli uomini travestiti da donne, le parti burlesche eseguite da uno che raffigurava da facchino; scherzi principali, le percosse e gl'inganni; linguaggio, tutto siciliano93. Galt, dopo Hager, trovò tra gli attori «il più popolare, uno che rappresentava il carattere volgare isolano più accentuatamente di quello che si facesse per i caratteri irlandese e scozzese a Londra»94.
Più espliciti i pubblici funzionarî. Pietro Lanza Principe di Trabia, Capitan Giustiziere nel 1793, le diceva «spettacoli di non troppo odorato buono, perchè, per lo più, piene di sentimenti vili [intendi plebei] e spesso indecenti, e che sicuramente non corrispondono al fine per cui si permette la buona commedia, che sarebbe quello di onorare la virtù e porre in disprezzo il vizio». Ma nel 1794 modificava in questo modo il suo parere: «Analizzandosi questa improntata siciliana, comunque sia stata definita per spettacolo di sentimento alquanto indecente, non racchiude nelli medesimi che uno scherzo passeggiero e niuna conseguenza. Il ricorso peraltro in queste improntate suol accadere di persone che si uniscono tali sentimenti. Non si sono mai fatti leciti gli altri in queste improntate di scherzare contro la religione. Le persone poi che dirigono tali improntate sono più che circospette». Concludeva perciò: «Il governo le ha sempre permesse»95.
Giovanni Meli guardava di mal occhio, non già la classe sulla quale era gettato il disprezzo del genere di rappresentazione, ma lo spirito della rappresentazione medesima. Il sentimento delicato del poeta faceva di lui un essere di tempi più progrediti, di idee più elette che non fossero quelle dominanti allora, facilmente, clamorosamente accolte nei teatrini. In una sua nota egli rilevava: «Per comprendere in quanto dispregio sono al presente presso i cittadini gli abitanti dei villaggi delle campagne, basta portarci una o due volte ad ascoltar le commedie nazionali, dove si osserva costantemente che fra li ceti degli uomini, quelli nell'ultima derisione sono i facchini e i contadini»96.
Il successo ottenuto dal Marotta e dal Perez fu così trionfale, e continuò così costante, che fece attecchire un genere fino ad essi forse non tentato, ma senza forse non portato al grado a cui essi lo portarono. Il successo fece gola a molti, e nuovi artisti da strapazzo, e nuovi impresarî da dozzina vollero gareggiare con rappresentazioni del tipo, dato, imposto per opera della così detta coppia grande, che era la compagnia Marotta-Perez. E qui ha principio una pioggia incessante di domande di questo o di quell'impresario per ottenere dall'autorità competente la licenza di teatrini per commedie popolari buone per far divertire il pubblico basso, impossibilitato di assistere ai teatri alti. Le carte della R. Segreteria di Stato del tempo son testimoni di questa gara per invidia di risultati, per avidità di lucri, i quali, dividendosi, doveano per necessaria conseguenza attenuarsi fino alla irrisione. Un casotto alla Marina chiese il permesso di alzare ed alzò nel 1793 mastro Giovanni Pedone; ma non potè, per la scarsezza dell'annata, pagare le 16 onze volute dalla Deputazione per le strade97. Uno «con palchi aperti a tenore dell'ordine reale, per improvvisate siciliane» ne volle pel seguente 1794 mastro Antonino Demma; e come lui, nel medesimo anno, per proprio conto altro ne chiese un certo Pignataro, «per bastasate improvvisate di dilettanti ed altre burlette». Questo stesso sollecitava un Barcellona. Richiesto del suo parere dal Vicerè, il citato Capitan Giustiziere Principe di Trabia non sapeva che fare: e per uscirne mostravasi non molto tenero del genere, «che avrebbe voluto sostituito e modificato con commedie o burlette decenti». Non propendeva per le vastasate, fin lì «con una certa restrizione, come di tre o quattro nel Carnevale e raramente nelle altre stagioni», accordate, e raccomandava il Barcellona, come il più pulito e reputato. Ciò nel giugno del 1793. La parzialità non piacque a nessuno. L'anno seguente, sei nuovi o vecchi impresarî si affollavano per licenze d'altri casotti in Piazza Marina. Stavolta il Capitan Giustiziere era come l'aio nell'imbarazzo. Chi preferire? E se tutti chiedono di eseguire bastasate, come dir male di tutti? L'anno scorso si era lasciato sfuggire quel giudizietto poco gradito; ed ora non avrebbe voluto ripeterlo. Aggiungi che tra i richiedenti c'era la compagnia autentica delle vere bastasate, che si faceva avanti fiduciosa, come sicura della preferenza al Pignataro, trascurato l'anno scorso. D. Giuseppe Marotta, D. G. Sarcì, D. Mario Montera, D. Gaetano Gulotta, mastro Giuseppe D'Angelo, mastro Fr. Corpora pregavano il Vicerè che rinnovasse al Pignataro il permesso al quale pei suoi precedenti aveva un certo diritto. «Alcuni sconsigliati — essi scrivevano — han chiesta simile permissione per loro; ma costoro non hanno la coppia, che ha solo il Marotta supplicante. Pignataro vanta per licenze ciò sin dalla Capitania del Marchese di Giarratana. Ecco perchè questi poveri padri di famiglia si ridussero a scritturarsi con Pignataro».
Il Principe di Trabia, che era uomo di buon senso, prendeva, come suol dirsi, a quattro mani il suo coraggio, e da onesto Capitan Giustiziere favoriva la giustizia alla quale avea diritto questa brava gente, dicendo anche un po' di bene delle bastasate, non ostante il po' di male che ne avea detto innanzi. Marotta trionfava su tutta la linea, ma il trionfo era fortemente contrastato da emuli e da avversarî. Antonino Carini, esercitando un suo casotto nella Piazza Marina, faceva dei lagni contro gl'invidiosi attori della coppia grande, cioè contro il Marotta; ed era costretto a prendere la coppia piccola per superare questi, che essi chiamavano creatori di cabale; e, ad accrescere attrattive, domandava di poter «fare intermezzi con balletti di gente siciliana per maggior godimento del pubblico» (7 gennaio 1795); inutile pretesa, ridotta solo alla concessione di «opere serie ed oneste», ossia di «tragedie sacre per la prossima quaresima» (27 gennaio), concessione del nuovo Capitan Giustiziere, Principe di Galati.
Eppure anche questa riserva suscitava risentimenti. L'impresario del teatro di S.a Lucia, Giuseppe Azzalli, ci vedeva un disvio della sua clientela e richiamavasene all'autorità; ma non capiva o fingeva di non capire che l'uso dei casotti era inveterato, che il Governo li avea sempre favoriti, perchè la maestranza non avrebbe altrimenti avuto un'occupazione dilettevole spendendo pochissimo. «La gente che frequenta i casotti non frequenta il S.a Lucia, osservava giudiziosamente la medesima autorità. I casotti sono sforniti di tutti quei comodi che da per tutto vuol trovare la culta ed onesta gente; e in essi vengono dati degli spettacoli che quanto conciliansi l'immaginazione e soddisfano al gusto del popolo, altrettanto sono incapaci di trattenere le culte ed eleganti persone».
E proseguivano le richieste per casotti da vastasate, di mastro Antonino Lamanna, di D. Fr. Simoncini, di D. Giuseppe Aloj e di non so quanti altri. Il Capitan Giustiziere esaminava e consentiva, e le licenze non mancavano; sicchè il piano della Marina d'inverno, quello della Garita di estate avrebbero dovuto essere ingombri di baracche. Eppure non lo erano se non in parte: perchè primeggiava sempre la vecchia e originaria Compagnia; ai danni della quale, o al miraggio di larghi guadagni, fin due grossi speculatori si fecero innanzi con l'offerta, apparentemente vantaggiosa al Fisco, sostanzialmente offensiva alla libertà, del pagamento di 30 onze annuali pel diritto proibitivo di alzar baracche per commedie popolari (1795 e 1796).
E di che non si domandava monopolio, e quindi diritto proibitivo?
Ma tra tanti casotti che sorgevano e sparivano, tra tante compagnie di comici con programmi rigorosamente siciliani tendenti a mettere in evidenza i costumi e la vita del popolo, quella del Marotta e del Perez era sempre favorita e coperta di applausi. Lì era il genius loci, il creatore e, se vuolsi meglio, il restauratore di un teatro che rispondeva al momento storico, e che ritraeva caratteri non mai fino allora con parola più incisiva, più colorita, più affascinante saputi cogliere ed incarnare. Questo genius loci, giova ripeterlo, era il Marotta.
Ultimo e non indegno avanzo della vecchia Compagnia, Mario Montera proseguiva molto più tardi i miracoli artistici del suo bel tempo. Giovedì 25 dicembre del 1824, sui soliti luoghi di affissione di «Leggi ed Atti della pubblica Autorità» si leggeva il seguente:
Il genio, la tendenza naturale ai leciti ed onesti divertimenti, di questo cortese non meno che dotto pubblico hanno indotto il Capo comico Nazionale Mario Montera a riunire una compagnia di tutti nazionali atta ad esporre le solite burlette antiche in lingua nazionale, ossiano vastasate: e prevj i dovuti permessi, ha fatto erigere un teatrino nella via Bottari, il quale sarà titolato «Il Teatrino della Compagnia siciliana».98
Il domani di Natale ebbe luogo la prima rappresentazione, alla quale altre ne seguirono negli anni dipoi quando Ferdinando II di Borbone, venuto a Palermo, ne intese parlare come di spettacolo tutto siciliano, che aveva pieno riscontro con quello di S. Carlino. Egli, che palermitano si ricordava di essere, e in Napoli era cresciuto e vissuto, non seppe resistere alla tentazione di vederlo: e lo vide. La commedia nazionale, la vastasata, era allora entrata (e forse fu distinzione d'un quarto d'ora) nel S.a Cecilia: ed il Re ci si divertì molto. Poca cosa parve l'intreccio; deficiente la catastrofe; «ma il dialogo, animatissimo; sorprendente l'attitudine dei comici, che in sostanza eran del volgo, e gli abiti ben il mostravano; e il dialetto talmente siciliano da rendersi difficile per gli stessi uditori siciliani, non che per un forestiero. Il Sovrano credette i comici più naturali di quelli che erano a S. Carlino, e ben credea»99.
Fu l'eco tarda ma pur sempre sonora e gradita di una voce che per lunghi anni avea tenuto desta l'attenzione del popolo palermitano nel secolo precedente, e che facetamente lo avea giocondato.
Tre anni dopo, sotto la lettera V del Nuovo Dizionario siciliano di V. Mortillaro si leggeva per la prima volta la voce vastasata con questa spiegazione: «rappresentazione teatrale, che espone fatti popolari e ridicoli in lingua nazionale, sovente aggiungendo nel momento ciò che credono i recitanti a proposito, senza stare rigorosamente ai detti del suggeritore».
Di questo teatro, nulla, proprio nulla ci resta: dolorosa constatazione, che non ha il conforto di una prova contraria.
Che cosa è avvenuto delle due o tre dozzine di canevacci di commedie o anche delle commedie sceneggiate o scritte? Noi lo ignoriamo; ma se dobbiamo giudicare dall'unica che ci resta, il Curtigghiu di Ragunisi, quel teatro dovette rappresentare non solo il momento storico dianzi affermato, ma anche il momento sociale e letterario del nostro paese.
Il momento passò, e nè la storia civile, nè la storia letteraria dell'Isola seppe fissarlo in un giudizio che a' ricercatori del passato desse ragione esatta di un titolo volgare, assurto alla importanza della commedia dell'arte tra noi.
Non è guari la stampa palermitana, siciliana, italiana e financo estera a proposito d'un forte artista catanese e d'un valoroso scrittore di scene della vita del nostro popolo, diceva che noi non avevamo mai avuto un teatro dialettale: primo, anzi unico esempio, quello che si affermava sui teatri dell'Isola e del Continente col Grasso, coi suoi abili compagni e con l'esperto autore drammatico che dirigeva e presto tornerà a dirigere la comitiva. Quella stampa ignorava la storia di casa nostra, aggiungendo un altro ai cento errori ond'è purtroppo pregiudicata la conoscenza delle cose di Sicilia. No, non è vero che noi non avemmo mai un teatro popolare siciliano! Se poi il vecchio teatro siciliano si vuol paragonare col nuovo, probabilmente per trarne ragioni sfavorevoli al vecchio, allora si manca dei criterî elementari per giudicare che altro era il settecento, altro è il novecento, anzi manca addirittura uno degli elementi del giudizio. Un teatro dialettale, come abbiamo veduto, vi fu, e si credette così proprio e caratteristico della Sicilia che da tutti venne appellato nazionale: e commedie nazionali furon dette le vastasate, sì perchè la Sicilia era pei Siciliani una nazione, e sì perchè pei dotti di essa, specialmente nel sec. XVIII, il dialetto voleva levarsi a dignità di lingua100.
E questa è storia!
Spettacoli avventizî si vedevano nelle diverse stagioni dell'anno, e curiosi d'ogni classe vi godevano ora una mostra di dromedarî, di leopardi e di fiere africane ad essi ignote, ora macchinette automatiche e balli di orsi, ora giuochi atletici giammai visti, e stimati impossibili a forza umana, ed ora marionette d'una ingegnosa compagnia lombarda.101. Nel maggio del 1788 il patrizio palermitano Agostino Chacon dei duchi di Sorrentino esponeva statue parlanti, che sarebbero una meraviglia anche oggi non che al tempo che sorpresero V. Torremuzza102. Mentre Giustino Materangelis lucchese divertiva con fantocci curiosissimi, il napoletano Crispino Zampa eseguiva con altri fantocci di sua opera commedie, tragedie ed altre cose teatrali103. V'era la riproduzione d'un bucintoro che chiamava gran numero di visitatori, e v'era un nano tedesco, che la madre presentava sotto il palazzo Cesarò, rimpetto il Salvatore, contro pagamenti diversi secondo che i visitatori fossero nobili, civili e di bassa gente.
CAP. V.
I MUSICI E LA LORO UNIONE. MUSICATE, ORATORII, CANTATE, DIALOGHI.
La passione pel teatro derivava in parte dalla passione per la musica, come in tutta l'Isola così nella Capitale.
Antica era in Palermo la Unione dei Musici (1679), fratellanza alla quale erano ascritti quanti «come strumentarii», o come cantanti, o come maestri, coltivassero l'arte dei suoni.
La chiesetta di essi, dedicata a S.a Cecilia, loro patrona, scompariva al sorgere del teatro di questo nome (1693), destinato alle opere musicali. Da quella Unione si direbbe partito il movimento artistico di questo genere in Sicilia; ad essa mettevano capo le esecuzioni musicali profane e sacre, di camera e di chiesa, pubbliche e private, dalle più modeste alle più solenni. Nel settecento i migliori componenti della Unione venivano dal Conservatorio del Buompastore.
In virtù di una bolla pontificia una metà dei fanciulli di questo Ospizio si consacravano alla musica vocale e strumentale, ed eran facili a distinguersi per una specie di lunga veste e per un mantello di panno turchino, che li copriva; onde il titolo di turchini.
Ogni anno, la mattina dell'11 luglio, usava dagli alunni cantare pel Cassaro in onore di S.a Rosalia un inno composto da uno di loro, e con questo canoro spettacolo s'inaugurava il festino. Giuseppe Licalsi e Carlo Mellino (1785), Raffaele Pepi (1786), Leonardo Giliberto (1788), Michele Rocco (1793), Domenico Spadafora e Raffaele Russo (1795-1797), Ignazio Taranto (1796) sono tra quelli che nello scorcio del secolo musicarono codesti inni, ispirati da gentile sentimento di devozione e forse da un po' di vanità.
Ma altri e più noti legarono i loro nomi all'annuale omaggio; e la lista è onorevole per l'arte in Sicilia. Vi sono Giuseppe Amendola, prescelto a scrivere la messa solenne pei funeri del Vicerè Caramanico (1795); Giuseppe Calcara, che più tardi, nella trasformazione del teatro S.a Lucia, musicò un'opera del Carolino; Michele Desimone, che rivestì di note (1799) un coro di Siciliani per la venuta dei Reali in Palermo, e quel Giulio Sarmiento, vice-Maestro della Cattedrale, che al S.a Cecilia si affermò con l'arguta sua opera i Tre Eugenj. Il favore del pubblico accompagnava sempre Salvatore di Palma, autore della pietra simpatica. Francesco Vermiglio, Maestro di Cappella straordinario del Senato, godeva non immeritata fama; e si levavano sopra tutti per opere illustri ed eminenti ufficî Michele Mantellone, che con l'Ezio (1777), la Semiramide (1785), la Troja distrutta (1778), l'Armida (1786) fece ammirare all'estero il genio musicale della sua Palermo; e, sopra di lui Francesco Piticchio, che, ricco degli allori raccolti in Dresda con gli Amanti alla prova (1784); con la Didone abbandonata (1786), in Brunswick; con Il Bertoldo (1787) qui pure passava ai servizî di S. M., mentre Benedetto Baldi, nell'aureola del suo valore artistico, conseguiva l'invidiabile onore di Maestro di cappella di Lady Hamilton; onde poteva nella palazzina De Gregorio al Molo quasi ogni giorno contemplare le grazie largite a lei dalla natura e la potenza onde la facea grande l'amor cieco e non incolpevole di Lord Nelson.
Semenzaio di musicisti, il Conservatorio trovava ragione di sviluppo e di continuato incremento nelle funzioni religiose, nelle cantate profane, nelle feste nobiliari e nelle popolari. La vita fiorentissima degli ordini religiosi portava con sè una lunga sequela di quasi giornaliere funzioni chiesiastiche, fonte di non laute ma sicure mercedi. Frequentissimi gli oratorî e gl'inni per santi e per sante, nei quali poeti, compositori, sonatori, cantanti, tutti avean da guadagnare; periodiche le commemorazioni di avvenimenti sacri, festeggiamenti per celebrazioni di pietose leggende; incessanti le monacazioni e le professioni di voti nei monasteri: e in questi e nei conventi e nelle confraternite vespri e messe cantate, funerali e tedeum. È stato rilevato che nella sola Messina ben centocinquanta giorni dell'anno erano feste patronali104.
Non lasciamo andare senza qualche parola gli oratorî. Le tipografie ne stampavano e ristampavano sempre. Per la sola Congregazione di S. Filippo Neri c'è una ricca collezione del Solli, stata messa abilmente a profitto a larghi intervalli105. Per tal modo, il vecchio, dopo il silenzio di alcuni anni, ricompariva come nuovo, e Il trionfo di Giuditta davasi la mano con Il trionfo della Religione; La morte di Assalonne con La morte di Saulle o con La morte di Sansone, Sisara con Sedecia, Abramo con Giacobbe, e l'uno e l'altro con Atalia. La Passione di N. S. G. Cristo, «poesia dell'Abbate Pietro Metastasio romano», commoveva nella «musica del sig. Giovanni Paisiello, Maestro di cappella napolitano»; i Pellegrini del sepolcro di N. S. «del sig. D. Stefano Benedetto Pallavicini» con quelli «del celebre sig. D. Giovanni Rodolfo Hasse, detto il Sansone». Raffaele Russo, il Guglielmi, Federici creavano quando buone quando mediocri note su poesie del Pallavicini e del Metastasio, del cesenate Fattiboni, del siciliano Gaetano Salamone e di altri di minor conto. Il Piticchio stesso, non ostante l'alta sua posizione artistica ed economica, non negava l'opera sua, perchè i compensi dei padri Filippini dell'Olivella facevano gola a chicchessia.
Il dramma ora sempre diviso in due parti per due giorni diversi. Chi ne legga oggi con attenzione qualcuno, vi scoprirà forse uno strano accomodamento a musica anteriore. In uno il poeta confessa di avere ridotto «i sentimenti di un dramma profano per cui era composta la musica ad un oratorio sacro»106: delittuoso stratagemma non unico nè raro.
L'omaggio che rendevano alla Santa gli alunni del Buompastore lo rendevano egualmente i musicisti adulti della Unione: omaggio compartito in frequenti cantate o sinfonie secondo le fermate nel Cassaro, e chiuso con la generale comunione che essi andavano a prendere alla Cattedrale. Siamo alla vecchia frottola, nome che parrebbe non doversi intendere come canzone piuttosto volgare, ma in significato diverso stando almeno all'uso che se ne facevano. Un diarista, annunziando la funzione, scriveva: «12 luglio 1779. La flotta dei musici andò a farsi la comunione al Duomo dando luogo a diverse cantate o sinfonie» 11 luglio 1780: «flotta dei musici della Unione di S. Cecilia per il Cassaro»107: donde il sospetto che non si tratti di una frottola poetica, ma di una frotta, di una moltitudine, di persone che andavano cantando un inno, una canzoncina. I Capitoli della Unione però nell'indicare questo espresso dovere, volevano che tutti li virtuosi musici così cantanti come strumentarj di tasto, d'arco e di fiato e maestri di cappella abbiano da intervenire all'offerta... cantando e suonando la frottola, ripieno da cantarsi nei luoghi designandi dal Superiore»108.
Agli eruditi la spiegazione d'un vocabolo, che in conclusione potrebbe aver avuto due significati.
Guardando qualche vecchio disegno della piazza Ottagona o Vigliena nella ricorrenza di eccezionali solennità, si scorgono quattro palchetti gremiti di virtuosi. I disegni illustrano i testi e ne sono alla lor volta illustrati: e i testi appunto descrivono gli artisti, altri a sonare ed altri a cantare incessantemente. Ne abbiamo per la entrata di Carlo III (1735); ne abbiamo per le feste di S.a Rosalia; e di molto prima (1711), ne abbiamo per la vittoria di Filippo V di Spagna sopra l'esercito degli alleati. Un poeta siciliano italianizzando cantava:
Nell'ottangula piazza insemi accampaDi canora assemblea quattru parchettiRemora duci in cui cu' passa inciampa109
Certo non eran sirene incantatrici questi cantanti, ma confermavano la inclinazione loro alla melodia ed il largo esercizio dei cultori di essa. Come poi il lettore potrà vedere verso la fine di questo capitolo, molti signori facevano della scelta musica di componimenti lirici e drammatici nelle loro ville e nei loro palazzi.
Con siffatti mezzi molteplici ed utili a dar da vivacchiare, il mestiere di virtuoso, messo in dubbia luce dal vieto motto: musici et cantores miserrime vivunt, rendeva qualche piccola cosa. I salarî annuali erano un'irrisione; e basta dire che per le messe cantate di S. Rocco e di S. Sebastiano il Senato pagava tre onze e due tarì, e «per l'associo del Divinissimo il giorno del Corpus Domini» quattr'onze e dodici110; ma tanti pochi fanno molto, e ciò basta perchè i musicisti crescessero a dismisura.
Il Santacolomba, Direttore del Conservatorio, vedeva ogni giorno un caffè d'allora nella Piazza Vigliena, «frequentato soverchiamente da questi fertili professori» e ne avrebbe voluto scemato il numero111.
L'ultima riforma dei Capitoli dell'Unione dei Musici (1762) si vede soscritta da 104 confrati, oltre dieci altri aggregati posteriormente. Un esemplare di questi Capitoli, appartenente alla Unione medesima, ha delle annotazioni sulle quali occorre fermarsi un momento112. Parecchi confrati erano sacerdoti, forse organisti, od anche cantanti di chiesa. Alcuni aveano lasciato la Sicilia e non si sa per quali regioni d'Europa vagassero. Uno, Ippolito Papania, trapanese, sonatore d'organo e di violino, bandito, andava ramingando fuori regno. Longevi non pochi di essi, morti uno ad 86 anni (D. Francesco Lanza), uno ad oltre 90 (D. Giuseppe Sardella), uno a 100 (D. Giuseppe Biundo). Farà certo meraviglia il sapersi di quattro cantanti (D. Giovanni Anghirelli, probabilmente non siciliano, D. Girolamo Spina, D. Agostino Dulena, D. Saverio Scivoli), spadoni. La notizia, non nuova affatto per la Sicilia, viene da fonte ufficiale, e non ammette dubbio. Anzi è detto che uno di questi quattro, lo Scivoli, occupava l'alto ufficio di Unito maggiore, cioè di Superiore, e che dei suoi sciagurati consorti in spadoneria, non uno ebbe lunga vita, essendo tutti morti giovanissimi, dai 24 ai 30 anni di età. Quando poi si sappia che tra i cantanti erano delle voci femminili di sopranini e contralti, ci vuol poco a supporre la esistenza di quei disgraziati; i quali peraltro venivano ufficialmente ammessi dalle antiche Costituzioni del Conservatorio del Buon Pastore113, e rimasero in un motto di dispregio, divenuto oramai storico114.
Questi confrati per altro, in virtù del riconoscimento della loro Unione da parte di tutti i Vicerè succedutisi dal 1679 alla fine del sec. XVIII, aveano obblighi e diritti che fanno pensare al altre corporazioni del tempo. Se prima pagavano onza una e tt. 18 di entrata e tarì 3 il mese, ora, nello scorcio del secolo, per le comuni strettezze ne pagavano 9 di entrata e tre carlini di contribuzione. Possedevano gioie, argento, coltre, stendardo, e ne facevano sfoggio negli accompagnamenti funebri. Ammalati, se non eran debitori verso la Compagnia, avean diritto alla assistenza sanitaria, a quella dei loro infermieri, ad un sussidio temporaneo. Per le vie non potevano associare altri cadaveri fuori di quelli dei loro confrati, sotto la pena fortissima di 30 onze di multa. Alle spese occorrenti per l'annuale oratorio in onore della protettrice S.a Cecilia potevano far fronte con gli introiti del Teatro di loro proprietà, come a quelli per la offerta di S.a Rosalia con gli «introiti delli lucri d'organi ed orchestra»115.
Privilegio, se non singolare, raro, quello del Foro proprio, rappresentato dall'Auditore generale, abilitato a decidere «così per l'osservanza dei Capitoli come per l'occorrenza di tutti i virtuosi musici accollati in detta Unione tanto attive quanto passive»116.
La Calata dei Musici, rimpetto la fontana Pretoria, sul Cassaro, luogo di convegno ordinario, era tuttodì piena di siffatti virtuosi. Vi avresti incontrato maestri valenti di musica e soprani, contralti, tenori, e bravi strumentisti e strimpellatori della peggiore specie, ai quali, dal più al meno, erano familiari l'oboe ed il violino, il fagotto e la tromba, il flauto ed il corno di caccia, la chitarra francese, il mandolino ed il contrabbasso, oltre l'immancabile organo ed il prediletto cembalo117.
Con la venuta del reggimento degli Svizzeri di Jauk si videro per la prima volta i piattini di metallo, certi particolari tamburi e timpani e triangoli, e ne fu lieta occasione una sontuosissima festa del Principe di Resuttano (1769)118. Questi strumenti di recente introduzione aveano chi sapesse maestrevolmente maneggiarli ed ingrossavano la falange dei sonatori nelle orchestre e nelle bande. Se poi il Senato non si risolveva ad aggiungere neanche uno ai dieci musici ordinarî della guardia pretoria, non fa nulla: altri istituti aveano di che vantarsi di nuovi strumentisti.
La musica del teatrino senatorio nella Marina dal giorno di S. Giovanni (24 giugno) alla Esaltazione della S.a Croce (14 settembre) per tutte le sere di estate ricreava ogni buon palermitano119.
Per alcuni anni tra una sonata e l'altra del teatrino, la Domenica, ve n'era sul mare, in un gozzo carico di sonatori da fiato, che con dolce lentezza solcava le acque d'argento come barca di fate in un lago incantato. La chiamavano notturna, e ne rendevano illimitata lode al senatore Barone Calvello, delegato per la musica cittadina120. Nella Villa Giulia altra banda musicale, già nota ai nostri lettori, per legato perpetuo del Principe di Paternò attirava uditori appassionati, come nelle sere d'estate donne ed uomini non invitati da nessuno s'abbandonavano al canto di deliziose ariette121.
E alla Villa Giulia e alla Marina il numero dei sonatori accrescevasi mano mano che si entrava e progrediva nel nuovo secolo. In poco volger d'anni eran già ventiquattro: direttore il Vermiglio, che pezzi proprî e del Piticchio non cessava di regalare ai sempre numerosi uditori. Più in qua, tra un pezzo e l'altro si canteranno, con accompagnamento di mandolini e di chitarre, le solite canzonette siciliane. La gente seria d'oggi rimarrà scandalizzata della profanazione del palchetto municipale per via di queste canzonette dialettali; ma i nostri nonni non ne rimanevano niente impressionati: anzi ci si divertivano come ricreazione naturale e paesana. Nelle grandi feste pubbliche l'intervento di questa banda musicale sarà sempre salutato con plauso, e non vi mancherà il quartetto a corda (violino, violoncello, viola, contrabbasso) nelle ricorrenze ecclesiastiche più solenni.
Per questo beninteso amore all'arte dei suoni molte case signorili tenevano per propria ricreazione un'orchestra. La Resuttano era di queste: perchè il Principe nudriva un gusto squisito d'arte, come una intelligente predilezione per le lettere.
Altri patrizî eccellevano in cosiffatto gusto: e si ricordano a titolo di lode Carlo Cottone di Castelnuovo, Girolamo Grifeo di Partanna, Gian Luigi di Paternò, Pietro Lanza di Trabia ed altri maggiorenti della Nobiltà.
Nei palazzi, continua era l'eco di dialoghi e di cantate, occupazione geniale di maestri abilissimi e di dilettanti esperti. I salotti della più eletta cittadinanza risonavano della miglior musica del tempo, canto e pianoforte, sovente con accompagnamento dei soli strumenti obbligati ad arco, disimpegnati anche dagli alunni del Conservatorio del Buompastore. Il signor Hager non potè mai dimenticare in Vienna le nostre chitarre ed i nostri mandolini. Graditi sempre gli autori più illustri. Piticchio si alternava con Alessandro Scarlatti, Zingarelli con Guglielmi, Paisiello con Cimarosa. Via via che la musica piegava a forme nuove, le più intelligenti famiglie si affrettavano ad accoglierle. Ogni repertorio privato si arricchiva di arie e di madrigali, di canzonette e di romanze, produzione manoscritta che si diffondeva per copie, tenute poco men che originali. Le molteplici vicende delle famiglie hanno disperso tanto tesoro di studio; ma sopravvivono parecchie centinaia di volumi nella Biblioteca del R. Conservatorio di Musica.
Non era artista di canto o di strumento che non trovasse ammiratori e protettori. Un violinista celebre, venuto di Terraferma, col pagamento di tre tarì a persona dentro il refettorio del convento della Gancia diede un'accademia e potè contare sopra un introito netto di trent'onze. Chi avrebbe sognato allora che per accademie simili si sarebbe pagato un giorno sette volte di più!
Un Giuseppe Calcagni cantante, al S.a Cecilia allietava con un trattenimento di arie, rondeaux, concerto di strumenti, duetti, ecc.122. Altri ed altri ancora trovavano accoglienze oneste e liete; sì che Antonio Solli veneziano, impareggiabile sonatore di violino per le corti d'Europa, negli ultimi anni di sua vita sceglieva Palermo come sua seconda patria, «non indegno di stare accanto al maggior sonatore d'arpone che si fosse mai sentito», il palermitano Michele Barbici, di cui dopo il 1769 «si sonarono in Napoli o altrove con gran plauso i trii ed i quartetti»123.
CAP. VI.
LA BOLLA DELLA CROCIATA.
«Nel 1556 i Sovrani di Sicilia ottennero dai pontefici il privilegio di vendere e distribuire le bolle di Pio IV nella occasione della guerra contro i Mori. Per gratitudine di questa concessione Filippo il Prudente fece un'annua assegnazione alla fabbrica di S. Pietro in Roma di scudi romani 1666».124
Sulla fine del sec. XVIII col pretesto che si dovesse dar la caccia alle galere turchesche, gl'introiti di questo privilegio li volle per sè Re Ferdinando, il quale sapeva bene quel che voleva, perchè quegl'introiti costituivano una bella sommetta.
L'acre Giuseppe Gorani nel 1794 scriveva che la Sicilia pagava per questo quarantunmila ducati all'anno125. Se dicesse la verità, sel veda chi ha modo di approfondire questa forma, poco o niente finora studiata, di sfruttamento governativo dell'Isola. Più tardi, nel 1813, l'Ortolani affermava lo introito annuale delle bolle 45000 onze, pari a ducati 135 mila; e senza dubbio egli parlava della Bolla in tutta la Sicilia e non nella sola Palermo.
Questa cifra, per chi vi si fermi sopra con attenzione, è molto interessante. Quarantacinque mila onze valevano mezzo milione di bolle; e mezzo milione di bolle rappresentavano cinquecentomila Siciliani sollecitanti la licenza dell'uso delle carni, delle uova, dei caci, del latte ecc. La popolazione d'allora, in tutta l'Isola, era di 2 milioni; sicchè una quarta parte di essa cercava di mettersi in regola con la chiesa, con la propria coscienza e anche col proprio stomaco per quanto poco fosse esigente. Poteva, è vero, partecipare alle ragioni dell'acquisto il timore di essere scoperti trasgressori d'un precetto chiesastico, che è quanto dire civile e magari politico; ma al religioso non prevaleva certamente il timore delle pene corporali dell'autorità civile e politica. Nessun credente, nessun suddito fedele di S. M. avrebbe sognato di sottrarsi al compimento dei più elementari doveri religiosi, nei quali pietà, devozione, culto si confondevano in un pensiero indefinito, in aspirazioni ataviche molto vagamente mantenute. Se poi questo pensiero fosse espressione fedele d'un sentimento schiettamente religioso, non è luogo opportuno d'indagare.
Vicerè il Marchese Caracciolo, un real dispaccio del 15 febbraio 1783 aboliva l'intervento senatorio alla solenne proclamazione della Bolla; ma un dispaccio posteriore lo ripristinava. Così, mentre si manteneva intatto il divieto precedente, della partecipazione del Magistrato civico alle quarantore del Monte Pellegrino (14 settembre), tornava ad imporsi quello della grande festa della Bolla126, evidentemente perchè se ne accrescesse la pompa, e con la pompa le entrate a beneficio del Sovrano.
Ed ecco, come pel passato, questa cerimonia nelle domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima, ripetersi con tutto l'apparato religioso, civile e militare, onde per lunghissimo volger d'anni era stata accompagnata.
Trattavasi della pubblicazione d'un indulto pontificio a favore di chi per ragion di salute volesse in quaresima cammaràrisi, cioè mangiar di grasso. Ma questo indulto, che pur concedeva beneficî religiosi non comuni, portava con sè qualche obbligo materiale e spirituale in chi lo cercasse. Egli dovea per l'acquisto della Bolla, cioè della licenza, 52 grani (L. 1,11) e compiere speciali pratiche devote, visitando in dati giorni, per un dato numero di volte, alcune chiese designate.
Per ciò appunto l'opera del Senato era non che cercata ma voluta. Il gonfalone della SS. Crociata veniva sorretto da un prete, avente allato un tesoriere (erario) dell'Arcivescovo, il quale portava in mano una bara, entrambi, prete e tesoriere, eran preceduti da dodici chierici, o jàconi rossi (russuliddi), in cotta.
Non ostante che adusato a cosiffatti spettacoli, il pubblico grosso e minuto s'affollava innanzi al palazzo arcivescovile, ove la lieta novella dovea primamente darsi. Tamburini e trombetti senatorii, agli ordini del Cerimoniere del Senato, ad un cenno di lui sonavano: e D. Girolamo De Franchis con chiara e roboante voce leggeva: Il Sommo Pontefice si è degnato concedere l'uso dei latticini e delle carni nella prossima Quaresima. Ma perchè il Cerimoniere del Senato e non altri dell'Amministrazione della SS. Crociata? Perchè il Senato entrava in tutto e per tutto, ed il suo Cerimoniere stavolta era anche Banditore.
La cavalcata (giacchè tutta questa gente andava su muli e cavalli che richiamavano a quello dell'Apocalisse) sfilava verso il Palazzo vicereale. Al corpo di guardia, Don Girolamo rileggeva, e tosto, per la piccola piazza (Chiazzittedda), via di Porta di Castro e Ponticello, fino al Palazzo Pretorio. Terza lettura e terza ripresa di via, stavolta per l'abitazione del Tesoriere della Crociata, donde, dopo una quarta ed ultima lettura, alla Cattedrale ordinaria o provvisoria. Allora le tre autorità principali potevano esser soddisfatte dell'omaggio reso loro; ma il Tesoriere lo era più di tutte, e per quei giorni non capiva nei panni.
Così preannunziata, la Bolla veniva più tardi, in un gran foglio stampato, con ogni maniera di solennità, condotta in giro pel Cassaro. Il Senato in carrozza, e dietro ad esso, ufficiali nobili s'avviavano alla graziosa chiesa di S. Francesco d'Assisi. Quattro canonici lo ricevevano alla porta; il Cerimoniere gli esibiva l'acqua santa; i tamburi e lo stendardo col Crocifisso dipintovi sopra si mettevano in moto; gli Orfani dispersi, gli Orfani di S. Rocco, i frati Conventuali, i Chierici del Seminario, seguivano, e con essi il Capitolo col suo araldo, i tre vivandieri, uno dei quali in cappa magna con un quadretto della Madonna in mano. Penultimo gruppo: jàconi rossi, paggi del Pretore e del Vicario, e in mezzo, con la tanto celebrata Bolla, in insegne canoniche, il Ciantro, fiancheggiato dall'Assessore e dal Maestro Notaro della Crociata.
Ultimo gruppo: Mazzieri, Maestro di Cerimonie del Senato, Senatori coi loro ufficiali nobili e civili, contestabili e trombetti e sonatori di oboe e lunga tratta di gente.
Entrati in chiesa, tutti erano al loro posto. Ad un lato il Vicario generale o il Ciantro; all'altro, il Senato. Inchini rispondevano ad inchini: e quando tutto era in ordine, e fin la Bolla appesa innanzi al Crocifisso, la cerimonia aveva il suo epilogo in una gran messa, intramezzata da un sermone, che celebrava i beneficî provenienti dallo indulto stato concesso.
L'incarico di questo sermone era ambito e sollecitato anche da predicatori sommi. Il Senato, che soleva far sempre le spese, stavolta (rara eccezione) non ne faceva nessuna; bastandogli solo di metter di suo la pompa pretoria. Chi pagava invece era l'Amministrazione della Crociata, la quale compensava il panegirista dell'opera con quattr'onze d'argento (L. 51), una risma di carta bianca (di quella che oggi si dice protocollo), un mazzo di penne d'oca e cinque copie della Bolla: un bel regalo davvero!
Una volta il predicatore designato non comparve. Era già l'ora della funzione, e tutti si guardavano in viso tra maravigliati del ritardo e contrariati che non si potesse udire la tanto attesa orazione panegirica. Ed ecco farsi innanzi verso il Commissario un sacerdote, ed offrirsi di supplire il ritardatario. L'offerta, manco a dirlo, è subito, ma non senza una tal quale diffidenza, accettata. Il ben arrivato ecclesiastico sale sul pergamo e fa una orazione del seguente tenore: «Sua Santità, inesauribile nelle sue grazie, ne ha concesso una, cristiani dilettissimi, che non ha l'eguale nel mondo universo: ha accordata la Bolla, per poter ogni fedele cammàrarsi, e con questo, ha pure mandata la indulgenza plenaria. Così egli ha aperto, ma che dico io aperto? spalancato il tesoro delle celesti grazie. Per questo tesoro non v'è prezzo. Eppure, se sapeste, uditori umanissimi, quanto poco si paga una parte di questo tesoro, la Bolla della SS. Crociata! Ditelo voi!... Forse cent'onze? No: figli miei; non si permette cotanto dispendio. Forse cinquanta?... Neanche. Lo pagherete venti, dieci onze? Neanche questo. Potreste allora pagarlo cinque; ma la inesauribile carità del Padre dei fedeli non può consentire a tanta spesa. E allora nè cento, nè cinquanta, nè venti nè dieci, nè cinque, si potrà pagare un'onza. Oibò, neanche la metà, fratelli dilettissimi, neanche un quarto d'onza! Sbalordite! Tanto tesoro, che vi consente di mangiar carne e latticinî durante la prossima Quaresima, tanto tesoro si paga solo cinquantadue grani!....»127.
Contro l'ammonimento consacrato nel solito cartellino attaccato alla porta delle chiese:
Se vuoi placar di Dio la maestate offesa,Sta con silenzio e riverenza in chiesa.
uno scoppio d'ilarità risonò per le ampie volte del tempio. Il vecchio Arcivescovo Mons. Sanseverino strinse con forza le labbra; il giovane Pretore Duca di Cannizzaro sorrise con tutto l'Eccellentissimo Senato: e le quattr'onze in argento, e la risma di carta, e le penne d'oca, e le cinque bolle furono con inusitato piacere mandate fino a casa dell'arguto o semplice oratore. Egli se le era ben meritate!
Abbiamo detto che il Senato faceva sempre le spese: e dobbiamo un chiarimento della nostra affermazione.
Le funzioni non solo profane ma anche sacre erano senza numero, ed il Comune non poteva disinteressarsene. Lasciarne passare una senza concorrervi operosamente, che è quanto dire spendendo, era un'offesa alle tradizioni religiose della Città. Molte cose abbiam trovate in proposito rovistando vecchie carte d'archivio: e più volte ci è venuto sulle labbra l'antico motto: Cappiddazzu paga tuttu! Senza uscir di sagrato, ricordiamo che per le processioni senatorie per quelle delle chiese secolari e regolari la sola cera impiegata ammontava a poco men che diciotto quintali (presso a chil. 1440), la quale al prezzo di tarì 8, gr. 12 il rotolo (L. 365 il chil.) raggiungeva la cospicua cifra di circa milledugentotre onze (Lire 15.325,50), divenuta un terzo di più nel 1808 per l'aumento di prezzo del genere. Nè c'è da sospettare di arbitrî di senatori, o di compiacenze verso preti e frati, perchè quella dozzina e mezza di quintali di cera era stata, come ultima ratio, ritenuta spesa obbligatoria dalla famosa Riforma governativa del 1788128.
E lasciando altri particolari, torniamo alla Bolla.
Al domani della funzione, questa veniva messa in vendita. Ogni buon padre di famiglia si affrettava a provvedersene, e ad apporvi il proprio nome, recitando a tempo e a luogo alcune orazioni, e pregando non solo pel Sommo Pontefice, ma anche pel Re, che, a conti fatti, era l'unico beneficato, come quello che si scroccava somme colossali, e benedizioni, non si sa quanto sincere, dei suoi sudditi.
Il desiderio di mangiar di grasso stuzzicava sovente i cittadini a procurarsi in varie guise l'autorizzazione del cibo proibito.
Abbiamo in proposito un documento abbastanza curioso e molto caratteristico. Gl'impiegati tutti, dal nobile Spedaliere al guattero della cucina, dell'Ospedale celtico di S. Bartolomeo (oggi Istituto dei Trovatelli) e di altri spedali e spedaletti della Città, il dì 6 febbraio del 1799 si rivolgevano al Cardinale Arcivescovo di Napoli, a ciò delegato dalla S. Sede, perchè consentisse loro, mercè l'acquisto della Bolla, l'uso delle carni e dei grassi per la Quaresima e per ogni altro giorno proibito (vulgo proìbitu) dell'anno. Il documento è questo:
«L'Ospedaleri, li Professori maggiori fisici e chirurgi, li Pratici fisici e chirurgi, l'Infermieri e Cappellani, li Ricordanti, l'Aromatarj, li Maggiordomi, li giovani di assento, li cuochi, li massari, li serventi dell'uno e dell'altro sesso, li lavandare, li P.P. Cappuccini e tutte le persone addette al servigio dell'Ospedale di S. Bartolomeo, l'Incurabili e dell'Ospedale dello Spirito Santo con suoi annessi e dipendenti ospedaletti della città di Palermo in Sicilia, umiliano alla E. V. che havendo supplicato al di loro Arcivescovo di accordargli (sic) in perpetuum la grazia di poter mangiar carne in tutti i giorni proibiti dell'anno, come sono Venerdì, Sabati, vigilie, quattro tempi e quaresima, per essere li viveri di mezzo scarsissimi, per le laboriose fatighe che sono nelli detti ospedali col prossimo pericolo di perder la vita; per altro non spirano se non aere mercuriale, risposegli non aver tale facoltà. Supplicano pertanto V. E. affinchè quale special delegato di S.S. Pio VI gli facesse la grazia accordargli in perpetuum la dispenza suddetta, di poter mangiar carne colle loro famiglie e rispettive commensali in tutti i giorni proibiti di sopra descritti coll'obbligo espresso però di doversi provvedere ogn'uno di essi della Bolla della SS. Crociata. Lo supplicano ecc.».
Si rileva da qui che la grazia volevasi in perpetuo e per tutte le famiglie dei sanitarî, degli ecclesiastici e degli inservienti: privilegio che non aveva esempio nel genere. S. Eminenza esaminò la cosa e concesse129 ma S. Maestà non dovette saperne nulla, altrimenti forse se ne sarebbe risentita come di concessione lesiva degl'interessi dello Stato o, meglio, suoi.
CAP. VII.
QUARESIMALI E QUARESIMALISTI. ESERCIZI SPIRITUALI.
Ed entrava la Quaresima col treno formidabile delle sue prediche.
Il funebre momento era il primo passo verso la reazione ai baccanali. Sulle fronti belle, forse fino a poche ore innanzi sfiorate da ardenti, furtivi baci, cadeva la grigia cenere ad iniziare un periodo di moleste resipiscenze, pausa per alcuni, eternità per altri, soliti a giocondarsi della vita allegra.
Da cento pulpiti, per cento bocche, con pertinacia di sciupata rettorica si lanciavano sugli ascoltatori parole blande e voci roventi, a coprir l'eco tuttora indistinta degli urli dei passati giorni. E le mani si agitavano irrequiete, ora energiche nell'accusare, ora calme nel discutere, ora stringenti nel persuadere, sicure nel promettere e fiduciose nello sperare.
La severità dei richiami poteva, è vero, determinare a rigori corporali; ai quali però la fiacchezza di perseveranza toglieva ogni carattere di profonda convinzione. Come soffocati, recenti ardori intiepidivano; desiderî indiscreti tacevano, ed un senso di misticismo nasceva talora nell'animo di chi meditava: e la meditazione era agitazione di spirito irrequieto, non lontana dal finire in vera, ma effimera contrizione.
Ma noi viaggiamo per un campo fantastico, dal quale, per indole nostra e per la natura schiettamente oggettiva di questo lavoro, ci siam tenuti lontani. Proseguiamo invece per via di fatti la vita dei nostri bisnonni.
Preoccupazione costante, ed insieme occupazione gradita, era quella del quaresimale nella chiesa madre, la quale, come il lettore sa, nell'ultimo ventennio del secolo era provvisoriamente a Casa Professa.
Il Senato non trascurava mai di fare, con la intesa del Capitolo e dell'Arcivescovo, la nomina del quaresimalista, nomina ordinariamente anticipata di otto anni sulla data della recita del quaresimale. Nel 1782 P. D. Felice Testa della Congregazione dei Celestini veniva eletto pel 1790; nel 1783, P. D. Pietro Rottigni somasco pel 1791; nel 1784, P. Alberto Tozzi dei Predicatori pel 1792, e via discorrendo.
Gli è che Palermo, città di primo ordine, Capitale del Regno di Sicilia, dovea pensare bene a chi affidar così grave compito; e chi dovea disimpegnarlo non poteva essere il primo venuto, o l'ultimo arrivato. Palermo avea persone che intendevano, uditorio intelligente e di gusto, che non si contentava, nè poteva contentarsi di chicchessia. Nei suoi pergami eran saliti in ogni tempo i principali oratori d'Italia, chiamati dall'autorità del Senato, allettati dalla riputazione che ad essi veniva dall'eservi saliti, dicitori di merito incontestabile.
V'era poi una ragione considerevole per la oculatezza da mettersi nella scelta: il paragone con i quaresimalisti di altre chiese, nelle quali usava ammirare veri campioni della sacra eloquenza. Il pubblico accorreva alle due chiese come a due teatri: e voleva giudicare de auditu e de visu dell'uno e dell'altro.
Certo non era il quaresimalista d'una parrocchia privilegiata che poteva imporre soggezione. Questo, nominato bensì dal Senato, era un oratore di secondo o di terz'ordine: e solo le deliberazioni del civico consesso ne serbano ricordo. Quelli che davan da fare erano invece i Domenicani ed i Filippini, i quali al predicatore ufficiale della metropolitana contrapponevano i migliori loro soggetti; e se non li avevano del proprio ordine, li facevan venire da altri del clero regolare e secolare pur di averli e di gareggiare. Tanto lusso obbligava a spese, ed i frati Domenicani ed i padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri le facevano per superarsi tra loro.
Anche le monache si volevano mettere in evidenza, ed entravano nella gara: quelle della Martorana specialmente, alle quali tornava graditissimo il trionfo del loro quaresimalista sull'altro del Duomo, come qualche volta ai Teatini di S. Giuseppe dovevano tornare d'infinito piacere i trionfi oratorî della loro chiesa.
Non ostante le mal celate velleità del primato nel genere, due chiese soltanto se lo palleggiavano contrastando anno per anno: la Cattedrale e l'Olivella!
La fama precorreva pomposa i loro predicatori. I devoti, gli habitués, accorrevano numerosissimi ad ascoltarli; volevano studiarne la mimica e la parola, la scienza e l'ingegno, far dei confronti. Il loro giudizio veniva ripetuto per la Città, nelle conversazioni e nei caffè; e la curiosità, come nasceva negli assenti, così acuivasi in coloro che gli aveano uditi e non se n'erano formato un concetto a modo loro. Il pro ed il contro traducevasi in favore e in disfavore dei discussi oratori, dei quali ben a ragione il proverbio siciliano: Tinta dda matri c'havi lu figghiu pridicaturi! compiange le genitrici; giacchè non v'è persona che più dei banditori della parola di Dio sia maltrattata da quelli che meno la intendono. Alla simpatia o all'antipatia del pubblico varie circostanze concorrevano tutte più o meno forti: la nazione del predicatore l'ordine a cui apparteneva, le sue relazioni con qualche reputata famiglia del paese, e poi le doti intrinseche e più le esteriori di lui. Laonde accadeva il medesimo che agli artisti da teatro, fatti segno di calorosi applausi e di tacite disapprovazioni. Nel 1785 un genovese che predicava nella chiesa dell'Olivella soppiantava un napoletano al Duomo; dove anche l'anno seguente un altro soccombeva a quello della medesima Olivella. Nel 1787 la logomachia sostenevasi tra di valenti Domenicani, come tra due altri mediocrissimi del medesimo ordine nel novantacinque e nel novantasei. Il sac. Gaetano Burlò nella chiesa di S. Giuseppe superava di gran lunga i suoi emuli; di che fu un gran discorrere fino a vedersi anche i meno intemperanti tra gli spensierati giudici da caffè bisticciarsi nelle assemblee e nelle riunioni. Si era pensato in tempo debito (1791) a P. Pietro Rottigni dei padri Somaschi; ma all'ultima ora, dopo sette anni dalla nomina, egli mandava scusandosi di non poter venire. Fu una indelicatezza imperdonabile, che fece andare su tutte le furie il signor Pretore ed il nobile Senato. Che cosa poteva quindi fare P. Matteo Aceto, invitato improvvisamente, poco prima della Quaresima? Si erano messi gli occhi sul P. Teresio da S. Cirillo, e se n'era fatta la elezione; ma avvicinandosi il 1794 egli se n'era andato all'altro mondo, e fu fortuna che P. Gaspare da Gesù, carmelitano scalzo, accettasse il tardivo e gravoso ufficio, e più, che lo compiesse con una certa lode.
Al giunger dei Reali in Palermo, l'intervento loro alle sacre concioni assumeva carattere di pubblica dimostrazione a favore del P. Domenico Maria Sances dei Domenicani. Egli predicava al Duomo, cioè al Gesù, Casa Professa, mentre all'Olivella predicava un nizzardo. Che pronunzia infranciosata quella del nizzardo! Ed era mai possibile che col vento fortunale spirante dalla Francia, riuscisse gradita quella pronunzia?
Ed ecco il Re e la Regina recarsi tre volte la settimana a sentire il Sances. Maria Carolina ne era addirittura entusiasta, e per riflesso, tutte le dame di Palermo. A quaresimale finito, lo invitava al Palazzo e regalavagli una forte somma in monete d'oro ed una tabacchiera del valore di dugent'onze (L. 2550)!, poco più del doppio, quasi il triplo, del compenso solito a darsi dal Senato al suo oratore ufficiale quando egli era forestiere130. Lo spirito d'indifferenza religiosa dell'antico pupillo del Tanucci avea già subito l'influsso della politica e della sventura. La esperienza avea gettata molta acqua sul fuoco dei primi anni del suo regno: e corte e chiesa si erano in lui strette in amplesso assai più forte che non si potesse sospettare appena egli era uscito di minorità. Il giovine principe nel 1768 aveva arditamente espulso i Gesuiti, anche cadenti ed infermi; il vecchio Re nel 1805 doveva richiamarli: e gli stemmi della Compagnia di Gesù, stati sollecitamente atterrati, dovevano venir ricomposti e rimessi in onore. Laonde il cronista Villabianca, a chiudersi del sec. XVIII, per la Quaresima del 1800 poteva non senza una tal quale malizietta scrivere: «Li primi ad esercitare la religiosa osservanza di sentir la predica dei sani giorni furono li Sovrani con tutta la R. Famiglia; con che avendosi (sic) essi passato allegramente nello scorso baccanale, procurano ora far bene alle loro anime nei giorni di penitenza e fare insieme i lor doveri di principi nell'edificare i popoli col loro santo cristiano esempio»131.
Strano, scomposto accozzo di profano e di sacro, di scettico e di bigotto, di ridancione e di geremiaco, questo degenerato figlio di Carlo III, che divertivasi e sospirava, che ogni maniera di caccia e di pesca lecita e non lecita alternava con le noiose cure dello Stato; e che, mentre per non dare ombra alla Regina si asteneva dal visitare i monasteri, dove con le attraenti bellezze muliebri della Capitale si sarebbe potuto guastare la testa, divertivasi con Donna Teresa Fasone; la quale poi, in un giorno di malumore, per un inatteso regalo di cattivo genere, dovea egli disterrare e mandare a domicilio forzato in Castelvetrano!
Il quaresimale del Duomo non era il solo ciclo di prediche di cui si occupasse il Senato. Ad altri cicli consimili e a non pochi panegirici doveva annualmente questo pensare tanto per la metropolitana quanto per le parrocchie, sulle quali, come è risaputo, avea ed ha diritto di patronato. Per le tre Rogazioni precedenti l'Ascensione invitava soggetti di valore indiscutibile. Le Rogazioni erano le processioni alle quali nessuna corporazione monastica doveva mancare; sicchè le prediche che le coronavano, dovendosi pronunziare innanzi ai monaci ed ai frati della città ed agli ecclesiastici più in onore, facevano «tremar le vene e i polsi» ai più valenti. Chi non conosce il P. Reggente Domenico Danè, poeta ingegnoso ed elegante, sostegno dell'ordine di S. Francesco di Paola? Ebbene: fu lui uno degli oratori; e con lui in varî anni D. Fr. Ruffo, dottore in sacra teologia, i cappuccini P. Giuseppe Alfonso e P. Fra Camillo da Palermo, il crocifero P. Camillo Fuscia, il teatino P. D. Em. Oneto, il carmelitano P. Lettore Niccolò Aiello, lo scolopio P. Fr. Cusenza ed i preti Bonomo, Puccio, Barresi, Fernandez, Camarda, Calderone, Agalbato, Miraglia, Giunta e D. Giuseppe Trofolino.
Trofolino?... Oh! questo sacerdote non fu solo un buon predicatore, ma anche un fervoroso operaio della chiesa. Se il lettore non ne sa altro, si ricordi almeno essere egli stato l'autore della giaculatoria che dopo la benedizione del Divinissimo si recita ogni dì nelle chiese.
Fa mestieri di trascriverla?
Eccola quale egli la compose e l'Arcivescovo del tempo l'approvò (1779):
Adoramu umiliatiLa santissima Trinitati;Adoramu ogni momentuLu santissimu Sacramentu;E lodata sempre siaLa purissima Maria!
Adesso il pietoso lettore sa che questa canzonetta conta la bellezza di centoventicinque anni di età.
Il fiore dei panegiristi del tempo era adibito anch'esso a celebrare, oltre le tre Rogazioni, S. Sebastiano e S. Agata, per conto del Comune, che dal 1575 avea fatto voto di festeggiarli come protettori e patroni della Città, e S.a Rosalia, la graziosa verginella palermitana, il genio tutelare a cui la Città medesima come ad àncora di speranza, a tavola di naufragio, a porto di salute ricorse sempre con fede nei giorni più tristi per essa.
Poco meno che mezzo secolo addietro, fra il 1850 ed il 1860, le Rogazioni aveano già perduto l'antico lustro, e S. Sebastiano le simpatie che lo avean
. . . . . . . . fatto degnoDi tanto onore . . . . . .
Chi scrive queste pagine ricorda le ultime processioni commemorative delle due ricorrenze, dove non più gli ordini monastici tutti, ma solo pochi loro rappresentanti con gonfalone e croce intervenivano, rari nantes in gurgite vasto, scarsi componenti una breve fila di frati, appena notabili nelle grandi vie da percorrere, non sai se mortificati di essere in sì poco numero, o infastiditi dell'ora dello spettacolo, che li distraeva dalle consuete occupazioni.
Il quaresimale prosegue sempre lo stesso a cura del Municipio e col favore inalterato del pubblico, che ora si rivolge a quello dell'Olivella,132 ora si accentra tutto sull'altro, secondo il giudizio degl'intendenti, le relazioni degli amici, la mimica degli uditori più autorevoli, i quali coi più lievi movimenti del capo, o con l'aggrottar delle ciglia, o col contrarre delle labbra, talora decidono del merito dell'oratore e formano presso il servum pecus degli ascoltatori la così detta pubblica opinione.
Nella Quaresima erano di obbligo alcuni giorni di meditazione in esercizî spirituali. Tutte le chiese di secolari e di regolari accoglievan fedeli d'ambo i sessi; ma v'era un luogo esclusivamente destinato a questo devoto ufficio, la «Casa degli esercizî», fondata dai preti di S. Carlo Borromeo; e v'era anche la congrega del Fervore (1765), promossa ed aiutata da quell'uomo di santa vita che fu Mons. D. Isidoro del Castillo dei marchesi di S. Isidoro, provvidenza del quartiere dell'Albergaria, del quale fu parroco attivissimo. Lì, nella Casa, erano lunghi corridoi con camerette da una parte e dall'altra per coloro che vi si recassero, una magnifica cappella, un ampio e lungo refettorio e qualcos'altro per la pace dello spirito. Per nove giorni di seguito, nobili e civili vi si ritiravano per attendere alla riforma del loro costume ed all'acquisto della cristiana virtù133. Favorito da clausura volontaria (e sovente involontaria) era il raccoglimento di coloro i quali, per devozione sincera o, come non di rado accadeva, per ostentazione, vi entravano. La Curia arcivescovile li conosceva uno per uno, e rilasciava loro un attestato di questo compiuto dovere, come tutte le parrocchie rilasciavano quello del precetto pasquale. Li conosceva la Polizia e sapeva tenerli in conto come di buoni cattolici così di sudditi fedeli. Li conosceva anche il Senato, nei cui archivi se ne conservavano alcune volte i nomi e i documenti, perchè l'autorità comunale consentisse la costruzione di certi ripari necessarî ad impedire ai passanti di turbare il religioso ritiro134.
Luogo consimile pel conforto dell'anima sua aveva una volta scelto il Vicerè Fogliani (1767): la Quinta Casa al Molo, con la predicazione del gesuita P. Sansone; ma non avea voluto esser solo, e «di casa in casa con un suo creato avea mandato invitando tutti i nobili della città.» Ecco il suo nodiglio:
«Il Vicerè la riverisce, e avendo risoluto di andare a fare li Esercizj di S. Ignazio nella quinta Casa, la esorta e prega a volere con la sua pietà tenergli compagnia in questo santo ritiramento, e gliene averà obligazione, oltre il merito che ella si farà col signore Iddio. Questa fatta di esercizj, composta di soli nobili, comincierà la sera del lunedì 23 corrente marzo, e terminerà la mattina del giorno primo di aprile.
Ve ne sarà in appresso una seconda, composta di nobili e mercadanti, la quale comincierà la sera del lunedì 6 aprile, e terminerà la mattina del mercoledì santo. Si compiaccia però avvisar per tempo con suo biglietto in risposta a quale delle due potrà intervenire, non dubitandosi che per questi pochi giorni lascerà ogni altro affare per occuparsi di quello solo, che tanto importa all'anima sua».
Il tono della chiusura non ammetteva dubbio sull'accettazione. «Fatevi gli esercizj spirituali (diceva con belle parole il Vicerè): e dichiarate se volete farli coi nobili ora, o coi nobili e coi mercanti più tardi.».
Non si ha il numero dei signori invitati con questa circolare; ma si sa che in compagnia di S. E. furono quaranta persone probabilmente dell'alta aristocrazia135.
Vicende della vita!... Questa Quinta Casa dovea vent'anni dopo (1786) convertirsi in R. Casa di correzione pei figli discoli e per le mogli scorrette!
Nel 1799, nel medesimo mese di marzo del suo antico Vicerè, Ferdinando III con Carolina e tutta la Corte, assisteva dentro la Cappella Palatina ad esercizî simili a quelli che abbiamo cennati136: e furono giorni di grande sacrificio pel Sovrano, che non uscì, non fiatò e, tanto per parere, tenne silenzio da certosino.
Quello che per gli uomini alla Quinta Casa, avveniva per le donne nel Ritiro delle figlie della Carità sotto nome di Filippone. «Nel corso quaresimale si ricevevano per nove giorni dame e donne civili e zitelle e povere per farvi gli esercizi spirituali di S. Ignazio di Lojola in santo ritiro, delle quali le prime pagavano una certa somma per lo trattamento del pranzo, della cena e di quanto altro bisognava».
Così diceva un articolo del Ragguaglio del pio luogo: «e da questo santo Stabilimento non è stato poco il vantaggio che in questa città se ne è riportato,» aggiungeva un erudito137.
E come non v'era chiesa (e la pratica è sempre in pieno vigore anche oggi, specialmente nelle parrocchie, negli oratorî, nei monasteri, nelle case di educazione, ecc.) nella quale, per età e quasi per classe sociale, gli esercizî di Quaresima non si ripetessero per gli uomini, così non v'era e non v'è chiesa nella quale dove per nobili dame, dove per modeste signore e dove per umili donnicciuole, e per ragazze e madri di famiglia, quattro giorni almeno non venissero a questo consacrati. Le diverse partite di esercizî supponevano ed ammettevano uditori diversi: e nessun altro di sesso, di età, di condizione differente. Cominciavano (ripetiamo, che l'uso è sempre vivo) nelle ultime ore del giorno e finivano di sera. Istruzione e Meditazione impartivasi quando da un solo, quando da due sacerdoti. Quasi sempre amena la istruzione: e se per poco si scorre l'Utile col Dolce del P. Casalicchio, al quale i predicatori ordinariamente attingevano138, si comprende bene perchè uomini e donne, vecchi e fanciulli, vi si divertissero; ma la meditazione era una vera penitenza; quella sul purgatorio e, peggio ancora, l'altra sull'inferno, un supplizio. Una di queste prediche pel rumore che fece, dovea restar proverbiale, e merita un ricordo.
Era appunto di Quaresima, e nella chiesa di S. Maria delle Grazie, detta della Gància, alla quale è attaccato il relativo convento dei frati Osservanti, si compievano i soliti esercizî per le popolane della Kalsa. Toccava oramai la meditazione sull'inferno: e si era voluto renderla efficacissima rappresentando al vivo le pene dei dannati. Nel meglio, quando cioè il predicatore si accalorava nel descriverle, si sente un orrendo scroscio di catene, e pietosi lamenti di uomini, e raccapriccianti urli di demonî, e fracassi assordanti, e bagliori sinistri di fiammate, che rompeano, rendendola più penosa, la oscurità della chiesa. Immaginiamo il terrore delle donne! Quale più, quale meno, tutte si misero a piangere, a singhiozzare implorando pietà e misericordia, a gridare come ossesse; le più pronte si precipitarono verso la porta fuggendo; molte si svennero, alcune tramortirono. A tanto scompiglio accorsero i vicini, e con essi la Polizia: e sentendo la cosa, non poterono trattenere le più matte risate.
La frase popolare Finiri a 'nfernu di Gància attesta il tragicomico aneddoto139.
CAP. VIII
FRATI, MONACI E CONVENTI.
Non era ordine religioso che non fosse più o meno largamente rappresentato in Sicilia; e dicendo Sicilia, vogliamo intendere Palermo, centro anche della vita ecclesiastica dell'Isola. Basiliani e Benedettini, Cappuccini ed Agostiniani, Domenicani e Minimi, Antoniniani ed Osservanti, Carmelitani e Nicolini aveano in città e fuori i loro monasteri ed i loro conventi140.
Professavano le regole di S. Basilio e di S. Benedetto, di S. Francesco d'Assisi e di S. Agostino, e le sotto-regole di S. Domenico e di S. Francesco di Paola, di S. Antonio da Padova, di S. Nicolò di Bari, del terz'ordine di S. Francesco e via discorrendo. V'erano poi anche preti secolari e regolari, che partecipavano delle fraterie, ma ne differivano quasi radicalmente, perchè, congregazioni particolari, aveano per proprio istituto determinati scopi, come quello d'istruire la gioventù (Scolopî), di educarla (Filippini), di assistere i moribondi (Crociferi), di meditare e di elemosinare (Teatini) ecc. Di Gesuiti non si parlava più da un pezzo.
I frati eran divisi per provincie monastiche: e capo supremo di ciascuna era appunto un Provinciale con giurisdizione assoluta sopra un dato numero di conventi. Era preposto al convento un Guardiano, col nome di Priore tra i Benedettini e i Domenicani, di Correttore tra i Minimi, di Nostro Hermano tra i Mercedari. Il Guardiano quindi, il Priore, il Correttore moderava o dirigeva la famiglia del suo convento, come il Provinciale o l'Abate (se tra Benedettini, Basiliani ecc.) quelle di tutti i conventi a lui sottoposti. Egli, il Guardiano, amministrava, disciplinava i suoi confrati, ma non così indipendentemente che non dovesse darne conto al suo superiore, sotto i cui occhi passava qualunque carta, ed al cui controllo era sottoposta ogni spesa, come qualsiasi disposizione relativa al governo materiale e spirituale della comunità.
Un critico di cose monastiche si lasciò sfuggire che gli abiti dei Regolari eran tanti e così diversi che ci sarebbe stato da farne una gaia collezione di quadri e da riempirne le più cospicue gallerie del mondo.
L'espressione ha un fondo di vero, in quanto gli abiti, a ragione della necessaria distinzione di ordini, erano molti e molteplici, sì per la stoffa ond'eran composti, sì pei colori e sì per la forma. Come dai frati Cappuccini si andava per la scala religiosa fino ai monaci Benedettini, così dal ruvido albagio (abbràciu) si giungeva al morbido fior di lana; e dal nero perfetto di questi ultimi, al castagno dei Mendicanti, al latteo dei Predicatori e dei Benedettini Bianchi. Dalle amplissime maniche spioventi sui fianchi dei monaci, dalla saccata dei Minimi, si scendeva alla stretta ed angusta degli Antoniniani. I rozzi sandali, per via di modificazioni e di ritocchi, assurgevano ai delicati calzari; se parecchi erano gli ordini che andavano a capo nudo, non pochi si coprivano, quali d'un nicchio e quali d'un cappello a tegoli.
La chierica unius mediocris palmae dei Minimi allargavasi fino a limitare, nei Minori Conventuali, una corona di corti capelli, simbolo della corona di spine di G. C., e si riduceva alla misura d'una moneta di scudo d'argento nei monaci di S. Basilio e di S. Benedetto.
Ciascun ordine professava un voto proprio oltre quelli di Povertà, Castità, Obbedienza, obbligatorî per tutte le fraterie; e dove uno s'astringeva a perpetua vita quaresimale (Minimi), un altro a quella della predicazione (Domenicani), gli altri, alla istruzione, alla redenzione degli schiavi, alla elemosina, alle missioni nei Luoghi santi ecc.141.
Poveri avrebbero dovuto esser tutti in quanto che a nessuno era individualmente lecito di possedere: e se qualche cosa aveano, questa non poteva essere se non del convento; ma tali non erano se si guardi agli stabili ed alle larghe entrate della comunità. I viaggiatori del tempo si palleggiavano le cifre di codeste entrate, e le facevano ascendere a somme favolose142.
Checchè ne sia, nella Capitale ciascun frate (non parliamo neppure di monaci), di qualsivoglia corporazione, mangiava, beveva e vestiva decentemente. In provincia però s'intristiva sovente nei disagi; e v'eran conventi nei quali la tanto gradita campana del refettorio sonava solo pro forma.
Il Governo, che si occupò anche un poco di monasteri e di conventi poveri, provvide a tutti in generale con la legge dell'ammortizzazione; ed ai disagiati, con l'abolizione di quei conventini che per difetto di patrimonio, o per iscarsezza di numero, o per degenerazione dal primitivo istituto, non fossero più in grado di reggersi o non avessero più ragione di esistere.
Codesto concetto, vogliam dire embrionale, del Governo sulle corporazioni religiose, doveva in tempi posteriori, due terzi di secolo dopo, dar luogo a provvedimenti tanto improvvisi quanto immaturi. Gli scomposti tumulti palermitani del settembre 1866, fin qui non ricercati abbastanza nella loro finalità, vennero seguiti dallo scioglimento delle corporazioni medesime e dall'incameramento dei loro beni a pro dello Stato, o meglio a pro di accorti speculatori. Costoro, aiutati da inconsci, o da inesperti, o da disonesti, seppero trarne profitto a scapito dei poveri, ai quali il dilapidato patrimonio venne indebitamente sottratto.
Della morale dei frati si è sempre discusso: e le opinioni unilaterali ci son giunte in proverbi poco benevoli ad essa. Se ne raccontano tante, da poterne venir fuori un nuovo Decamerone; ma si dimentica che la fragilità è umana, e non poteva esigersi virtù soprannaturale in mezzo alle tentazioni pertinaci della vita in chi a 16 anni avea professato un voto, del quale non era in grado di valutare le conseguenze avvenire.
Ferdinando III volle ovviare al danno della inconsapevolezza dei giovanetti che si legavano con voti perpetui a quella età, e dispose che le professioni non dovessero farsi innanzi il ventunesimo anno: disposizione savia, ma non priva di difetto in quanto il professando, chierico dapprima, novizio poi, non avea avuto fino a vent'anni agio di conoscere il mondo per decidersi ad abbandonarlo per una vita del tutto diversa.
E frattanto, vedi incoerenza dello spirito umano! Una volta che Re Ferdinando recossi a visitare il chiostro di Monreale, quei monaci, dopo avergli chiesto la mitra come l'avevano i canonici della Collegiata del Crocifisso, altra grazia non seppero domandargli se non quella di poter pronunziare voti solenni prima del ventunesimo anno! Il Re avrà pensato: «Oh guarda! io l'avevo fatto per essi, ed essi non se ne contentano: ...fate il comodo vostro!», e da Legato Apostolico concesse il privilegio, che la incauta comunità si affrettò a consacrare in una lapide nello scalone del monastero.
L'obbedienza era il voto forse più rigorosamente osservato, o fatto osservare. Il semplice frate, ed anche in dignità di Definitore, di Maestro, di Reggente, vi si sobbarcava o rassegnato o a denti stretti. Il Provinciale, emanazione dell'autorità generalizia, ordinava a suo arbitrio la residenza del frate. Codesta residenza egli partecipava all'interessato con un foglio di carta in latino, chiamato obbedienza; la quale poteva essere imposta dalla esigenza del culto in una chiesa di provincia, ma poteva anche rappresentare, come di frequente avveniva, un provvedimento disciplinare. In questo secondo caso la faccenda era grave: e la obbedienza sonava castigo o punizione.
L'obbedienza era un'arma terribile. Per essa, dicono le male lingue, avevano sfogo le antipatie di persona, gli odii di parte monastica; in essa si epilogavano le vendette personali. I peggiori conventi della provincia eran destinati ad ospitare i paria delle fraterie. Quando poi l'avea fatta grossa od era un recidivo incorregibile, previa l'autorizzazione del Generale dell'ordine, il frate veniva confinato in un convento di «stretta osservanza» non solo fuori provincia, ma anche fuori ordine. Era un domicilio coatto in tutto il significato della parola, al quale, in caso di riluttanza di renitenza, andavasi con la sgradita scorta della forza pubblica, rimanendosi sotto la scomoda sorveglianza della Polizia. Gibilmanna, tra Cefalù e Castelbuono, suona triste anche oggi pei frati che vi tribolavano; e Polistena era la Gibilmanna della Calabria.
Le Costituzioni siciliane però offrivano la guarentigia di un tribunale d'appello al religioso che si credesse ingiustamente castigato: vogliam dire il Giudice della R. Monarchia, che ordinariamente era un alto prelato, e, perchè rappresentante del Governo, indipendente. A questo Giudice il povero bersagliato richiedeva fremente e fiducioso una riparazione, che allo spesso otteneva completa: la revoca d'un'obbedienza che eccedesse i limiti dell'ordinario e prendesse carattere di punizione immeritata anche in rapporto alla salute del frate. Era l'autorità sovrana del Re che si contrapponeva alla monastica, la quale da Roma, da un Generale, da un Cardinal protettore dell'ordine, dal Papa stesso attingeva forza ed autorità.
Or parendo questa esorbitante in alcuni ordini e come una inframettenza a scapito della potestà regia, un giorno si pensò a diminuirla, anzi a distruggerla senz'altro in alcuni ordini monastici: ed eccola colpita in pieno petto. Un decreto reale, la mattina del 4 novembre 1788, improvvisamente aboliva i Generalati dei Domenicani e dei Francescani in Sicilia. Fu una bomba che scoppiò con ispaventevole fracasso, accolta dove con fragorosi applausi, dove con penosa sorpresa; di che l'eco giunse disastrosa a Roma. In Palermo frati e chierici regolari non compresi nel sovrano editto si chiedevano perchè non lo si estendesse anche ai loro ordini, sottraendoli così alla supremazia d'un Generale o d'un Procuratore Generale, che quasi nessuno di essi aveva mai veduto, ed al quale dovevano ciecamente ubbidire.
Espressione dei sentimenti d'allora son tre sonetti anonimi, corsi manoscritti appena promulgato alle Quattro Cantoniere il real decreto. Chi li compose? Nessuno lo seppe; solo più tardi se ne attribuì la paternità ad un prete, professore di Teologia dommatica nell'Accademia degli Studî, il celebre sac. Carì, che con olimpica serenità se ne rimaneva dietro le quinte.
I sonetti son così liberi che noi non sappiamo farli di pubblica ragione; e perciò li lasciamo manoscritti143.
Com'essi, i frati, passassero il loro tempo, è stato detto e ripetuto. A quanti si sono occupati delle fraterie, rincrescevole è parso il saperle sovente disoccupate senza utile alcuno per la società. I viaggiatori che lasciavano la Sicilia, scagliavano contro queste tutti i sassi che incontravano per via. Gorani nel 1791 mettendo in combutta preti, monaci e frati, ne faceva sessantatremila poltroni, oltre a «centomila persone votate al celibato e perdute per la società»144. Chi abbia per poco guardato l'opera del «citoyen françois», sa che mangiatore di ecclesiastici egli fosse. Hager dolevasi che andando a cercare qualche frate in convento, non ne trovasse mai uno. Dov'erano? «Nelle botteghe o per le strade, a sciupar un tempo prezioso, a ciarlare, ad oziare, mentre non pur l'agricoltura, ma anche le manifatture e le fabbriche per manco di braccia perivano». E voleva senz'altro che si mandassero a zappare o far da manuali145.
Fin quell'uomo mite del Marchese Villabianca deplorava questo stato di cose, che tornava «a molto discapito della popolazione». Quando nel 1779, sulla politica del Tanucci, il Sovrano, «stante il continuo, smisurato moltiplicarsi di frati mendicanti di S. Francesco», ordinava per dieci anni la chiusura dei noviziati e fissava per le province siciliane il numero dei Cappuccini in 900, degli Osservanti in 450, e dei Riformati in altri 450, lo stesso nobiluomo compiacevasi che S. M. volesse «uomini utili allo Stato pel maneggio delle armi e per la coltura di campi»146. Nè men severo in siffatti giudizî era nella sua malandata vecchiaia.
Non pertanto, Bartels, per indole, per professione evangelica e per la evoluzione e rivoluzione dei tempi, avverso alle fraterie, faceva un'osservazione di ben altro genere a favore delle fraterie medesime. Mentre l'aristocrazia del censo tormentava nelle lontane terre i vassalli e, forse senza saperlo o volerlo, ne succhiava per mezzo di avidi procuratori il sangue, gli ordini religiosi erano umani verso la povera gente che ne lavorava la terra e ne riceveva pane; il quale se era bagnato di sudore, non grondava di lacrime.
L'osservazione trova appoggio nei fatti.
È bensì vero che guardando ai diversi istituti monastici non fosse da rimanere edificati della scrupolosa osservanza dei voti; ma è ugualmente vero che, come per compenso, larga era nei frati la beneficenza. La povertà pudibonda trovava sempre nelle case monastiche una minestra ed un pane, che sovente bastava a sfamare sventurati non usi a stender la mano. La miseria, che per lunga abitudine di chiedere andava a battere a quelle porte, non tornava indietro senza un sussidio. Differenti le ore per quella come per questa; diverse le mense. Houel, pur esso non amico dei frati, rimaneva commosso nel vedere, dentro il convento dei Cappuccini, «in un refettorio particolare e recondito, accolti ogni giorno a desinare nobili poveri e vergognosi, con grande onestà serviti. Nessuno si accorgeva della ragione del loro andare, giacchè infinito era il concorso dei poveri a quel convento. Ed osservava: «Quest'opera di carità fa degni di considerazione quei frati, ai quali ricchi e non ricchi fanno elemosina per sopperire alle spese a tanto bene necessarie. Essi meritano di esser benedetti, giacchè non posson fare dei loro beni uso migliore»147.
Come nei monasteri femminili era la stretta clausura pei due sessi e per qualunque persona, meno che per le autorità ecclesiastiche, pel medico e per gli operai addetti a lavori materiali; nei conventi la clausura era solo limitata alle donne. Gli uomini potevano entrare; le donne, invece no. A nessun militare era fatto lecito sorpassare armato la porta, la sua sciabola o spada dovea rimanere giù, in essa. Quando i Reali ebbero vaghezza di fare una visita al monastero dei Benedettini di S. Martino, e con loro erano anche donne, avvenne una strana scenetta, nella quale le dame di compagnia, col pretesto di far parte della comitiva, presero per loro le facoltà della Regina e delle principesse reali di penetrare nelle monastiche mura maschili; il che fu ragione di gravi risentimenti dei superiori.
Ed è giusto avvertire che alcuni anni innanzi era stata perpetrata una comica frode, per ragione della quale la sorveglianza era divenuta più del solito oculata. Una signora inglese, desiderosa di conoscere de visu l'interno del monastero, travestita da uomo, era entrata con altri uomini, visitatori del grande edificio. Nessuno se ne accorse, nessuno ne seppe nulla; ma quando l'Abate n'ebbe conoscenza, ordinò che nessun forestiere quind'innanzi vi mettesse più piede148. In dubiis pro anima.
Gibbon lasciò scritto: «Un solo convento dei Benedettini rese alla scienza forse maggiori servizî che le due università di Oxford e di Cambridge.».
Questa opinione, in Sicilia, nel secolo XVIII, deve aver credito, perchè nei monasteri di S. Martino e di Monreale erano uomini eminenti per dottrina, pietà e senso squisito d'arte. Il gusto che dominava fin nei particolari delle opere antiche e moderne dei due monasteri, non meno che in quelli di S.a Maria del Bosco e di S. Nicolò l'Arena, prova che quelle non eran persone volgari, ma che invece si ispiravano ai più elevati sentimenti del bello. Dopo un secolo e più che il Governo Vicereale fece vandalici saccheggi a S.a Maria del Bosco; dopo trentott'anni che la Legge sulle corporazioni religiose è venuta a scompaginare quanto avea saputo comporvi il monachismo intelligente, musei, pinacoteche, librerie, attestano una civiltà di pensiero che la beffarda società d'oggi non riuscirà a cancellare giammai.
Eppure nel secolo XVIII il pubblico non era pienamente persuaso della pietà e della sapienza dei Benedettini. Padri dotti e buoni come i fratelli Salvatore e G. E. Di Blasi, come D. Ambrogio Mira e D. Raffaele Drago, D. Gaspare Rivarola e D. Carlo Ant. Paternò, e come D. Gioacchino Monroy ed altri tali, si contavano a dito: e i non contati si prestavano a giudizî sfavorevoli, che tutti li mettevano in combutta. La loro mondanità li teneva con un piede nel chiostro ed uno nelle dorate sale degli aviti palazzi, alternando così la monotona recitazione del breviario con la variata lettura di certi libri giunti in contrabbando dalla Francia, e l'aperta contemplazione delle sacre immagini nella chiesa e dei severi ritratti nei dormitorî con quella furtiva delle Provvigioni pel chiostro, stampe di costumi e di scene illustrate, che con deplorevole leggerezza qualcuno tra essi mostrava a visitatori stranieri149.
Poesie siciliane e italiane del tempo e di prima avvalorano siffatti giudizî, certo non temerarî. Di una di esse diremo che un benedettino raccomandava in poveri versi ai suoi correligiosi di rimanere al loro posto, di serbar silenzio a rifettorio, di non andar bighellonando pel monastero, di stare in ritiro, di non cercare più di tre pietanze e, nel sollievo di gennaio, di non pensare all'antica usanza150. Che cosa fosse questo «sollievo» e questa «usanza», non si riesce di capire: salvo che per quello non voglia intendersi un po' di svago a Palermo, dentro il monastero dello Spirito Santo (caserma dei pompieri), nei giorni freddi d'inverno in S. Martino; e per questa, qualche vecchio abuso. Altri componimenti ribattono sul medesimo chiodo; ma son colpi delicati che si riducono a biasimare, indirettamente rafforzandolo, lo sfarzo dei nobili figli di S. Benedetto, sfarzo rimasto proverbiale quanto il letto dei Predicatori e le mense dei Cappuccini:
Lettu di Duminicani,Lussu di Binidittini,Tavula di Cappuccini.
Se i Benedettini per la loro nascita e quindi per una cert'aria d'altezzosità venivano sfavorevolmente segnalati dai religiosi d'altri ordini, questi non potevano andar lieti di cordiali rapporti tra loro. Gelosie sempre rinascenti per dottrine teologiche, per preminenze di regole, li tenevan divisi l'un l'altro, ed erompevano in motteggi in pubblici ritrovi principiando nei refettorî e finendo nelle sagrestie dei proprî conventi.
Dal dì ch'erano andati via i Gesuiti, i Domenicani erano restati quasi i primi a rappresentare la più soda cultura, essi nel sito dei quali era stato fiorentissimo lo Studio, protetto dal Magistrato del Comune. Per questo eran tenuti in alta estimazione. Ma i Domenicani non sapevano perdonare ai Francescani la immensa colonna alzata in onore della Concezione in mezzo della piazza della lor grande chiesa; colonna che ricordava un trionfo dei frati Conventuali, sostenitori arditi della verginità di Maria, da essi posta in dubbio.
Quella colonna era un dispetto permanente per ciascun domenicano, il cui ordine vide sempre di malocchio il giuramento del sangue del Senato di Palermo151, e serbò una certa simpatia pel Muratori, che lo biasimò non essendo giustificabile la difesa, a costo del proprio sangue, di una credenza cattolica non proclamata mai come domma dai sovrani pontefici. Ma i Francescani se ne impipavano, perchè avevano dalla loro il Magistrato Civico e sapevano che tutte le simpatie dei Domenicani non sarebbero valse un briciolo nella protezione di questo, specialmente dopo che la potenza dell'ordine di S. Domenico era stata depressa per l'abolizione del S. Uffizio.
Non contro un altro ordine, ma contro la confraternità dei falegnami, i Teatini sbraitavano per la statua di S. Giuseppe, che quelli, proprietarî del terreno della chiesa, aveano voluto piantare sulla porta. E che non fecero per impedire questa preferenza di fronte al fondatore del loro ordine, S. Gaetano! Ogni anno, per la festa di S. Giuseppe, quando i maestri dentro il maestoso tempio distribuivano la immagine del S. Patriarca, inghiottivano bocconi amari nel sentire i monelli a gridare sotto la loro Casa, nella vicina piazza Vigliena e per le vie: Viva S. Giuseppe, e non S. Gaetano!152.
Ragione di scatti e di ostilità erano le processioni sacre, alle quali era d'obbligo l'intervento delle comunità religiose. La precedenza di queste dava luogo a liti non sempre definibili dall'autorità ecclesiastica secolare (la quale, del resto, ben poco poteva sugli ordini regolari), ed era occasione frequente di clamorosi ricorsi presso l'Apostolica Legazia. Frati Conventuali, Osservanti, Riformati scendevano in lizza tra loro, e poi, alla lor volta, in lizza contro altre comunità per il posto che loro spettava nelle pubbliche funzioni.
Nel 1778 il Re in persona, come Legato Apostolico, stabiliva le norme regolatrici di siffatta bisogna; ma quelle norme a nulla valsero, e lo spettacolo dei dissidî proseguì poco edificante.
Tre anni dopo un Ministro siciliano, a nome del Re scriveva: «Per darsi fine alla controversia agitata con eccessivo calore degli animi tra i pp. Conventuali ed i pp. Osservanti e Riformati in materia di precedenza nelle processioni ed in altre pubbliche funzioni,.... S. M. ha avuto presente la sovrana sua reale risoluzione del 1778, con cui per punto fisso e generale fu determinato che la precedenza dei frati nelle pubbliche funzioni regolar si debba dall'antichità dell'approvazione del rispettivo loro Istituto». E partecipava questa volontà acciò venisse comunicata ai superiori di quegli ordini, non solo «per comune notizia», ma anche «per l'osservanza, ad oggetto di evitarsi in avvenire le scandalose brighe che sovente per tal piato sono avvenute».
Sarebbe una vera ingenuità il credere che le brighe cessassero. Nelle processioni e nell'associazione dei cadaveri si combatteva pel diritto di priorità; come nella festa di S. Antonio per quello della celebrazione di essa, reclamato per conto proprio ed esclusivo da ciascuno dei tre ordini. Si giunse a tale che il Re dovette incaricare il Tribunale della Legazia e specialmente la R. Camera di S. Chiara del più rigoroso esame, in giudizio contraddittorio, «delle bolle pontificie invocate dai provocatori della lite e dei giudizî degli scrittori di cronache, annali ecc. dei documenti tutti che si potettero avere nelle mani dai componenti quel Tribunale, fornito sempre d'uomini notissimi per onestà, ricchi di erudizione storica, come di scienza canonica. Più anni andavan per la scrupolosa ricerca, che dovea fornire la base della sentenza; solo nel 1794 il R. Dispaccio pose fine alla questione»153. Il Sovrano, che avea ben altro pel capo che i puntigli dei frati per siffatte piccolezze, conchiudeva in questi termini perentorî: «Che s'imponga perpetuo silenzio a controversie di questo genere, le quali per lungo tempo han turbata la pace dei frati col distrarli dagli esercizî di religione, ai quali son chiamati»154.
Gli era come dicesse: Andate a farvi benedire: e non mi state più a rompere la devozione!...
CAP. IX.
LA PROFESSIONE DI UNA MONACA.
Il dì 11 gennaio del 1797 S. E. Rev.ma Mons. D. Filippo Lopez y Royo, Arcivescovo della Diocesi di Palermo, riceveva la seguente partecipazione:
«Io Donna Maria Buglio, Abbadessa del Ven. Monastero di S. Maria dell'Ammiraglio detto della Martorana di questa città di Palermo, dell'ordine del Padre S. Benedetto, faccio fede come avendo con buona licenza di S. E. Rev.ma nostro Arcivescovo fatto capitolo, nel quale sono intervenute tutte le monache c'hanno voto, e proposto, che la Novizia Donna Luisa Valguarnera, doppo aver finito l'anno intiero del suo noviziato, e compiti li anni ventuno di sua età, richiede umilmente di essere ammessa per amor di Dio alla professione solenne delli tre voti monastici di Povertà, Castità, Obedienza, e di perpetua clausura in questo monastero, e di esser accettata nel numero delle monache velate con la solita dote di scudi 1000, è stata accettata con l'intiero consenso della nostra Congregazione, avendo con voti secreti, e non a viva voce, in quantità sopra due terzi come richiede la nostra santa Regola. Di più faccio fede di mia coscienza, e ne chiamo in testimonio Dio benedetto e che mi ha da giudicare, che la suddetta Donna Luisa Novizia, per quel, che io giudico, ed ho potuto vedere, e intendere dalla Madre Maestra, e da tutte le Superiore, e monache, sa leggere bene, ed è degna per virtù di essere gratificata, ed abile per il servizio di Dio in questo Monastero.
«In fede di che ho fatto la presente sottoscritta di mia mano, sigillata col nostro solito sigillo.
«Dato nel nostro Monastero di S. Maria dell'Ammiraglio in Palermo, oggi li 9 del mese di gennaio dell'anno 1797.
Dopo otto giorni Mons. Serio, Vicario generale della Diocesi, si recava alla Martorana ad interrogare un'ultima volta, e ad esplorare l'animo di D.a Luisa, e n'avea la conferma letterale delle dichiarazioni precedenti della Madre Abbadessa: e con questo la rinunzia formale dei suoi beni, «acciò più libera e sciolta applicar si possa a servire Sua Divina Maestà».
Siamo al giorno 23 gennaio. Dalla via Alloro, dal Cassaro, dalla Strada Nuova portantine e mute elegantissime vengono a fermarsi nella piazzetta di S.a Caterina. Dame e cavalieri in abiti inappuntabili ne scendono posatamente, e con istudiata gravità infilano la porta della chiesa. Il Principe di Valguarnera li ha tutti invitati per la solenne professione della sua terza figliuola, la quale, compiuto, come abbiam visto, l'anno del noviziato, intende appartarsi per sempre dal mondo.
I musaici del sublime monumento di Giorgio Antiocheno brillano all'agitarsi delle mille fiammelle accese nelle tre absidi e nelle cappelle laterali. Otto o nove altari sono ininterrottamente occupati da celebranti, stati «pregati di accrescere vieppiù la pompa colla presenza di loro messa». A traverso le lucenti grate si profilano le esili figurine delle nobili monache; dalle quali, a rispettosa distanza quelle delle converse, e più in là ancora, o in una stanza a parte, invisibili, le cameriere, pronte ad ogni cenno delle rispettive loro signore.
Tutto è pronto per la cerimonia. Al corno dell'epistola dell'altare maggiore sono le vesti monacali della candidata: lo scapolare largo e lungo, la cocolla manicata e talare, il velo nero, il breviario, che devono essere incensati e benedetti. Esce la messa solenne. I musici dal letterino155 intuonano il Kyrie. All'offertorio, il celebrante va a sedere sotto un dossello. Di dentro, nella parte interna, sotto altro dossello, col suo baculo d'argento in mano, circondata dalle monache tutte in cocolla, ergesi maestosa la Badessa. Ed ecco, preceduta dalle educande e dalle novizie compagne, inginocchiarsele innanzi in abito di novizia, Maria-Luisa Valguarnera (giacchè è questo il nome di religione che dovrà prendere) e chiederle la grazia di Dio e la sua. Un breve dialogo latino si svolge tra l'una e l'altra; la quale, interrogata, risponde di rinunziare al diavolo ed alle opere di esso, di volere assumere la conversazione dei costumi monacali, abbandonare quella dei genitori, abdicare alla propria volontà.
Gl'invitati si mettono in punta di piedi, allungando il collo per vedere o sentire, e la novizia con voce flebile e tremante legge la sua petizione. Le compagne palpitano; la giovinetta, accostatasi al corno dell'epistola dell'altare dell'oratorio, lo bacia, e presa la penna soscrive col segno della croce invece che col proprio nome la domanda. E mentre il sacerdote prega, la novizia si alza e con le braccia aperte in atto di volare e col viso al cielo ripete per tre volte, inginocchiandosi in ciascuna: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam: et non confundas me ab expectatione mea (Prendimi, o Signore, secondo la tua parola, ed io vivrò: e non volermi fare sperare invano).
La funzione segue a svolgersi dal celebrante della chiesa, che recita orazioni e benedice gli abiti, li incensa e li manda dentro l'oratorio. La curiosità negli spettatori cresce. La Badessa senza scomporsi toglie l'abito noviziale alla neo-religiosa che le sta prostrata innanzi, la veste dello scapolare grande, della cocolla, del velo nero, le porge il breviario, recitando mano mano una preghiera, finchè la professata intuona: Regnum mundi, versetto che le monache tristamente ed il coro dei musici allegramente proseguono ed avvicendano con crescente commozione di tutti. Il sacerdote torna a benedire, e la Madre Badessa riceve in oscolo di pace suor Maria-Luisa, mentre il medesimo fa la Madre Priora, e l'una dopo l'altra le monache tutte.
Le campane suonano a festa: gli astanti mormorano, i cocchieri di fuori schioccano le fruste, e lacchè e lettighieri torno torno alla Fontana Pretoria gridacchiano e sorridono. In uno istante muta la scena. In mezzo all'oratorio, sopra un tappeto ed un cuscino suor Maria si prostra per terra: e le suore la coprono tutta con coltre nera come cadavere che resti chiuso entro una cassa: e le converse le adattano dal capo e dai piedi due candelieri accesi. A un dato segno, le campane dall'alto rintoccano a mortorio: e come un tremito invade tutti i circostanti; e le monache singhiozzano, e i circostanti lacrimano, impotenti a reprimer lo schianto del cuore alla improvvisa morte morale di colei che è così piena di vita. Dentro e fuori, la commozione è al colmo: ma si mitiga non sì tosto che il celebrante inviti la docile vittima ad alzarsi: Surge quae dormis, et exurge a mortuis et illuminabit te Christus (O tu che dormi, levati, e sorgi di mezzo ai morti, e Cristo t'illuminerà)156. Ed essa si leva, e con gli occhi rossi s'accosta alla grata del comunichino157, e tra la impazienza degli invitati riceve l'ostia benedetta: e nuove benedizioni e nuove incensate e nuove orazioni porgono a tutti agio di osservarla, di studiarla, di scrutarne il cuore profondamente agitato.
Il sacrificio è compiuto. Oggi suor Maria-Luisa nel refettorio sederà la prima tra le novizie, domani l'ultima tra le professe. La maestra avrà una ragazza di meno da sorvegliare; la Badessa, una subalterna di più alla quale imporre; le suore una novella compagna alla quale confidarsi; le celle monacali, una nuova ospite.
Intanto nel parlatorio riserbato è un apparato di altro genere. La Nobiltà e gl'invitati tutti, dimenticando lo stridente taglio delle chiome dell'anno precedente ed il triste tumulo di pochi momenti innanzi, vi passa lietamente chiacchierando e motteggiando. Lì per mano di servitori gallonati ed imparruccati corrono incessanti, ed a profusione quasi incredibile, fenomenale, gelati di tutte le essenze, e amarene e limonate e carapegne e cioccolata e paste e pasticcini quanti può averne inventati la monacale industria e favoriti la capricciosa golosità dei consumatori158. La signora Badessa D.a Maria Buglio, benchè non ispetti a lei lo indirizzo di tante cortesie, si moltiplica per far onore agli ospiti, i quali tutti, dalla più attempata matrona alla più svelta ragazza, dal vecchio più costumato al giovane più libertino, felicitano la nuova sposa del Signore: alla quale, come ai genitori di lei, ripetono a coro la trita frase d'occasione: «Beata lei che s'è messa in salvo, lasciando a noi i guai di questo mondaccio!...».
Eppure, chi potesse penetrare nell'animo di questa beata, quale tempesta di affetti e di aspirazioni non vi scoprirebbe! E che crucciamento e dolore e dispetto in quello delle giovini compagne! Astrazione facendo dalle professe per vero, profondo sentimento religioso, le quali potevano dirsi soddisfatte, anche felici del loro stato, quante di queste non eran tormentate dal pensiero di aver troppo facilmente abbandonata la società nella quale avrebbero potuto brillare! Quante non rimpiangevano l'annuenza al chiostro, destramente strappata dai genitori, che dovevano ad ogni modo sbarazzarsi dei cadetti e delle figliuole per conservare ai primogeniti o all'unica erede le ricchezze!159 Anch'esso, il chiostro, aveva le sue attrattive; ma quanto non concorrevano queste a rendere talvolta angosciosa la vita di privazioni del mondo! Come resistere alle tentazioni incessanti quando le monache, affacciate alle logge sul Cassaro, vedevano uomini e donne d'ogni ceto, andare spensieratamente? E non era ragione d'ingrati confronti lo scorgere il fratello, la sorella, la cognata, l'amica, in carrozza, a piedi, bevendo fino all'ultima goccia l'ambrosia della felicità, o il saperli pompeggiare in passeggiate, in teatri, in ricevimenti, in spettacoli, in pranzi, in tutte le ricreazioni della vita!
Ciò non pertanto, non una parola di risentimento era dato sorprendere sulle loro bocche. A traverso la calma imperturbabile e la devota rassegnazione, nessuno mai sarebbe riuscito a scoprire la interna lotta di tanti cuori. Alcuni di questi cuori forse sanguinavano; ma chi ne udiva i gemiti? Solo qualche anima gentile li avrà in segreto raccolti, compatiti, disacerbati col balsamo di lacrime pietose.
La festa è finita. La famiglia della neo-professa, rientrando in casa, ha riandato mestamente le grandi spese sostenute dal dì che la figliuola entrò educanda, a questo della professione: e la dote, e il livello (vitalizio), e il corredo, e i varî trattamenti, e gli ornati ed i parati della chiesa, ed altri particolari a base di centinaia d'onze. E non di meno può dirsi contenta di esserna uscita senza il pericolo non infrequente della rinunzia al chiostro, proprio all'ultimo istante, poco prima del solenne giuramento dei voti, dopo che per la educanda, per la novizia si sono sperperate somme ingenti in tutte le funzioni che precedono e conducono a questa, or ora compiuta.
Perchè è da sapere che le spese di professione erano le ultime di una serie del genere, che partiva dalla prima entrata della ragazza in monastero e giungeva dove l'abbiam vista. Il Governo le proibiva; ma a che valevano le sue proibizioni se fatta la legge è trovato l'inganno? La circolare della Gran Corte (1775) per la riforma di siffatte spese veniva sempre elusa.
Facciamo un po' di conto in famiglia e vediamo come andassero le cose.
Per chi nol sappia, varie erano le funzioni per le quali la fanciulla dovea passare per giungere a professarsi.
Qualunque fosse l'età nella quale una bambina veniva ricevuta in monastero (e si cominciava anche a quattro, cinque anni! giacchè di buon'ora voleva crearsi alla futura monachella un ambiente che facesse dimenticare quello di famiglia), al settimo anno essa faceva la ufficiale entrata di educanda. Era quella una funzioncina tra seria ed infantile, alla quale parenti ed amici intervenivano, soddisfatti quanto le monache, con le quali ricevevano in comune dolci e rinfreschi, pur non avendone i regali e le galanterie.
Da educanda passava a novizia vestendo l'abito religioso: funzione che esigeva l'offerta dell'abito, della manta, oppur della tovaglia, o d'altro al monastero, di un cero da mezzo rotolo (gr. 400) a ciascuna religiosa, di non so quanti ceri per gli altari, e poi di dolciumi a tutto andare, così dentro come fuori il monastero, e di ori e argenti e moneta sonante.
Veramente questa entrata in noviziato dovrebbe avere lunghi particolari. Il lettore potrebbe a passo a passo seguire la giovinetta educanda nei sei mesi di perseveranza precedenti il noviziato medesimo, fuori del monastero; vederla a distrarsi o in noiosi passatempi, o in graditi ritrovi, in città e in campagna: occupazioni tutte preparate con tal fine astuzia da non far nascere simpatia per la vita fuori chiostro; studiarla nelle settimane di probazione; ammirarla finalmente nel giorno della monacazione. Giammai ragazza al mondo s'avviò a giurar fede di sposa con festa e lusso pari a quello di lei nel momento di questo primo drammatico atto della vita claustrale. Sciolte sulle spalle le lunghe, lucentissime chiome; candide, ampiamente strascicanti per terra le vesti nuziali, verso il palpitante seno stracariche di ricchi ornamenti; coperto di gemme, di pietre e di ori preziosi il collo delicato, le orecchie, le dita, ella s'appressa ad abbandonar tanta pompa per divenire la sposa del Signore. Ad una ad una tutte quelle forme mondane ella viene smettendo, fino all'ultima, (che è terribile sacrificio per una donna!): le chiome, sulle quali, forbici inesorabili s'accostano crudelmente recidendo, e che la genitrice reclamerà per la famiglia, doloroso testimonio d'una bellezza scomparsa. Il saio monacale copre subito la gentile figura, ohimè! così improvvisamente trasfigurata!
Abbiam vista la seconda delle funzioni, e potremmo tornarvi per fermarci sui parati e sulle macchine che si costruivano in chiesa, sulla grande musicata per la messa cantata, sui ceri accesi a tutti gli altari, sulle lumiere pendenti dalla volta, sulle torce spettanti alle monache e sulla profusione di dolci tra i presenti e gli assenti, tra i funzionanti e gl'impiegati, i protettori, i familiari, i clienti del monastero, non escluse le converse, le cameriere, le donne esterne di servizio. Ma nossignore: più tardi verranno i primi ufficî e lo insediamento in essi. Vanitosa come figlia di Eva, orgogliosa quanto una nobile del settecento, la giovane religiosa non vorrà restare indietro alle consuore che l'han preceduta. Che si direbbe di lei, che della sua casa, se la infermiera o la refettoriera non impiegasse qualche somma in ornamenti, apparati, utensili del rispettivo ufficio? Ci vada di mezzo il livello riserbatosi, si contraggono pure debiti, la generosità va fatta!
Molte e non liete son le riflessioni alle quali potremmo abbandonarci per tanto sperpero; ma a che giovano esse se non giovarono i continui ricorsi dei congiunti delle moniali al domani d'una professione? Limitiamoci a deplorare con una vittima del tempo, certo Lombardo, la elusione delle leggi, e solamente confermiamo il baratro che nelle case aprivano le pompe monacali; donde «una delle più dure concause della decadenza delle famiglie nobili di questa Capitale e di tutto il Regno e le scandalose dispiacenze tra padri e figlie»: i padri nel vedere, come abbiam detto, le figlie mutar di volontà dopo tanti anni di vita di educande; le figlie per la conseguente riduzione della dote160.
CAP. X.
LE MONACHE E LA LORO VITA NEI MONASTERI.
Tornando alla nostra monachella, eccola entrata, come morta al mondo, nel numero dei più; ma pur tale, ella può rimaner paga del suo nuovo stato. Da qui a tre anni le saranno schiuse le porte degli impieghi del monastero: ella
Sarrà fatta sagristana,Purtunara, cucinerà,Spiziala ed infirmerà,Cillarària sarrà,
come dice il buon Meli. Potrà anche salire al grado di borsaria, di rotaria, di maestra delle educande o delle novizie, di Priora, di Badessa161.
Intanto comincia a disporre di qualche scudo delle sue entrate per certi bisogni e doveri che non son quelli della cibaria, del vestiario, del bucato, del culto, ai quali provvede il monastero. Di una cameriera e magari di due non potrà fare a meno, abituata com'ella è ad esser servita. Un confessore non le si potrà negare: l'ha ogni monaca, vuole averlo anche lei: un confessore tutto suo, esclusivamente, unicamente suo, che ella non permette, o solo per rara eccezione permette, che abbia altre penitenti162 nel medesimo monastero163. Lui direttore dello spirito, consigliere, amico, padre essa guarda con premurosa riverenza; a lui i suoi pensieri, le sue attenzioni. Non v'è solennità ch'ella lasci scorrere senza una di codeste attenzioni. Per la Pasqua gli manda i più squisiti pupi cu l'ova; per S. Martino, i più teneri biscotti pieni; per Natale le più dure mostacciole; anzi, perchè di grado superiore nella famiglia numerosa dei dolci, i più pesanti pantofali164. Nella ricorrenza dell'onomastico o del compleanno di lui, essa non sa, nè può rinunziare al piacere, fors'anche al dovere, di mandargli un grande vassoio ('nguantiera) con dolci speciali del monastero, o conserva di scorzanera (scursunera), e sopra o intorno una mezza dozzina di fazzoletti di seta rosso-gialla, o di posate, o di cucchiaini da caffè d'argento. La domestica esterna (mamma), portando questi doni, o un'ambasciata chiedente della salute di lui, sa di dovere studiare tutte le mosse del padre (confessore), imprimersi nella memoria le parole tutte da lui pronunziate, con la mimica che le associa, per poterle subito ridire e ripetere alla signora.
Or com'è che una monaca, pur avendo professata povertà, poteva permettersi tanto lusso di regali?
Il come è semplicissimo. La monaca si rivolgeva con una lunga lettera, a forma prestabilita, alla sua superiora e le chiedeva le licenze di disporre del peculio, ossia del proprio vitalizio per i bisogni personali o per fare delle piccole offerte. La formula di questa lettera è un capolavoro di educazione, di rassegnazione alla volontà della Badessa, suprema moderatrice del monastero, vigile custode della regola di esso. Perchè, dopo la più larga professione di santa obbedienza alla materna carità ed autorità di lei, la supplicante chiedeva il permesso di potere col vitalizio «compire qualche atto di gratitudine così coi parenti che con qualche altra persona cui ella avesse obbligazione; potersi servire di tarì dodici, tenerli in suo potere e spenderli per sua soddisfazione..., fare qualche elemosina, far celebrare qualche messa, pagare qualche persona di servizio..., imprestare o imprestarsi qualche cosa secondo le occorrenze del tempo, disporre di tutto quello che teneva in cella, servirsi di alcune cose d'argento, ricevere tutto quello che sarebbe stato dato dal monastero, dai parenti o da altra persona, e che se ne potesse servire e disporre a suo arbitrio e poter fare qualche cosa dolce così per sè stessa che dei parenti e persone cui avesse obbligo...» Excusez du peu!
Aveva la Badessa, senza intesa del Vescovo, facoltà di concedere queste ed altre licenze?
— «Sì», rispondeva un canonista, al quale ne veniva mosso quesito; «perchè la Badessa ha le medesime facoltà dell'Abate».
E quanto poteva, con licenza della Badessa, spendere la monaca?
— «In ragione del vitalizio», si rispondeva, e, secondo le varie opinioni, da uno a quindici scudi165, fino a cinque dei quali solo pel confessore.
Ecco giustificati i regali delle monache. Ma la faccenda non era così semplice come si presentava. Una volta (1755) l'Arcivescovo Cusani, fungendo da Vicerè e da Capitan General di Sicilia, volle portarvi rimedio, ed ordinò «a tutte le monache particolari e converse di ogni monastero, senz'alcuna eccezione, sotto pena di scomunica maggiore ipso facto incurrenda, che non potessero nè molto nè poco, nè direttamente nè indirettamente, nè per qualsivoglia pretesto dare, o regalare ai loro confessori ordinarj, o straordinarj, regolari o secolari; e questi all'incontro, sotto pena di sospensione ipso facto incurrenda non potessero nè per sè, nè per altri, ne per qualunque formalità, che potrebbe pensarsi, anche per titolo di elemosina, ricevere cosa alcuna dalle medesime»166.
L'editto del Cusani suscitò un pandemonio. Ecclesiastici insigni furon chiamati a dare il loro avviso. Un parere teologico diede P. Benedetto Piazza; uno canonico, P. Francesco Burgio: un altro, mezzo teologo, mezzo canonico, il molto Reverendo P. Giuseppe Gravina: tre scrittori di primo ordine. L'Arcivescovo con tutta la sua autorità ne uscì malconcio. Un anonimo ne prese le parti, e in un libro che si finse stampato a Lucca ed uscì invece dai torchi di Palermo, furon messe carte in tavola e, a difesa del Cusani, raccontate cose dell'altro mondo.
Ecco il titolo intero di questo prezioso libro: Ragguaglio delle contraddizioni sostenute dalla pastorale vigilanza di Mons. D. Marcello Papiniano Cusani Arciv. di Palermo per occasione di un Editto da lui pubblicato agli 11 di Ottobre del 1755: per cui si vietano i regali delle monache ai confessori: gli abusi intollerabili nelle occasioni de' Monacati e Professioni delle medesime: e l'accesso dei Regolari ai loro monisteri senza la licenza dell'Ordinario: che serve di confutazione ai voti de' PP. B. Piazza, Fr. Burgio e G. Gravina d. C. de G. contro l'Editto stesso e l'Ordinaria, e la delegata giurisdizione dei Vescovi. In Lucca 1759. (In-8º, pp. 407).
Altri bisogni, non personali, imponeva la Comunità per officiature, servizio divino, ricorrenze civili, restauri edilizi del monastero. Questi bisogni non eran pochi, nè facili a soddisfare con le rendite del religioso istituto, e con lo scarso assegno personale delle suore. E frattanto le famiglie erano di continuo importunate per sovvenzioni straordinarie, che provocavano clamorosi ricorsi al Sovrano. Laonde nel 1779 Ferdinando ingiungeva ai monasteri «di addossarsi le spese di qualunque genere senza ombra di gravare per le moniali. Per tal modo, diceva, i padri di famiglia si rilevano dal peso di soccorrere con straordinarie spese le loro figlie e congiunte, mentre le singole monache non si angustiano più di spendere quel che quasi angaricamente spendevano»; e faceva obbligo espresso ai vescovi di sorvegliare la esecuzione dei suoi ordini. I vescovi peraltro, impotenti a ciò, vedevano la loro azione frustrata dalle comunità religiose, refrattarie a qualsivoglia provvedimento in proprio favore.
Lesi nei loro personali interessi, i parenti tornavano a gridare: ed il Re, seccato, emanava nuovi ordini e passava alle minacce, non intendendo più oltre sopportare che si pagasse di proprio dalle monache quello che avrebbe dovuto pagarsi dalla cassa del monastero. Le monache, diceva il Re, fecero i loro conti e videro che non potevano arrivarci, avendo bisogno dell'aiuto di costa, cioè di denaro delle famiglie: e ne mormoravano. E sdegnato, nuovi richiami faceva ai Vescovi, affinchè sotto pena di peccato mortale vietassero alle monache qualunque spesa individuale per ricreazioni, dovute solo ed assolutamente dal patrimonio del monastero (1782)167.
Ma di chi si dolevano queste benedette monache se esse medesime eran causa dei loro mali? Il 1º gennaio del 1796 moriva suora Emanuela Cordova, Badessa di S.a M.a delle Vergini, e seppellivasi in monastero168. La buona donna sapendo a quali dispendî sarebbe andata incontro la comunità, pei funerali a lei dovuti, tre giorni prima si dimetteva da superiora. Le suore avrebbero potuto uscirne bene, accettando la rinunzia: ma senza discussione la respinsero169: il che fa onore al loro sentimento di devozione per la loro venerata madre. Ma allora perchè tornare alle solite querimonie pel gravame che loro veniva da siffatta sventura? Oh non sapevano esse che alla Badessa toccavano gli onori dei capi religiosi? e che per tre giorni consecutivi sarebbe occorso l'intervento del Capitolo e del clero della Cattedrale: i canonici, i prebendati? Cujus culpa delle 70 onze che ci volevano per tutta questa funzione, alla quale peraltro era in loro facoltà di sottrarsi?
Ma v'è anche di più, e questo conferma la responsabilità tutta monacale dello sperpero inconsiderato che nei monasteri si faceva170.
Poche settimane dopo giunta in Palermo la Corte di Napoli, volle la Regina Carolina fare un giro pei monasteri. Primo visitò (1 aprile 1799) quello di Sales, fuori Porta Nuova, al quale era annesso il R. Educatorio delle nobili donzelle che prendevano nome da lei. L'accompagnarono dame e cavalieri, e le furono resi omaggi singolari; e regali di fiori di smalto e ceste di dolci furono offerti ai principini: somma complessiva di questa bazzecola, settant'onze (Lire 892,50)! Di questo un po' male rimase la Regina, non per offesa che venisse al suo orgoglio di sovrana, ma pel costo di tanti regali. Laonde, rientrata nella Reggia, emanò ordini severi che nelle seguenti visite, offerte simili non si ripetessero, pena la sua indignazione.
Vera o no che fosse la collera, bisognava prenderla nella sua espressione e non pensare a nuovi trattamenti per lo appresso.
Eppure la prima a dimenticarsene fu l'augusta incollerita.
Tre mesi e diciotto giorni durarono le sue visite, e in ventun monasteri da lei visitati, non una ma due feste da ciascuno si lasciò ella fare e si godette, l'una più dispendiosa dell'altra. Se il Sales buttò via quelle settant'onze, il Salvatore, per non restare ad esso indietro ne buttò cento (L. 1275). Carolina avrebbe dovuto senz'altro smettere; ma non ismise, e la minaccia della sua indignazione fu una scena appesa: appesa, come per far comprendere che le acque dolci diacce, i sorbetti, le carapegne non eran poi roba da rifiutare; e che se la visita si prolungava troppo, a certa ora, tanto lei quanto gli augusti marmocchi avrebbero avuto bisogno di un ristoro, che con parola propria chiameremo cena. Difatti non vuolsi dimenticare che la Corte, secondo l'uso d'allora, pranzava poco dopo mezzogiorno.
Ecco dunque una cena regale con pietanze in caldo e in freddo degne della figlia di Maria Teresa e della moglie di Ferdinando III.
I monasteri facevano a gara per superarsi, anzi per sopraffarsi a proprio danno. Non avean danaro e lo toglievano precipitosamente in prestito, senza speranza di poterlo prontamente restituire. Parati, illuminazioni, musicate, Pange-lingua in chiesa, illuminazioni a cera di Venezia dentro, in tutti i corridoi, nelle sale del Capitolo, in refettorio, nel quartiere della Superiora, gramolate di tutte le essenze, ponci di caffè e schiume di latte, dolci sopra dolci, torte grasse, arrosti di pollanche (talora chieste alla cucina del Principe di Trabia), conserve ed altra roba da dessert; e poi doni di altri dolci, di argenteria, di oreficeria e fin di telerie: ecco ciò che presentarono queste monachelle, che per la vanità di comparire più di quel che erano toglievano alla loro sussistenza il necessario ai piccoli comodi.
Al tirar delle somme, per la follia di poche ore, ciascuno dei monasteri visitati s'indebitava per la cifra tonda di trecent'onze (3825), e quello delle Vergini, di seicento (7650)!
Al domani di tanta ebbrezza, le recriminazioni delle singole religiose contro le loro superiore e delle superiore contro le singole religiose esplodevano violente. — «Fu la Badessa che volle spender tanto!» esclamavano le une. — «Furon le suore che s'imposero, perchè le monache di Sett'Angeli, e financo quelle di S.a Chiara, fecero cose da pazzi!» rimbeccavano le altre. — «La colpa è tutta delle Teresiane, le quali senza un accordo regalarono una cornice d'oro massiccio», aggiungevasi, mentre in alcuni circoli monastici si gettava la colpa di tanta jattura «su quelle superbacce, dicevasi, di S.a Caterina, che per la loro rendita di 20.000 scudi all'anno, spendono e spandono come se tutti i monasteri possedessero banchi di danari!».
E frattanto angustie o querimonie eran pascolo giornaliero di più che millecinquecento moniali, ed i cantastorie di piazza sotto le loro finestre e presso i parlatorî le venivano frizzando col canto della «Storia nuova delle monache indebitate», e ripetendo ad ogni strofa l'intercalare, che faceva ridere il non colto pubblico:
Dijuna, o monaca, fa' pinitenza:Scutta li sfrazzi fatti a cridenza!171.
E poichè era risaputo che la Superiora delle Repentite non avea voluto partecipare al comune sperpero, ed alla dama della Regina avea fatto intendere che non avrebbe potuto procurarsi l'onore della regale visita, un ultimo verso della canzone esclamava:
Viva la monaca d' 'i Repentiti!
Quale fosse la istruzione nei monasteri non è facile vedere; certo, però, non dev'essere stata gran che, se nel vecchio Ceremoniale del P. Tornamira, che era il vangelo delle monache benedettine, si ammetteva che la monacanda non sapesse scrivere pur avendo imparato a leggere correttamente nell'anno del noviziato o in due anni di esso, ove uno non fosse bastato172.
Supporla però inferiore a quella dei Collegi di Maria sarebbe errore, almeno in alcune materie di cultura femminile. Il più antico di questi Collegi, quello dell'Olivella (1791) e, meglio ancora, l'altro di S.a Maria alla medesima Olivella (1740), nel primo articolo del suo Statuto prescriveva «il gratuito insegnamento alle ragazze nei lavori donneschi, nell'istruzione letteraria elementare, nell'aritmetica, nonchè della educazione morale della cristiana religione»: il che non è poco, data la scarsissima istruzione popolare. Potevano le monache non essere nel grado d'istruzione delle donzelle del Carolino; ma non è a presumerle da meno delle Collegine, anche in considerazione della inferiorità di queste al ceto nobile, e talvolta forse al civile. A ragione, peraltro, dell'ordine al quale appartenevano le monache erano obbligate a leggere gli ufficî divini.
Una prova indiretta della loro cultura nelle Arti belle e geniali l'abbiamo come nel maneggio degli strumenti musicali che si avea occasione di ammirare in molte religiose, così negli stupendi lavori di ricamo, di cera, di smalto con disegni che si eseguivano dentro gli stessi monasteri. Corridoi, sale da Capitoli, cappelle interne, cori, celle, erano ingombri di bacheche e di scarabattoli con immagini di cera, in abitini delicatissimi, ornati di drappi a fiocchettini, a frangette, a fiorellini, a foglie, ad erbe, che erano e, a chi li veda anche ora, sono una maraviglia. V'erano intere sacre rappresentazioni, scene plastiche della Bibbia, e del Leggendario dei Santi, le quali aveano assorbito lunghi anni di paziente lavoro d'ignorate artiste del chiostro, inconscie del loro valore, solo infiammate all'attuazione d'un ideale intensamente carezzato.
Quando (26 luglio 1775) la Principessa Giulia d'Avalos, moglie del Vicerè Marcantonio Colonna di Stigliano, visitò il Monastero di S.a M.a delle Vergini, Badessa la veneranda Marianna Notarbartolo dei Principi di Sciara, e si fece (giova avvertire che questa donna non era la prima del suo casato in quel pio luogo, perchè, per tradizione, le famiglie facevano di generazione in generazione entrare le loro figliuole sempre nei medesimi monasteri), come dicevasi fin d'allora, «della scelta musica», tre riscossero sinceri applausi: suor M.a Fede, suor M.a Carità e suor Marianna Emanuele de' marchesi di Villabianca, dilettanti, la prima di canto e cembalo, la seconda di canto, cembalo e salterio, la terza di violetta d'amore e violino173. E ci volle coraggio ed abilità per esporsi innanzi alla moglie di un Vicerè ed a 180 dame di Palermo che in quella occasione furono visitatrici e spettatrici.
In quei tempi le audizioni di questo genere non si pagavano.
Houel, che in qualche città dell'Isola stupì alla limitatissima istruzione delle donne anche dell'alta Società, in Palermo raccolse con piacere la notizia che una monaca, figlia del Principe di Campofranco, avesse scritto di morale174; ma se si fosse fermato un poco più sull'argomento, avrebbe saputo che altra moniale, Anna M. Li Guastelli, avea composto due poemi, uno su S.a Rosalia, un altro su Palermo.
Ma di essa, a tempo e a luogo.
Se poi la maggior parte delle monache erano di scarsa istruzione, non ne mancavano altre mediocremente istruite, le quali rappresentavano lo elemento culto d'un monastero. Queste, o alcune di queste, non eccellevano per floride condizioni economiche di famiglia, pur essendo nobili o civili; ma erano accettate come soggetti. Soggetto nel linguaggio monastico voleva dire persona di tali qualità intellettive che giovava prendere nel monastero (ed anche nel convento, se uomo) senza quell'appannaggio di corredo, di dote e vitalizio che era uno dei requisiti per l'ammissione e l'accettazione da parte delle comunità.
La soggetta occupava poi le cariche più delicate di scrittura: e se non la razionala interna, era sempre la scrivana del monastero o la segretaria della Badessa, col permesso della quale poteva tenere nella sua cella penne e calamaio; mentre le altre, al bisogno, dovevano andare a chiedere le une e le altre.
Molti e diversi i monasteri, superbi per moli, immensi per estensione, con due, tre atrii, e con avanzi, sovente ignoti alle gentili commoranti, ignorati anche dai dotti di fuori. L'ampiezza di essi era tale da consentire più d'un quartiere, e per servirci del linguaggio monastico, più d'una cella ad una medesima religiosa, e offriva persino un edificio interno di villeggiatura a tutta o a parte della comunità. Questa villeggiatura era ben diversa da quella che si faceva fuori.
Hager che volle conoscerli e n'ebbe permissione dall'Ordinario, ne visitò fino a ventidue, non tutti della medesima importanza, benchè tutti più o meno rinomati. Eran divisi fra i quattro rioni, dentro la città; ma quello di Sales, di recente costruzione, sorgeva fuori, nella via di Monreale (Corso Calatafimi). Più antico tra tutti il monastero del SS. Salvatore nel Cassaro. Per pingui patrimonî e per grande decoro aveano rinomanza i monasteri delle Benedettine del Cancelliere, delle Francescane di S.a Chiara, della Badia Nuova, delle Stimmate, di S. Vito, delle Domenicane della Pietà, delle Carmelitane di Valverde, delle Carmelitane scalze di S. Teresa, delle Minime dei Sett'Angeli, delle Teatine di S. Giuliano ed altri con sott'ordini e sottoregole di Santi e di Sante.
Le Badesse e le Priore, elette dal suffragio delle comunità, vi duravano anni ed anni in carica confermate dalla fiducia, o dal rispetto, o dalla convenienza, o fors'anche dal tornaconto dei partiti interni. Il fiore della Nobiltà palermitana eravi costantemente rappresentato; e negli ultimi del secolo (diciamo una data precisa: tra gli anni 1798-1800), suora Migliaccio, figlia del Principe di Malvagna e di Baucina (già Capitan Giustiziere e Pretore) al Salvatore, suora Gabriella Crescimanno al Cancelliere, suor Maria Buglio, che abbiam vista alla Martorana, suor Maria-Francesca Giacona o Chacon a S.a Chiara, suor Calderone dei Baroni di Baucina alla Badia Nuova, suor Maria Lucchese dei Duchi Lucchesi a Montevergine. Contemporaneamente reggevan le sorti di S.a Caterina la Rosalia Migliaccio dei Principi di Baucina, sorella della Badessa del Salvatore: della Pietà, suora Burgio dei Duchi di Villafiorita; di Valverde, suora Vannucci dei Marchesi Vannucci. L'ideale dei monasteri secondo i canti infantili dell'Isola, l'Origlione175, riposava lietamente all'ombra di suor Maria Diana dei Duchi di Cefalà.
Il monastero dei Sett'Angeli, convertito un secolo dopo in iscuola del Comune, dove taccheggiava una ignorantissima femina, onoravasi di suora Naselli dei Principi di questo nome; le Stimmate di suora Barletta dei Principi di S. Giuseppe; le Vergini, di suora Maria-Fede dei Marchesi di Villabianca, nostra vecchia conoscenza. Troneggiava Badessa di S.a Teresa la Settimo, sorella del Marchese di Giarratana, e del Sales Dorotea Lanzirotti.
Non di nobili, ma di elette famiglie borghesi menavano vanto altri monasteri che mal sopportavano di non potere stare in prima linea con quelli delle alte sfere religiose da noi serenamente e da esse dispettosamente guardate. La figlia del razionale D. Gaspare Scicli governava, è vero, la Concezione, suora Gerardi S.a Elisabetta, suora Concetta Gasparito S.a Rosalia, Suora Tomasino S. Giuliano, suora Maria-Anna di Guastelli l'Assunta, suora Rosa Lo Monaco le Repentite; ma non potevano, ahimè! esse, madri Guardiane e madri Priore, aspirare all'ambito titolo di Badesse.
Sugli ultimi piani dei palazzi del Cassaro, sotto i tetti, sporgevano, a brevi distanze, logge coperte. Quivi ad ogni pubblico spettacolo sacro o profano, religioso o civile, centinaia di testoline avvolte in candide bende si movevano irrequiete occhieggiando sulla fluttuante folla del corso. Erano le nobili suore dei Sett'Angeli e dell'Origlione, di S.a Chiara e di Montevergine e del Cancelliere, eran quelle delle Vergini e della Martorana e di S.a Caterina, le quali vi giungevano per lunghi, tortuosi cavalcavia, come quello stranamente maraviglioso di S.a Chiara, che andava di fronte al Palazzo Geraci, o per meati sotterranei, come quello che dalla Martorana riusciva sul Palazzo Gugino (Bordonaro) alle Quattro Cantoniere. Il capriccio femminile sposato all'audacia spensierata aveano con ingente spesa costruito questa specie di tunnel che a Maria Carolina parve (15 aprile 1799) opera romana. Un secolo dopo, livellandosi la via Macqueda, tra la Università e Piazza Vigliena, i retori della edilizia e della topografia della Città, alla vista di quest'opera sotterranea, si abbandonavano a fantastiche supposizioni, creandovi sopra leggende da medio evo, che solo la ignoranza e la malafede poteva far concepire.
Altri monasteri illustri (Pietà, S.a Teresa, Valverde), eran luoghi di raccoglimento e di delizia insieme, dove della stretta osservanza le monachelle aveano ragione di compensarsi con giardini e verzieri, laghetti e fontane, viali pensili e logge altissime, che esse si deliziavano a percorrere in barchette, in sedie portatili, in carrozzelle, alternandole con ufficî religiosi e domestiche incombenze. Chi vide prima della loro trasformazione S. Vito, le Vergini, la Concezione, e prima della loro delittuosa demolizione le Stimmate, potè formarsi una idea della ossequenza monacale e signorile al davidico precetto: Servite Domino in laetitia. Eppure
Pri la monaca racchiusa,Ch'avi sempri ostruzioni,Facci pallida e giarnusaIsterii, convulsioni176,
questi conforti del corpo e dello spirito non bastavano: ci voleva la villeggiatura, la quale, salvo rare eccezioni, non poteva farsi se non in campagna. La previdenza delle passate comunità o delle antiche benefattrici avea pensato anche a questo. Valverde possedeva una bellissima villa a Mezzomorreale, i Sett'Angeli una alle Petrazze, il Cancelliere a Sampolo, la Martorana a Scannaserpi. Quivi ed in altri siti ridentissimi passavano giorni spensierati intere comunità, senza preoccuparsi della lor sicurezza personale, alla quale provvedevano le alte e solide mura di cinta di clausura, ed i fattori che, di padre in figlio succedendosi, ne avean cura.
Ed anche questo non bastava.
Per breve pontificio esecutoriato nel Regno ed approvato dall'Arcivescovo del tempo, le monache di S. Caterina avevano il permesso di uscire di monastero quattro volte all'anno177. Era un privilegio speciale, che si ricordava sempre con invidia dagli altri monasteri. Pure non rappresentava una eccezione, se nelle monache era bisogno di un mutamento d'aria. L'architetto Houel intrattenendosi di questo argomento col Marchese Natale, apprese «che una monaca malandata in salute poteva uscire dal chiostro e andare dai suoi parenti, in città o in campagna», rimedio che a lui parve il più efficace a dissipare il languore, la noia, il disgusto del chiostro178. I medici erano in ciò d'una compiacenza fenomenale, e non si facevano pregare per iscrivere i loro certificati con la formula voluta: affermo con giuramento, senza la quale non si sarebbero questi riconosciuti validi.
La Curia arcivescovile un po' severa non impediva, ma forse concorreva a diminuire il numero delle monachelle girovaganti per la città. Quelle che Hager dice di aver viste a sfarfallare per le strade in carrozza, o a rimanersene fuori chiostro in casa dei parenti, col pretesto di malanni fisici, saranno state religiose professe, ma potevano anche essere educande, nei giorni di probazione, alla vigilia di monacarsi. Altrimenti non si riescirebbe a spiegare come, «vestite dei loro abiti, se ne stessero (son parole di Hager) nei terrazzi (balconi) a chiacchierare amorosamente, finchè non venisse il tempo di smetterli». Se s'incontravano in Palermo «molte dame maritate, che avean lasciata la tonaca»179, il nostro pensiero ricorre senza altro a quelle che decisero Re Ferdinando a portare a un anno le professioni (1790), ed a proibire le eccessive spese di monacazione. Gli annullamenti di voti monastici, infatti, nella seconda metà del settecento eran frequenti non solo per donne, ma anche per uomini: ed una ricerca all'uopo tornerebbe utile alla storia del costume anche sotto questo non mai guardato aspetto. La ricerca dovrebbe farsi nell'Archivio della curia arcivescovile e nelle carte del Giudice della Monarchia: qualche cosa ne dicono quelle del Vicario Capitolare Mons. Michele Schiavo180.
Agli annullamenti di voti femminili seguivano a quando a quando, anzi non di rado, i matrimonî d'amore. La monachella del Meli, stanca della vita che le tocca a trascinare nel chiostro, spiattella chiaro e tondo che ha fatto la sua brava petizione di nullità dei voti, e che non sì tosto riuscirà allo scopo, sposerà il suo attivo difensore legale:
L'avvocatu miu alligantiGià cumprènniri m'ha fattuChi pri mia ni nesci mattu:Spusa sua certu sarrò181.
Nè questa è poesia. Assistita dall'abile avvocato Don Onofrio Paternò, suor M.a Antonia Trigona vinceva la sua lunga causa di svestizione. Ella, col titolo di Baronessa di Spedalotto, Cugno, ecc., ereditava feudi considerevoli. Ed eccole a ronzarle attorno vagheggini e pretendenti. Vogliono essi dar la scalata al bell'edificio dei trentasett'anni di lei, ovvero al suo blasone? Probabilmente no: ella ha seimila scudi annui, e quei seimila fan gola a giovani e ad uomini maturi. Donna Maria-Antonia però
Sta come torre ferma che non crolla,
perchè è innamorata pazza del suo avvocato, il quale, dimenticando i begli occhi della Marchesa Flavia Mina-Drago, ne tiene ambe le chiavi, quella cioè del cuore e quindi della bella persona: e quella del tesoro d'argento. La seguente canzone siciliana, attribuita alla poetessa vedova D'Angelo, fece (1784) il giro degli eleganti salotti:
Middi livreri supra 'na cunigghia,Quali s'era a Diana dedicata,Cci currevanu appressu a parapigghia,Ed idda intantu si stava ammacchiata.Ma un guzzareddu (oh chi gran maravigghia!)Cu tuttu chi 'na lebbra avia appustata,Lassa la lebbra e c'un sàutu la pigghia,E fici a tutti 'na cutuliata182.
Non dissimile il caso di suor Giuseppa Teresa, quale dopo di essere stata vent'anni col ruvido saio all'Assunta a sbisoriare ufficî divini, alla medesima età della Trigona, per sentenza dei tribunali competenti tornava al mondo muliebre Donna Giovanna Moncada, sorella, nientemeno, di S. E. il Principe di Paternò. Poteva mancarle un marito? Ed ella se l'ebbe infatti pel Natale del 1789 nel Marchese di Castania D. Bartolomeo Avarna183.
La prospettiva della svestizione sorrideva lietamente a quelle tra le moniali che non si sentivano di durarla in mezzo alle miserie, alle piccinerie del chiostro. «Oh se le cose mi vanno a seconda, esclamava la povera Monaca dispirata del finissimo Meli, come sarò felice! Ho tutta la speranza di vedermi sciolta della professione, perchè varî ne sono i motivi:
E d'allura in poi, in avanti,Nun saròggiu cchiù 'nfelici;Di lu munnu chi Diu ficiComu l'autri gudirò.»
E che erano mai codeste miserie e piccinerie del chiostro? Ce lo dice appunto il poeta nel citato componimento, che nel genere è l'unica fedele pittura di quella vita.
La monaca messa in iscena è, a quanto pare, di famiglia civile, e lamenta la perduta libertà, la pace, la gaiezza della gioventù. I genitori la fecero entrare in monastero bambina; cresciutella, le dipinsero come un serpe velenoso il mondo, come una schiavitù il matrimonio, come un boia il marito. Spaventata, non volle più uscire dal chiostro; ma dovette accorgersi d'essere stata ingannata: senza di che, non si troverebbe ora chiusa fra quattro mura, vestita di nero, col capo raso come quello dei forzati, e con le
... scarpi grossi e chiani,Cu buttuna e lazzitedda,Senza fibbii a l'oricchiedda,Cà s'apprenni a vanità184.
Al domani della riscossione del vitalizio, tra spese grosse e minute non le resta un quattrino. Il vitalizio
Si nni va pri cumprimentiA lu patri cunfissuri,Chi a li gradi tutti l'uriLa stravïa185 quantu pò.
Ella torna dispettosa alle insidie lusinghiere dei genitori e dei parenti, e prosegue numerando le male arti di tutti per sorprendere la sua buona fede, e la maniera capziosa ond'essa fu costretta a dare il suo assenso, e le finzioni dello zio, che vedendo non potersi arrivare a coprire le spese necessarie per lei, aggiunse qualche cosa del suo, e l'intervento dell'avvocato, del professore (procuratore legale) e del notaio, che la crucifissero come Cristo. Circondata in tal guisa da persone tutte interessate a sacrificarla, la inesperta e debole ragazza rinunziò al mondo e fino al nome di battesimo. Ed ora, ahimè! è una infelice tra infelici.
Cuminciannu ccà di mia,Quantu monachi cci sunnuVurrian'essiri a lu munnu'Ntra li spassi chi cci sù.
E la vita sua scorre in continui tuppertù, fra sospetti e gelosie, in mezzo a compagne disperate, tra sorveglianze e sorprese, in superbia ed invidia: affettate, schifiltose, malaticce e scontente di tutto e tutto pubblicamente lodando. Le sue consorelle son la curiosità in persona, e mentre non si occupano di nessuno, sanno i fatti di tutti, e ostentano virtù e santimonia186.
Differenza di ceti, e tra questa, divisione di un medesimo principale ordine religioso, suscitavano e mantenevano gare tra un monastero e l'altro. I monasteri di primissimo ordine guardavano dall'alto al basso quelli che accoglievano monache di famiglie semplicemente civili. Questi, d'altro lato, mettevano in ridicolo il fare pretenzioso di quelli, e perchè non potevano eguagliarli, tenevan le ciglia in cagnesco. La visita dianzi ricordata della Vice-regina Colonna di Stigliano ne è un saggio: quella della Regina Carolina, una conferma.
Le moniali di S.a Caterina e le moniali della Pietà erano domenicane: ma quelle si vantavano, o eran dette figlie di Don Domenico, e queste strillavano a sentirsi dire figlie di Mastro Domenico. San Domenico aveva il Don in un monastero aristocratico, e contava per mastro, che è quanto dire operaio, manuale, in un monastero di media levatura.
Codesti dispetti affilavan le armi della maldicenza: nessuno monastero poteva sottrarvisi, neanche quelli che meno la pretendevano a ricchi, a nobili, ad antichi. E se per poco uno simpatizzava con l'altro, e in una solenne occasione entrambi si scambiavano cortesie, la simpatia costava loro cara pei commenti che vi facevano sopra le altre comunità. Un invito delle monache di S. Chiara a quelle della vicina Martorana nella visita di Maria Carolina (18 aprile 1799) informi.
A cosiffatti dispetti pigliavan parte con largo contributo di burlette e di aneddoti i reclusori ed i ritiri, che raccoglievano umili donne, o fatte collocare dalle famiglie, o reiette dalla società e dalla fortuna. Era anche qui una delle molte, sgradevoli manifestazioni di chi non ha contro chi ha, di chi non è contro chi è. La non favorevole corrente si tramandava col volger dei tempi. Dal giorno della tempestosa soppressione del 1866 ad oggi, per ragioni diverse e non tutte ponderate, varî monasteri, come molti conventi, sono stati o demoliti o destinati a servizî pubblici e non publici; le comunità, ridotte di numero, si son fatte passare in monasteri tuttavia ospitanti la vecchia primitiva e propria comunità, stremata di morte e non più impinguata da nuove giovani esistenze. Un monastero, ad esempio, per ineluttabile fatalità di eventi e per volere della suprema autorità ecclesiastica, accoglie le nobili moniali delle Stimmate e dei Sett'Angeli; ma le tre comunità vivono ciascuna a sè, con la propria regola e con le proprie gerarchie, in posti diversi del medesimo edificio, isolate, senza cercarsi, pure incontrandosi. Dove finisce il recinto d'una parrebbe di dover leggere il famoso: Nec plus ultra delle colonne d'Ercole. La buona educazione le avvicina, le assorella nelle malattie, nei giorni del dolore; ma la tradizione le tiene autonome. Ognuna per sè e Dio per tutte.
Una delle ragioni di dispetto, o per lo meno, di noncuranza di monache a monache era la differenza d'istituti nei quali esse convivevano. Le nobili comunità potevano essere animate dai più sinceri sentimenti religiosi, ma non potevano dimenticare la loro origine, che di loro faceva un corpo distinto, superiore ad altri che pretendevano alle medesime entità religiose. L'argomento pare frivolo, ma per esse non lo era. Nei monasteri si professavano voti di povertà, castità, obbedienza secondo le varie regole dei fondatori. Questi voti eran solenni e perpetui: nè c'era Ordinario che potesse sospenderli o annullarli, Ora da un secolo e più, per graduale modificazione di vita e di idee, non poche opere pie laicali femminili si eran venute trasformando fino ad assumere carattere religioso interamente diverso dall'originario. Il primo istituto di emenda della città, quello delle ree pentite dello Scavuzzo, a poco a poco venne escludendo le donne di mala vita ed accettando le sole vergini. Nello scorcio del secolo, lo Scavuzzo era già una badia in tutta forma e in tutto tono. Il ritiro delle donne peccatrici sotto titolo di S.a Maria Maddalena a S. Agata la Guilla non voleva più sentire a parlare di male femmine; e benchè contrariato in questo dalla Sacra Congregazione di Roma, si atteggiava a vita monastica con abito carmelitano e con superiora avente il pomposo titolo di Badessa. Questo tramutamento di un ricovero di beneficenza in un luogo claustrale avveniva in altri istituti, come, del resto, avveniva anche fuori Sicilia. L'autorità ecclesiastica per far entrare tutto sotto la sua giurisdizione non si opponeva, anzi favoriva la tendenza; l'autorità civile rimaneva indifferente187. Aggiungasi le velleità delle collegine, le quali con voti semplici e temporanei si atteggiavano a professe di voti solenni, ed esercenti pratiche e doveri da monache professe: e si avrà la chiave della tacita avversione delle monache autentiche a quelle che non lo erano.
Forti della loro onestà, alla quale e da donne siciliane e da moniali tenevano come alla cosa più sacra di questo mondo, molte scrupoleggiavano intorno alla clausura imposta dai canoni. A questo concetto ragionevole ma sommario vuolsi attribuire la esagerata osservanza di regole e prescrizioni rigidissime, rigidamente osservate. Nella visita dianzi ricordata della Regina Carolina (1º apr. 1799) alla badia di Sales, la nota discordante fu l'intervento dei cavalieri di seguito della regale visitatrice: e lo sdegno della superiora, anzi della comunità tutta esplose in un accentuato ricorso al Vicario generale dei monasteri Mons. Lodovico del Castillo188. Se l'arcivescovo Lopez, pensavano, fosse stato in Palermo, questa trasgressione dei sacri canoni non sarebbe avvenuta, anche perchè, venendo egli sovente all'Albergo delle povere, guardava con occhio benevolo il monastero.
La cronaca del tempo ha in proposito un fatto gravissimo, che poco mancò non finisse in una terribile tragedia.
Il Capitano di Giustizia Tommaso Celestre, Marchese di S.a Croce, aveva una cugina nello Scavuzzo, la Duchessa di Reitano, Caterina Colonna. Un giorno che la seppe malata, volle andarla a visitare. Ma lo Scavuzzo era già divenuto badia, e la badia aveva clausura. La superiora nega il permesso di entrata. Il Celestre minaccia misure violente; la superiora tiene fermo: e allora il Celestre (nel quale tu non sai se devi riconoscere un privato, a cui non era fatto lecito varcare le caste soglie d'una badia, o un magistrato di giustizia) fa atterrare a colpi di scure la porta di entrata. Le monache, più morte che vive, son pronte a respingere con la violenza la violenza, si asserragliano in alto dietro le finestre, e combattono disperatamente contro maestri e sbirraglia lanciando loro addosso pietre e acqua bollente. A battaglia finita, la superiora ci prendeva una carcerazione allo Spedaletto; ma si dichiarava soddisfatta di aver ceduto solo alla forza.
Questa scenata, è bene si sappia, avveniva il 10 gennaio del 1782, quando il Vicerè Caracciolo percorreva in lungo e in largo la via delle riforme in Sicilia e nella vecchia Capitale.
Un'ultima tra le curiosità della vita monastica.
Possiamo noi chiudere questa lunga esposizione di costumi, senza ricordare il più notabile di essi nel campo culinario?
Ciascun monastero aveva una piatta, un manicaretto, ch'era come il suo distintivo. Giacchè, non pur l'emblema in marmo o in legno sulla porta del monastero (le braccia incrociate per le francescane, il Charitas per le paoline, il cane che porta in bocca una fiaccola accesa per le domenicane ecc.) formava il blasone di esso, ma anche il dolce speciale solito a farsi nel monastero medesimo. Tutti i pasticcieri della città gareggiavano nel comporre d'ogni maniera ghiottornie: ma chi poteva mai raggiungere la squisitezza delle feddi (fette) del Cancelliere, dei frutti di pasta dolce di mandorle della Martorana, del riso dolce del Salvatore? Tutti preparavano conserva di scursunera (scorzanera): ma nessuno attingeva alla perfezione di Montevergine, come nessuno a quella della cucuzzata (zucca condita) e del bianco mangiare (specie di gelatina di crema di pollo) di S.a Caterina. Molti menavan vanto del loro pane di Spagna ma in confronto a quello della Pietà, qualunque dolciere doveva andarsi a riporre, lasciando che questo si contrastasse il primato con lo Stimmate nella bellezza delle sfinci ammilati, che pure nel medesimo monastero assurgevano a squisitezza impareggiabile nella forma delle sfinci fradici, composte di uova e panna.
La lista di tante golose specialità ci offre altresì le caponate dei Sant'Angeli, le ravazzate di ricotta di S.a Elisabetta, le impanatiglie di conserva dell'Origlione, le quali accrescevano lustro e voluttà alle mense dei signori non meno che le bibite diacce d'amarena giulebbata nei giorni estivi. Centinaia di cassate si riversavan fuori di Valverde per la festa di Pasqua, e settimane prima, pel Carnevale, migliaia di cannoli di vera ricotta con relative teste di turco e cassatelle della Badia Nuova, alla quale nessuno poteva negare la palma nella inaugurazione del calendario dei rituali dolciumi. Se S. Vito pompeggiava con i suoi agnelli pasquili, la Concezione con le sue muscardini pel festino di S.a Rosalia, i Sett'Angeli con le loro mustazzoli, e S.a Elisabetta con le sue nucàtuli per Natale, in tutto l'anno tenevansi in alta fama le Vergini con le impareggiabili loro mussameli e, meglio, con certi pasticci, il nome dei quali si presta anche oggi ad un poco decente qui pro quo. Grandeggiavan da ultimo S.a Teresa con le cassate in freddo, e S. Vito, mirabile dictu! col suo sfinciuni, un vero poema per i più autorevoli maestri di gusto, come la pasta con le sarde, complesso piatto nazionale della felicissima non che golosissima Capitale dell'Isola.
Certo, non si poteva andare più in là nella raffinatezza del mentovato quinto peccato mortale189.
Ma v'erano monasteri d'origine inferiore, che tanto lusso non potevano permettersi: ed anch'essi, nelle loro modeste sfere, godevano rinomanza, quale per lo scàcciu: ceci, mandorle, fave, avellane abbrustolite (Cappuccinelle), quale per le olive piene (Assunta), quale per altro190.
E come a lato del male sta il bene, così quasi a rimedio delle inevitabili indigestioni per tanti pasticci, cassate, cannoli, frutti, ravazzate, creme, zuccate, sfinci, sfincioni, olive e mandorle, la badia di S.a Rosalia compieva il pietoso ufficio di preparare un antacido medicinale, di sicurissimo effetto.
CAP. XI.
DI PREMINENZE IN GIURISDIZIONI.
Una mezza dozzina di secoli aveano apportato tante divisioni di poteri, tante distinzioni di diritti, e perciò tale cumulo di giurisdizioni e di preminenze che solo i più colti eruditi possono oggi raccapezzarvisi.
Meno la bassa gente, come nel sec. XVIII anche ufficialmente chiamavasi l'infimo ceto, tutti accampavano qualche diritto all'ombra del quale confortarsi. Patrizî, ecclesiastici, militari, civili, maestri e, fino al 1782, ufficiali della Inquisizione, componevano vere e proprie caste con privilegi, prerogative, immunità che a nessuno era lecito non che di toccare, neanche di discutere. A toccarli c'era da incontrare infiniti fastidî, e forse da buscarsi qualche processo. Ad ogni passo una costituzione che concedeva, una prammatica che limitava, un rescritto che inibiva, un bando che distingueva, un canone che tassativamente prescriveva. Per lievi trasgressioni, talora per semplici dimenticanze, magari per nulla, si lanciavano ricorsi al Pretore ed al Senato, alla Giunta dei Presidenti e del Consultore, al Capitan Giustiziere, al Presidente della R. Gran Corte, all'Arcivescovo, al Giudice della Monarchia, al Vicerè, al Sovrano. Gli è che non volevansi pregiudicate competenze e prerogative di qualunque genere, fossero anche di nessun valore.
Meglio di qualsiasi parola sull'argomento gioveranno i fatti che verremo brevemente esponendo. La cronaca è malauguratamente ricca e ne fornisce per tutti i ceti e per tutte le giurisdizioni: il difficile sta nella scelta.
Un giorno (17 luglio 1774) tre degli otto commissarî della Corte Capitaniale venivano catturati da una ronda delle Maestranze per un furto qualificato nel quartiere della Conceria (mandamento Castellammare) e condotti nella Carboniera, noto carcere dentro il palazzo del Comune. Il Duca di Villarosa, Capitano Giustiziere, se ne risente come di offesa alla sua persona; ed energicamente li reclama. Alla sua il capo ronda ne chiede giustizia sommaria. Il Pretore, Principe di Scordia, è in grave imbarazzo, e per gettare un po' d'acqua sul fuoco e contentare il Villarosa fa trasportare in sedie volanti alle segrete del Castello i tre rei e li mette a disposizione del capo della Giustizia; ma per non dispiacere alle Maestranze li invia accompagnati dalle ronde di esse. Così dà un colpo al cerchio ed uno alla botte. Ma poichè le Maestranze insistono presso il Pretore, lor capo diretto, e presso l'Arcivescovo, funzionante da Vicerè, acciò la causa venga tolta alla autorità regia, che vuol mandare a casa i rei, e data alla comunale, al Pretore cioè, questi illico et immediate si fa condurre innanzi gl'imputati, e senza tanti discorsi te li condanna ad una solenne bastonatura. E non basta. Il Vice-Capitano, che ha sostenuta la competenza della Corte Capitaniale, solo per questo vien destituito; ed il Re, tuttavia impressionato dei recenti tumulti contro il Fogliani, conferma alle Maestranze la facoltà di rondare di notte, salvo a ritoglierla loro in capo ad un mese per affidarla agli ufficiali regi di giustizia191.
L'ultima scena del piccolo dramma stupisce per la pena inflitta al funzionario giustiziere: e forse potrebbe avere una spiegazione pel tempo in cui essa si compiva. Eppure, diciott'anni dopo, quando si era alla vigilia del novantatre, accadeva qualche cosa di peggio.
D. Giuseppe Bracco, ufficiale della R. Segreteria, a cagione di debiti veniva inviato innanzi al Giudice pretoriano, cui copriva d'ingiurie. Questi un po' pei debiti, un po' per le ingiurie, ne ordinava il carcere nella Vicaria; ma la Vicaria era pei plebei: e Bracco non era un plebeo. Gli ufficiali di Corte Senatoria offesi nella dignità del loro compagno e del loro ceto, facevano contro il Giudice un ricorso a Fr. Carelli, Segretario interno del Regno di Sicilia. Risultato ultimo (18 sett. 1791): Sebastiano Procopio, che era al termine della sua onorata carriera giudiziaria, veniva chiuso in prigione192!
Proprio è il caso di esclamare: Da carceriere a carcerato!
Per recente abuso il Maestro Razionale del Senato arbitrava di sedere insieme col Pretore, coi Senatori, col Sindaco, negli stalli d'onore. L'abuso non si volle più tollerare; il Senato, senz'altro, lo proibì. Offeso pur esso nella sua dignità, il Maestro Razionale se la legava al dito aspettando un'occasione per prendersi la rivincita. I Senatori si tenevano di un ceto superiore o diverso da quello di lui, che vantava pure i suoi quarti secolari di nobiltà: senza di che non avrebbe potuto occupar la carica che occupava. Il 14 settembre del 1792 ricorreva la festa di S.a Rosalia. Il Senato in tutta pompa recavasi nelle sue pittoresche carrozze alla Cattedrale; ma non s'accorgeva che la carrozza ultima degli ufficiali nobili, tra i quali doveva essere il Maestro Razionale, seguiva vuota, sì che al giungere alla chiesa degli Espulsi (come allora pure si chiamava Casa Professa) si trovava solo. Gli ufficiali, offesi, se ne erano rimasti come Achille nelle loro tende. Una congiura, astrazion facendo dal signor Razionale, era stata ordita: attori, quegli ufficiali, impermaliti della recente ordinanza senatoria, la quale prescriveva dover essi «intervenire a tutte le funzioni del Senato: vespri, messe solenni, processioni, occupando solamente il luogo dopo il postergale del Senato ai stalli dei RR. Canonici»; ed al Maestro Cerimoniere inculcava l'osservanza dell'atto193.
Essi strillarono, ma stavolta il Magistrato non volle piegarsi.
Chi crede siffatti risentimenti, nel palazzo delle aquile, nuovi e limitati agli ufficiali di alto casato, si inganna. Essi erano periodici scatti di vecchi malumori, suscitati dal desiderio di non far credere che si dovesse dagli ufficiali medesimi stare in seconda linea, e dalla vanità di primeggiare. Il difetto partiva dalle sfere superiori e, per le medie, scendeva sotto forme diverse nelle infime. Fu osservato allora che già un secolo innanzi (1687) il Principe di Valguarnera Pretore avea, per causa di giurisdizione, litigato col proprio figliuolo, Conte d'Assoro, Capitan giustiziere. Si discuteva la soverchia circospezione di D. Scipione Di Blasi, che, essendo infermo il Pretore Conte S. Marco, (1720), da Sindaco avea guardato bene a ciò che dovesse fare nella processione di S.a Rosalia affin di non incorrere nel biasimo di avere invaso un campo di giurisdizione rigorosamente circoscritto dal Cerimoniale senatorio. Ma questo esempio fu riconosciuto degno d'imitazione allorchè essendo il Principe di Trabia, nelle feste patronali del 1767, obbligato a guardare per podagra il letto, ne compieva le funzioni il Maestro Notaro D. Vincenzo Giovenco, e ne riportava lode di correttezza nello aver saputo armonizzare la rappresentanza che gli era possibile con quella della quale il Pretore effettivo era investito194.
Chi poi sorride a codeste piccolezze ne ha ben donde, ma consideri che queste ed altre formalità consimili pigliavan carattere di somma importanza, e provocavano dispacci reali e vicereali. Se così non fosse stato, non avrebbe dovuto S. E. il Vicerè Principe di Caramanico pensare in tempo ad ordinare con tanto di decreto che nella processione del Corpus Domini, essendo anche stavolta malato il Pretore (1788), funzionasse il Priolo tra i Senatori (come a dire l'Assessore anziano o delegato, o il prosindacato d'oggi): e che il solo Avvocato fiscale della Corte Pretoria dovesse, dopo il seguito dei nobili, separatamente intervenire195.
Già più innanzi, nel corso di quell'opera, abbiam veduto quanto il Senato tenesse al titolo di Eccellenza, ed a quali accordi addivenisse pel retto uso di esso.196 Accade ora avvertire quanto vi tenessero anche altri senati nell'Isola, i quali se ad alti personaggi del Governo lo attribuivano, non intendevano esserne come per contraccambio da essi privati. Ricordiamo in proposito il seguente aneddoto, non singolare certamente, ma caratteristico.
Era il marzo del 1793, e la Sicilia trascinavasi negli orrori della carestia. A renderli men gravi due commissarî generali vennero dal Governo con pieni poteri inviati separatamente in Sicilia. Uno di essi, il Barone Gioacchino Ferreri, ex-giudice della Gran Corte, giunto a Caltagirone, si rivolgeva, per fornire la sua missione, al Senato: questo fu sollecito agli ordini di lui trattandolo dell'Eccellenza. Ferreri avrebbe dovuto rispondere dell'Eccellenza, titolo al quale quel Senato aveva o credeva di aver diritto; ma rispose invece dell'Illustrissimo. Il Senato se ne adontò e, rendendogli lì per lì la pariglia, lo trattò del medesimo titolo. L'offeso se ne richiamò subito ai ministri di Palermo. Il Senato di Caltagirone, reo non sai se di crimenlese o di una frivolezza, fu fatto venire innanzi al Vicerè a dar conto del non dato titolo: ed il più giovane dei Senatori, D. Giuseppe Aprile, senza neppure salutare i suoi, corse a Palermo, e dopo un forte rimprovero del Caramanico, dovette andare da S. Eccellenza il Ferri a dargli soddisfazione del mancato riguardo197. Ma il nobile giovane fremendo dentro di sè per la immeritata ammenda, deve fra i denti aver mormorato: Paglietta d'un giudice!... non tibi, sed Petro!
Anche quel buon uomo di D. Ippolito De Franchis risentivasi della comune vanità. E come, del resto, non risentirsene stando egli tutta la santa giornata nel Palazzo senatorio?
D. Ippolito — il lettore lo conosce bene — era Maestro di Cerimonie e Banditore della Città: ma era anche mazziere. Questo terzo ufficio non doveva parere all'altezza degli altri due, dato pure che fosse con quelli compatibile; sicchè egli chiese una volta di esserne dispensato affidandosi a persona sua ed a sue spese. E poichè si trovava a domandare, pregava «gli si concedesse la manica di gala ed il banco da sedere al principio della predella del Senato, prossimo al Pretore nelle funzioni particolari; ed in quella della Cattedrale, il primo stallo dei beneficiati».
Gli esempî son sempre contagiosi. L'agente del Senato, piacendogli infinitamente il favore concesso a D. Ippolito, ne sollecitò uno per sè, quello «di far la referenda degli affari litigiosi stando a sedere vicino al Maestro Notaro o del Razionale del Senato»198.
Dal palazzo del Comune passando alle varie sedi di giurisdizioni ecclesiastiche e religiose bisogna aprir bene gli occhi. Il terreno è irto di rovi e non si sa dove mettere i piedi. Dal parroco Mendietta della Kalsa, che per la processione infra ottava del Corpus Domini chiedeva di poter trattare con l'offerta dell'acqua santa nella sua chiesa di Niccolò Anita la nobile Deputazione del Monte di S.a Venera, filiale del Senato, al Parroco dell'Albergaria D. Giuseppe Rivarola, che durante i restauri della sua chiesa doveva ingozzar tutte le restrizioni e tutti i veto degli officianti di Casa Professa, provvisoria cattedrale e parrocchia ad un tempo, era un laberinto, nel quale riserve e proibizioni si guardavan di continuo senza accordarsi mai, pronti a venire a conflitto se per poco si credessero toccati nei loro interessati.
I monasteri eran quelli che in ciò davan molto da fare alle autorità. Le benedettine di S.a Rosalia, forti di non so che breve, non intendevano rassegnarsi alla giurisdizione del parroco di S. Giovanni dei Tartari quando ad una loro consuora doveva somministrarsi il viatico e la estrema unzione.
Una monaca paolina dei Sett'Angeli otteneva dal Papa di professare nel monastero della Pietà i voti domenicani. Quel che seguì all'annunzio del breve pontificio non è credibile. I due monasteri venivano a conflitto tra loro e volevano tirarvi, anzi vi tiravan dentro, S. Francesco di Paola e S. Domenico. «Il Papa, gridavano, non ha questa facoltà; e se l'ha, doveva prima sentire la Correttrice dei Sett'Angeli e la Provinciale della Pietà, o per lo meno il parere degli Ordinarî». Si ricorse al Giudice della Monarchia: l'Arcivescovo sosteneva le parti del Papa; il Vicerè quelle del Giudice199, e dopo una lite fastidiosamente lunga, a dispetti e mormorazioni dovette ottemperarsi ai voleri del Papa.
A Mons. Airoldi, nominato vescovo in partibus, sarebbe piaciuto consacrarsi nella chiesa del Salvatore, nel cui monastero vivea una sorella di lui: ma non volendo esporsi al biasimo di esser venuto meno a non so che competenza, pro pacis amore egli doveva rinunziarvi, e sostituire al Salvatore la privata cappella del Seminario arcivescovile200.
Moriva l'Arcivescovo Sanseverino (1793), ed al palazzo si disponeva il grande corteo funebre. La Compagnia del SS. Sacramento della Cattedrale voleva prendervi parte, ma le Compagnie della Pace e della Carità si opponevano, toccando ad esse, del ceto nobile, il posto. Frattanto i Canonici avrebbero voluto che la loro confraternita andasse immediatamente innanzi a loro; ma i Domenicani alla lor volta tenevan fermo perchè immediatamente innanzi al Capitolo non poteva, non doveva andar altro che l'Ordine dei Predicatori: e gloriam meam, esclamava il Provinciale di esso alteri non dabo!
Il sac. D'Angelo, presente alla incresciosa discussione, sdegnato della inevitabile sconfitta del Capitolo al quale apparteneva, dolevasi che anche nel suo «secolo illuminato la superbia e la frateria facessero andare avanti i loro pregiudizî e cantassero vittoria».201
L'intervento del Senato alle chiesastiche funzioni imponeva doveri estremamente delicati negli officianti. Guai se durante una di esse nella Cattedrale il Magistrato civico non ricevesse le incensate in perfetta regola! Nelle messe solenni, dopo l'offertorio e la incensazione dell'altare, il Cerimoniere del Comune s'avviava all'altare a prender l'incenso pel Senato. Un terminatore ed un canonico, diacono assistente, partiva con lui; un terminatore e un diacono assistente partiva pel Capitolo. Contemporanee, quasi isocrone, dovevano essere le incensazioni. Più e più volte s'era dovuto occupare non solo il Senato, ma anche l'autorità ecclesiastica di questa faccenda gravissima, già stata portata in tribunale del Vicario generale in sede vacante della diocesi202. Al canto dell'Agnus Dei il Cerimoniere saliva all'altare a prender la pace: un suddiacono e un terminatore movevano da soli pel Capitolo. Senato e Capitolo dovevano ricever l'abbraccio della pace eodem tempore: e guai un indugio offendesse la maestà dell'uno, la dignità dell'altro! D. Girolamo de Franchis, allontanandosi per una cerimonia qualsiasi dal Magistrato pretorio, o ritornandovi, sapeva delle riverenze di rito da fare. E se non lo sapeva lui, consumato in codesto galateo obbligatorio, chi doveva saperlo?
Guai ancora se in una sacra funzione per festa o per lutto, al Senato, al Capitan Giustiziere non venisse esibita una torcia del peso e delle dimensioni loro dovute: un rotolo e mezzo per uno (gr. 1200)! Il Vicerè stesso, che come prima autorità avea il diritto di riceverla di due rotoli (gr. 1600), avrebbe chiamato al dovere i negligenti ed i colpevoli.
Queste ed altre formalità aveva in dispetto il Marchese Caracciolo e cercava ogni occasione, ora per riporle, ora per isvilirle, o se possibile sopprimerle, anche a scapito della real dignità ch'egli impersonava. L'aneddoto che diremo fu pei rigidi osservatori delle etichette il colmo dello scandalo.
Nelle cappelle reali il Vicerè rappresentando pel Re il delegato apostolico, avea facoltà di stare, durante la incensazione, a capo coperto. Diciamo facoltà e diciamo poco; giacchè si trattava d'un privilegio d'ordine superiore: e gli spettatori, al momento supremo, in punta di piedi, sulle sedie, si godevano la straordinaria particolarità della scena. Or nella cappella reale tenutasi per le feste di S.a Rosalia del 1782 (quelle appunto che il Caracciolo voleva più tardi ridurre a soli tre giorni), il Vicerè in onta della vecchia consuetudine si argomentò di scoprirsi. Conoscendosi l'uomo, bisogna metter fuori campo la sua riverenza all'incensatore; il Caracciolo si scoprì appunto perchè poteva stare, per privilegio, coperto. Allora un mormorio d'indignazione accolse l'atto: e per tutta la città fu con generale risentimento raccontato che s'era tenuta una cappella senza cappello203.
Un vero scandalo!
Questa è storia; ma la tradizione racconta aneddoti molto più curiosi.
Un canonico non essendo riuscito ad aver giustizia per la via ordinaria di giurisdizione, un giorno chiedeva ed otteneva udienza dal Caracciolo. Giunto alla presenza di lui, con la maggior serietà del mondo gli esponeva come qualmente in una funzione pubblica di chiesa, egli, canonico, non avesse ricevuto le incensate alle quali avea diritto. — «E quante ve ne spettavano?» chiese bruscamente il Caracciolo. — «Tre, Eccellenza.» — «E quante ve ne dettero?» — «Due soltanto» rispose incorato il canonico. — «Eccovi il resto!» esclama concitato il Vicerè; il quale levandosi improvvisamente da sedere, pieno di rabbia, imitando con le braccia e le mani l'atto dello incensare, lo spinge indietro a furia di cazzotti e di pugni sul muso, fino allo scalone.
Abbiamo sfiorato appena l'argomento, quanto altro mai fecondo di comici aneddoti. Qua e là, del resto, nel corso di quest'opera, molti se ne possono riscontrare, documenti della vita pubblica del tempo. Laonde nel medesimo anno che il Caracciolo lasciava lo ingrato viceregno dell'Isola (1785), un prete di buona famiglia e di egregio casato non poteva tacere questa dolorosa verità:
«È degna di ammirazione e di lode la costanza sacerdotale nella difesa dei proprj diritti; ma è biasimevole nell'affare dei giusti diritti della Corona: guai a quelle società cristiane in cui si sostengono queste pugne! La nostra Isola ne soffrì profonde nel 1713, in tempo che passò dal dominio di Filippo V a quello di Vittorio Amedeo. E perchè? per un pugno di ceci negato da un bottegaio di Lipari al Maestro di Piazza di quel paese; perchè essendo del vescovo (il celeberrimo Mr. Tedeschi), veniva a ledersi l'Ecclesiastico Foro.
«Che inquietitudini per un sedile? che voci per un luogo di confraternite! che pugna per la destra e la man sinistra! che risse per una grippa sotto la croce! che contrasti per darsi a un cadavere l'ultima voce!»204.
CAP. XII.
IMPETI E RAGAZZATE.
I diaristi palermitani si danno molta cura di raccogliere certi fatti di cronaca, che con singolare efficacia illustrano il tempo del quale ci occupiamo.
Sarebbe grossolano errore trarre da quei fatti conseguenze e quindi giudizî generali sulla gente del paese. In tutti i ceti — è superfluo il dirlo — si riscontrano violazioni di Legge: e forse le violazioni dello scorcio del secolo XVIII furono relativamente men numerose di quelle di tempi detti o creduti più civili. Pure non vanno esse trascurate, e concorrono se non altro a far comprendere in che maniera s'intendesse da taluni la posizione nella quale società e istituzioni collocavano e guardavano certi uomini.
Se si analizzano i racconti che abbiamo avuto occasione di leggere, si vedrà che essi derivavano dall'esagerato, anzi dal falso concetto che alcuni giovani aveano della propria origine. Ad ogni passo s'invocavano diritti e distinzioni: e per gli uni e le altre cercavasi appoggio alle granitiche muraglie dei privilegi di casta.
Per quanto c'incresca, noi non possiamo passarci da una breve rassegna nel campo apertoci anche stavolta dalle scritture inedite del settecento: breve rassegna delle molte cose onde è malauguratamente piena la cronaca paesana.
Il lettore si armi di santa pazienza, e guardi con un po' di stoicismo le figure che gli sfileranno innanzi. Cominciamo con una donna.
Girolama Caldarera, Baronessa di Baucina, non conosceva limiti alla sua potenza. Sostenendo nei tribunali certa sua causa, un giorno usciva in male parole all'indirizzo del Giudice della G. C. Criminale. Quali fossero le parole, nessun testimonio ci sa dire: e forse non vi furon testimonî. Il carcere l'attendeva in un monastero, e vi sarebbe stata senz'altro condotta se la Regina Carolina non avesse dato alla luce uno dei soliti principini cosicchè la Calderara se la cavò con un po' di paura e di dispetto.
Il lieto evento era anche fortunato per un giovane Marchese (1787). Teneva costui, come oggi si direbbe, in sofferenza al Monte di Pietà alcuni pegni. I Governatori del pio Istituto aveano avuta molta, fin troppa longanimità rimandando di mese in mese la vendita degli oggetti pegnorati; ma, attendere più oltre non potevano quando a' poveri bisognosi facevano ben diverso trattamento: sicchè ordinavano la vendita degli oggetti nella Loggia. Il Marchese se l'ebbe a male e, recatosi al Monte, copriva d'insulti il governatore Giuseppe Ugo delle Favare. Questi si tenne dignitoso: e lì per lì gli fece infliggere due giorni di prigione: pochini, invero, e non per piacenteria o per timore del Capitan Giustiziere, ma, come abbiam detto, per la improvvisa notizia della nascita d'un principe reale205.
Se per esigenze di pubblici servizî il Pretore vietava il passaggio delle carrozze nel Cassaro nei giorni delle feste di S.a Rosalia, e le guardie di Marina stavano pel buon ordine, v'era chi si permettesse di contravvenire all'ordinanza. Nella lista dei contravventori è Andrea Reggio, che avanzavasi baldanzosetto con la sua carrozza. Ben glielo impediva un soldato comunale; ma egli bravando la consegna, lo copriva d'ingiurie e minacciavalo persino di vita.
Il Reggio contava 16 anni appena!
Qui è la prepotenza: e di prepotenze era ad ogni piè sospinto una triste fioritura. Reagire a chi si opponesse al libero esercizio delle loro facoltà, le quali non erano se non aperti abusi: ecco la massima di alcuni giovani, indocili a superiori e ad eguali.
A coteste massime informato, un certo ragazzo in una pubblica via, fremeva al pensiero di non potere col suo biroccio raggiungere e lasciarsi addietro un civile di Ponza, che pei fatti suoi lo precedeva. Corri, corri, lo raggiunge, e quando gli è allato, furibondo che non si sia sottomesso a lui rallentando il passo, lo prende a frustate.
Egli non avea più di 17 anni!
Siffatto spirito di superiorità rendeva poco cavallereschi fin con le donne coloro che più tenevano ad esser cavalieri. Niccolò Inveges sciacchitano, di pieno giorno, in via popolata, bastonava due ragazze di Pietro Imperiale Pastore. Come il Natoli, egli veniva relegato nella Colombaia di Trapani, ma è a deplorare che lo fosse per breve tempo: ben altra pena meritando sì volgare soperchiatore!
Un signore, insignito del titolo di Abate della SS. Trinità della Delia, incontravasi in Via Alloro con la carrozza del Dottore in legge Bernardo Denti, occupata dalla moglie e dalla figlia di costui. Elementare dovere consigliava la precedenza alle due donne: ma il signor Abate non se la intese, e picchia e ripicchia, faceva rotolare per terra il cocchiere, che, o sgomento o sbalordito, non osava reagire.
Quanto meglio allorchè incontri così malaugurati si risolvevano in un duello206! Almeno, la cavalleria, manomessa al primo istante, veniva da ultimo rispettata.
Di duelli peraltro se ne faceva così di frequente che era bazza se in un mese non se n'avesse a sentire uno o due, spesso per frivolezze che è miseria parlarne. Se ne ricorda sinanco per un servitore che si mandasse via, o per uno che se ne prendesse. Il Marchese di Roccaforte ne intimava al Conte di Aceto per un volante, che egli diceva essergli stato tolto207. Quasichè esistesse una legge che vietasse di assumere ai proprî servigi un uomo stato una volta ai servigi altrui, ecco un grave fatto di sangue!
Un giovane Cavaliere, che chiameremo D. Michele, licenziava un suo schiavo. Rimasto libero, costui trovava collocamento in casa Oneto, Duca di Sperlinga. C'era egli nulla di male? Secondo D. Michele sì; ond'egli avutane notizia, si partiva ad imporre allo Sperlinga una partita d'onore. E poichè entrambi mancavano di armi eguali, e si trovavano a pochi passi dalla casa della vedova Montevago Pellagra Grifeo, che ne possedeva delle buone, prendevano in prestito due sciabole. Lo Sperlinga desiderava chiarire come fosse andata la cosa, dar soddisfazione all'amico impermalito; ma D. Michele, dandogli del vile, improvvisamente colpivalo nel viso con una terribile frustinata. Accecato all'inatteso colpo, lo Sperlinga traeva lo sciabolotto e piantavalo in ventre al provocatore, che ne moriva quasi all'istante, avendo appena potuto balbettare il suo torto e ricevere l'assoluzione da un padre Crocifero che a caso era lì di passaggio. L'uccisore riparava in una chiesa; ma indi a non guari, forte delle sue ragioni, costituivasi al Castello. Avrebbe potuto, dopo i primi giorni, esser liberato; e lo fu, ma tardi, perchè i parenti dell'ucciso erano, per grandi aderenze, potenti. Alcuni mesi stette egli chiuso, e la offesa famiglia potè vantare una riparazione. E fu argomento di lunghe discussioni tra gli accademici da salotto se lo Sperlinga, Duca, avesse fatto bene ad accettare una sfida da un semplice cavaliere, che è quanto dire da un cadetto; ed i sapienti furon di avviso che egli non avrebbe dovuto accettare «mentre non era obbligato a rispondere trovandosi insignito della chiave d'oro come gentiluomo di Camera ed investito del grado militare di colonnello di fanteria del corpo dei miliziotti»208.
Per questo, il codice cavalleresco non avea riposo. I politici (eran chiamati così anche coloro che discorrevano con competenza di cavalleria) lo sfogliavano pei frequenti casi di dubbia soluzione. Chi non lo lesse e discusse per le offese che nella passeggiata della Marina si scambiarono il Duca Lucchesi, primogenito del Principe di Campofranco, ed il Duca di Villafiorita Gioacchino Burgio? L'uno, risentitosi di non so quali parole, avea dato all'altro una violenta percossa; il Villafiorita avea tratta la spada ed aggiustata al percussore una piattonata; di che il Campofranco buttavalo a mare, incurante degli scogli che avrebbero potuto sfracellargli il cranio.
Alla passeggiata era D. Vincenzo Capozzo, Giudice della G. C. Criminale, che subito, de mandato principis, condannava alla Cittadella di Messina per dieci anni il provocatore. La Corte di Napoli avrebbe voluto rappattumare le parti ugualmente cospicue del baronaggio, parenti tra loro: ma non voleva farsi scorgere. Si sceglievano due alti personaggi per venire a proposte plausibili, tanto, il focoso Vicerè Caracciolo non era alieno dallo accogliere un componimento amichevole. I due ex-Pretori Principe di Resuttano pel Campofranco, e Marchese di Regalmici pel Villafiorita (come si vede, duo grandi e rispettabili signori del tempo), sudano nello studio della intrigata quistione; «svolgono libri di cavalleria anche oltramontani e protestanti, e cercano di accordarsi»; ma non vi riescono, perchè ciascuno tira acqua al suo mulino; ed il Regalmici ha per sè il Governo ed esige pel suo primo (diciamolo così per farci intendere) che venga riparata con una pubblica soddisfazione la pubblica offesa al Villafiorita. Oh che si scherza!... Il Villafiorita è stato bastonato, buttato a mare a rischio di perderci la vita, e si discute se debba o no avere una soddisfazione?!...
Ogni tentativo di conciliazione è pertanto abbandonato; e allora il Re, contro la buona volontà del Vicerè, ne fa una che non pare sua: ordina il passaggio del Campofranco dalla Cittadella di Messina alla Colombaia di Trapani. È una doccia fredda sulle riscaldate teste dei partigiani del Campofranco; il quale, visto e considerato che stavolta col Governo non ci si vince, nè ci s'impatta, si rassegna a dar piena soddisfazione al Villafiorita. E così il processo si mette a dormire209.
L'altezzosità della prepotenza toglieva la lucida visione dei proprî doveri di fronte alla Legge ed ai rappresentanti di essa.
Anche qui gli esempî abbondano; ma anche qui dobbiamo limitarne la rassegna.
Un Marchese, incontratosi una notte (certa gente andava di notte come i lupi) in un passaggio di strada, urta, o è accidentalmente urtato da un ministro di giustizia. Le son cose di ogni giorno, codeste; ma il Marchese non può permettere che càpitino a lui: e alla testa dei suoi creati assalisce l'imprudente e lo picchia di santa ragione.
Debitore moroso ed impossibilitato a sottrarsi ad un pegnoramento sentenziato dal Tribunale del Concistoro, altro Marchese non fa diversamente: accoglie, cioè, a legnate gli ufficiali che vengono ad eseguire in sua casa la sentenza: atto tutt'altro che imitabile, ma pure imitato da quell'Alessandro La Torre e Fernandez de Valdes, che al cameriere del Giudice pretoriano, intimantegli la imbasciata giudiziaria per debiti insoddisfatti, faceva il regalo d'un fiacco di bastonate210.
Noi lo rivedremo questo giovane manesco, e sapremo quanto longanime sia stata con lui la Giustizia.
Antonino Calvello, del resto, non gli rimaneva addietro quando prendeva pel colletto e minacciava gravemente il Giudice della G. C. Civile Pietro Feruggia. Nè gli rimaneva addietro il Barone Diego Sansone allorchè andava ad assalire la casa del Duca di Vatticani chiamandolo a duello per litigi corsi tra il proprio figliuolo Alfio ed il Duchino medesimo, e gratificava di contumelie il Capitano della Gr. C. Torretta, andato da lui per tradurlo in carcere211.
Anche qui ricompariscono le velleità di duello, le quali anche qui fan pensare all'indole rissosa, ed insieme cavalleresca del siciliano. Un antico costume, ora del tutto dimenticato, ci offre in ciò una pratica singolare. Nel giorno di S. Valentino (14 febbraio) alcuni vecchi, nobili o ignobili, si salassavano, perchè questo buon santo rendesse valenti nelle zuffe e nei contrasti i suoi devoti212. Sta a vedere che il vincitore in un duello o in una zuffa debba esser colui che si sia cavato più sangue!
Altro ribelle alle autorità giudiziarie fu un Gioeni, che per un nonnulla penetrava a viva forza in casa Gaetano Greco, Giudice del Concistoro, nel momento che egli se ne stava a desinare, e con male parole apostrofavalo. Imprudente uomo costui, che, dimentico di esser figlio di quella gentile e culta dama, che fu Anna Bonanno, si ricordava d'esser marito di Giuseppa Cavaniglia dei marchesi di S. Maria, la quale, come ricettatrice di ladri nella sua villa dei Colli, veniva severamente chiusa nelle prigioni di Gesù (2 ott. 1800); e teneva bene alla memoria di esser padre di una donna tristamente celebre in Napoli, condotta qui ad accrescere il numero delle signore o raccolte o raccoglientisi nel ritiro di Suor Vincenza213.
A proposito di violenze non va dimenticata quella d'un tale, che con inaudito arbitrio imprigionava non solo un pubblico corriere, ma anche il Capitano di Giustizia della terra di Gaggi; nè va trascurata l'altra di due fratelli del Fiumesalato, i quali per non so quali fisime, con le spade in mano inveivano contro un cappellano delle galere di Malta214.
«Ragazzate!» si dirà; ed è vero; ma ragazzate che eran pure capestrerie, le quali offuscavano il decoro del casato onde tanti ragazzi provenivano suscitando lo sdegno dei saggi, l'ira repressa degli umili, la reazione brutale delle vittime. Capestreria quella del figlio del Barone Jannello, che si divertiva a scagliar sassi sopra le persone che passavano in via Lampionelli, ferendone non lievemente qualcuna: ferito, poi alla sua volta, egli stesso, ai Ficarazzi da un Vincenzo Giardina, secondogenito del signore di quel luogo. Capestreria la spacconata del già detto La Torre, il quale a tarda sera, nella entrata del Principe di S.a Flavia, all'ora del solito settimanale ricevimento di dame e cavalieri, faceva richiamare a basso il figlio del Barone Antonio Morfino; ed avendolo tra le mani, ordinava ai suoi creati di prenderlo per iscorno a cavallo e di contargli parecchie dozzine di sferzate. La quale violenza d'un giovane sopra un fanciullo (il Morfino non oltrepassava i 16 anni!) in tutti suscitava disgusto infinito; ma più che in altri nel Villabianca, il quale non sapendo rassegnarsi alla notizia d'un nuovo ospite della prigione di Porta S. Giorgio, pensava che «il Castello non leva bastonate, anzi serve per li polledri giovinastri per luogo piuttosto di divertimento che di pena»215.
Di fatti, il Castello era la parodia del carcere. La libertà personale vi si godeva in mezzo al rispetto dei carcerieri e degli ufficiali di guardia. Con pochi tarì di spesa vi si avea un bel desinare quando questo non venisse fornito succulento e gustoso dai parenti, e bastevole ad allegri conviti tra le varie persone che vi stavan raccolte. Vi si giocava e conversava spensieratamente come continuando in luogo di villeggiatura le dissipazioni di fuori. Nelle Pensées et Souvenirs il Palmieri de Miccichè ritrasse con rosei colori questa prigione distinta, donde si poteva financo uscire a diporto di sera impegnando la propria parola d'onore che si sarebbe ritornati: e la parola veniva scrupolosamente mantenuta come quella dei perditori al giuoco216, o come quella dei militari prigionieri di guerra.
I dissidî tra mariti e mogli eran pabulo alla cronaca d'alcova. Il pubblico grosso e minuto ci si divertiva parecchio, perchè all'umana natura torna sovente gradito quello che agli altri è disgradevole. In vero molto piccanti riuscirebbero queste pagine se tutte si potessero narrare le circostanze che accompagnavano le visite improvvise, intimi conversari, fatali sorprese, brusche divisioni, ritiri volontarî e relegazioni forzate. Tiriamo un velo su queste scenacce, moltiplicate dai costumi e dal bon ton della dilagante corruzione d'allora. Forse i tempi nostri sono più brutti di quelli, più fecondi di drammi lardellati di scandali; anzi vogliamo senz'altro ritenerli bruttissimi; ma non per ciò dobbiamo predicare che la morale d'una parte dei nostri bisnonni d'un secolo fa fosse integerrima ed irreprensibile.
Tuttavia non dobbiamo passarci da qualche fattarello di questo genere di vita siciliana: e lo faremo di volo.
Uno è quello della superba ed ostinata condotta di una dama di casa Reggio, dama che da ultimo persuase il Governo a chiuderla nel monastero di S.a Elisabetta (1777); un altro, quasi contemporaneo, quello di Nicoletta d'Avalos, fatta entrare a forza in S.a Caterina.
Drammatica la cattura di Margherita Lo Faso e Pietrasanta, Duchessa di Serradifalco. Il Duca suo consorte, scontento di lei, chiese per essa la clausura, non già in uno degli ordinarî monasteri, ma nella Casa (vera e propria prigione) delle Malmaritate alla Vetriera. La cattura doveva eseguirsi da un giudice di patente reale e con accompagnamento di dame, come soleva praticarsi in simili circostanze: ma fu eseguita invece da un semplice ufficiale dell'ordine dei berrobieri. Più severi non poteva essersi. «A due ore e mezza di sera la Duchessa nella sua casa fuori Porta Nuova venne arrestata da un capitano reale e condotta nella carcere Carolina delle nobili del Cuore di Gesù». Ci vuol poco ad indovinare chi fosse il Vicerè: non il pacifico Fogliani, non il festaiolo Marcantonio Colonna di Stigliano, non il mellifluo Caramanico, ma il Caracciolo, che, Marchese, era un mangia-nobili. Il rigore della procedura, veramente indebito in affari di famiglia, fu da lui seguito per la disubbidienza della Duchessa all'autorità vicereale.
La Margherita era figlia del defunto Egidio, Principe S. Pietro e, nientemeno, Presidente e Capitan Generale del Regno di Sicilia in assenza del Fogliani!
E la cronaca prosegue.
Nei primi di luglio 1779 le famiglie più elette della città ricevevano un foglietto a stampa, sormontato da magnifici stemmi principeschi e ducali, con questa partecipazione:
«Il Principe Trabia e il Duca di Sperlinga si danno l'onore di parteciparle che nel giorno mercoledì sera 7 Luglio si sposeranno la signora D. Aloisia Lanza e D. Saverio Oneto, loro rispettivi figli, ed ossequiosamente si rassegnano, riserbandosi i loro favori a nuovo avvìso»217.
Nozze meglio auspicate poche volte si videro; ma haimè! la Aloisia, fanciullina ancora, dovette subito dividersi dal marito, che contava appena diciassette anni! La sera del 27 marzo 1799, lo spensierato Saverio si recava al palazzo Butera, dal suo cognato Principe di Trabia. Quivi incontrava la moglie. Vederla e scaricarle a bruciapelo una pistolettata fu tutt'uno. La Aloisia scampò per mero caso; e mentre egli veniva condotto all'inevitabile castello, essa volontariamente andava a chiudersi — fatalità di vicinato e d'incontro! — a Suor Vincenza218, dove, martire del più snaturato tra i mariti, mestamente trascorreva la sua gioventù, Palmira Sirignano Duchessa della Verdura. In proposito, rifletteva un testimonio: «Tanto avviene alle povere dame che hanno mariti bruti. Al tempo stesso però è bene dire che ne' presenti corrotti tempi le femine si prendono gran libertà: ed è cosa invero detestabile, cagione e origine de' gran disordini».
L'allusione alla libertà che si prendevan le dame è molto vaga: e ad onore della Aloisia e della Palmira non va diretta nè all'una, nè all'altra. Le nostre indagini nulla ci han dato di men che lodevole sulle egregie dame.
Francesco Landolina, Duca della Verdura, aveva un figlio perdutamente innamorato d'una bella ragazza. Alle nozze da lui vivamente e replicatamente sollecitate l'accorto padre non volle mai consentire, così bene ne conosceva l'indole; chè anzi una volta dovette chiedere la carcerazione di esso. L'esperto uomo prevedeva i guai che Michele avrebbe fatti passare all'amata ragazza. Se non che, egli cessava di vivere, e l'innamorato Michele, reso indipendente, il 14 gennaio del 1787 sposava la Palmira Sirignano e Gajanos, più giovane di lui, che contava 25 anni. Dopo tanto contrasto di passione, che cosa c'era da sperare se non gioie oneste, godimenti sublimi? Niente affatto! Fin dalla prima sera Michele rivelò l'indole sua perversa. La tradizione racconta che egli chiuse e tenne tutta la prima notte, fra le vetrate e gli scuri di una imposta della stanza nuziale, la sposa come indegna di lui.
«Sprezzò, si aggiunge, la sposa e la bastonò con modi barbari e crudeli. La povera Palmira dovette andarsi a chiudere a Suor Vincenza. Egli fu relegato al Castello di S.a Caterina a Favignana; poi, per grazia, al Castello di Trapani», ove trovavasi ancora nel maggio di quell'anno, che avrebbe dovuto essere il più dolce e fu il più amaro per la bella giovinetta. Nel dicembre moriva a lei il padre: e la Duchessa vedova, suocera della Palmira, si adoperava col parentado per una conciliazione tra gli sposi, dai quali si sarebbero voluti dei figli. Nel gennaio del 1788 si rinnovava la mancata luna di miele: e «Dio la mandi buona alla detta povera dama! secondo vuole la opinione generale», esclamava il Villabianca; ma fu luna di fiele, fortunatamente breve. Dietro a Palmira tornava a chiudersi la porta di Suor Vincenza; dietro a Michele alzavasi il ponte levatoio del Castello. Che irrisione di vicinato! Se non che, dopo uscito di carcere il violento Michele, un giorno, non sapendo resistere allo scampanio festivo della chiesa del monastero del Cancelliere, che, come si sa, è presso il Palazzo Verdura in via Montevergini, salito più che di corsa alla terrazza, sparava lo schioppo sulla suora campanaia, che per miracolo rimaneva illesa.
Non così egli più tardi, allorchè, trovandosi in Termini in propria casa, veniva nottetempo aggredito e ferito a morte da ignota mano. Si sospettò allora di persona la quale volesse riparare all'onore offeso della moglie o della sorella, e fu invece del bandito Giuseppe Ruffino; la cui testa la mattina del 17 settembre vedevasi trionfalmente condotta per la città.
La vera luna di miele apparve finalmente per la Sirignano, quando, rimasta libera, sposò altro uomo che la rese felice; e, vissuta lungamente, nella sua tarda vecchiezza, non cessava scherzevolmente di ripetere: «Son tanto sdegnata della verdura, che dal 1787 non mangiò più insalata»219.
Degno riscontro del Landolina, col quale avrebbe potuto comporre una coppia bene assortita, fu la già nota Cavaniglia, bizzarro soggetto di conversazione pei salotti d'allora.
Tipo di dama aristocratica, essa avea portata a Palermo la grandigia del casato onde veniva, e vi aggiungeva quella del nuovo nel quale era entrata. Ma con l'orgoglio del doppio titolo ebbe sfrenata la passione per tutto ciò che non fosse bello. Il mal corrisposto marito si divise clamorosamente da lei: e chi ne seppe le ragioni non potè non dare ragione a lui, che pure non era un santo. La infedeltà di moglie degradò presto in infedeltà di amante: e questa infedeltà, ripetuta per malsana tendenza, dovea da ultimo costarle cara. Il 23 agosto 1798, nella via Alloro, sconosciuti sicari fermano la carrozza nella quale è la Giuseppina, ed uno di essi imprime sul volto di lei una scomposta ferita. Non rasoio, non coltello l'arme, ma un ferro da pistola, stavolta preferito per produrre uno sfregio. Uno sfregio a donna significa vendetta di feritore: e F. P. Colonna Romano, secondogenito del Duca Mario, si era voluto per siffatto modo vendicare di essere stato dalla volubile donna defraudato nei diritti acquistati di amante riamato. Fu detta gelosia la sua, ma fu anche odio mortale220.
E lasciamo altri fattacci che vanno dal trascorso giovanile al delitto più maturatamente pensato: dalle bastonature del cav. Giuseppe Ventimiglia de' Conti di Pradres al suo volante, che però, non potendone più, finiva col freddare il padrone (aprile 1798), e dalle stoccate di Saverio Oneto allo zio paterno in pubblico Cassaro sino agli assassini fin de siècle perpetrati da un certo signore di Catania. Lasciamoli dove sono questi fattacci, che nelle spesse maglie della rete della umana debolezza raccolgono pure fughe di perseguitati dalla Corte Capitaniale di Palermo, appropriazioni indebite di gioie ricevute in deposito, scassinazioni notturne di porte di gentildonne, e via discorrendo221.
Gli animi fremevano ad ogni passo, ed invocavano giustizia severa di tanti che abusavano della lor posizione disonorando i buoni che degnamente portavano titoli aviti.
«Oh gran virtù dei cavalieri antichi!» viene da esclamare alla stupefacente notizia che un giovinetto di Casa Ventimiglia (Giovanni Luigi), solo perchè dei Marchesi Geraci, rifiutava la nomina viceregia di Senatore. — Rifiutava quel che altri ambiva? — Sì, perchè egli non tenevasi della comunanza dei signori siciliani. I predecessori di lui avevan trattato da pari a pari coi re di Sicilia, usato la formola reale Dei gratia, vantato di poter coniare moneta e d'esser dispensati dagli uffici, relativamente a loro, modesti, di Senatori222.
E veniva anche da fremere considerandosi che mentre nell'aula del tribunale della G. C. Civile il magistrato sedeva a capo scoperto, egli, questo degenerato che alteramente entrava, osasse rimanere a capo coperto (2 febbr. 1792); e, passando dalla Vicaria, esigesse il saluto militare come quello che il picchetto di guardia rendeva al proprio superiore, Principe di Paceco Niccolò Sanseverino (26 luglio 1792)223.
Che importa che i rei (le geste dei quali abbiam dovuto per brevità lasciare nel dimenticatoio) venissero relegati quale alla Colombaja di Trapani, quale in Termini, quale in Favignana e in Messina! Questo c'è di fatto: che a capo di pochi mesi, di pochi giorni magari, essi tornavano allegramente come da un premio conseguito. E quando i loro compagni in trascorsi, discolerie, crimini uscivano dal Castello di Palermo, e tra i sorrisi e le strette di mano di certi amici riandavano i particolari delle loro spavalderie ed i passatempi goduti nella così detta prigione, il senno antico degli attempati signori ne soffriva oh quanto! Nella severità del volto, nell'abbassare degli occhi pareva declinassero costoro qualunque solidarietà di ceto con siffatta genìa, se il ceto poteva determinare ad abusi di tanta sfrenata prepotenza; ed allora con D. Giovanni Meli si udivano a mormorare:
Oh seculi, oh custumi!...Seculi cchiù birbuniDi chisti nun cci nn'è!
Ma dimenticavano che l'umana tristezza è immensa quanto il mare, e che se in tante e così brutte maniere si manifestava in Sicilia, con più raffinata violenza percorreva fuori di essa la scala della criminalità.
CAP. XIII.
INDELICATEZZE, FALLIMENTI, MALVERSAZIONI.
Oggi è un gran dire su pei giornali, un gran mormorare tra i crocchi e le conversazioni, di indelicatezze e di appropriazioni indebite, come con la ipocrisia del nuovo linguaggio si chiamano gl'illeciti guadagni e le grosse ladrerie di certi uomini pubblici; ma un soldo di pane che un povero affamato porti via illecitamente è chiamato sempre furto. In passato però non era diversamente, perchè la pianta-uomo è sempre una, e là dov'essa cresce e si muove, le virtù vanno coi vizi, e gli esempi di onestà intemerata hanno il contrappeso di ributtanti brutture. Dignità ed onori non impedivano che persone anche in conto di integerrime prevaricassero a danno delle amministrazioni alle quali eran preposte e delle quali avrebbero dovuto esser custodi scrupolosi e zelanti.
Il Meli, che non va mai trascurato quando si parli dei vecchi costumi, rispecchiando il pensiero dei suoi concittadini sull'apparente prosperità dei suoi tempi, lanciava in una ottava una terribile frecciata sul magistrato del Comune e sul capo supremo dello Stato in Sicilia. La freccia però rimaneva nascosta in casa del poeta, e solo da poco è stata messa in evidenza nell'epigramma A Palermu, che è anteriore al 1800224.
L'ardita accusa non determinava fatti speciali; ma la cronaca spicciolata d'allora deve averne raccontato qualcuno: il che può aver prestato argomento ai soliti pour-parlers a base di maldicenza. Si parla infatti della moglie d'un pezzo grosso del Senato, la quale avrebbe tratto profitto dalla posizione del marito, oscurando, con doni che riceveva in compenso di favori, la fama del casato225. Si parla d'altri pezzi egualmente grossi del medesimo Senato che avrebbero preso «denari e sborsi di buoni capitali dai loro subalterni eliggendoli uffiziali, che era poi in sostanza lo stesso di vendersi il jus furandi perchè si soddisfacessero dell'impieghi che vi avevano fatti perchè vi campassero sopra».
Ma son voci vaghe, che non hanno maggior valore dei soliti si dice della giornata. Si parla altresì di un Senatore, che col nome di persone di sua fiducia avrebbe assunta la impresa della beneficiata di S.a Cristina traendone larghi lucri. La qual cosa il Villabianca rivela, fieramente tonando contro le turpitudini del presente in così aperto contrasto con l'onestà del passato. Di quel passato egli stesso, a proposito della terza elezione di Ercole Branciforti, Principe di Scordia, a Pretore di Palermo, avea potuto scrivere che la nettezza delle sue mani «lo metteva sommamente in pregio, e lo rendeva venerando»226.
Erano nel palazzo pretorio sette Contestabili: uno del Pretore, sei de' Senatori. In palazzo e fuori si diceva di loro plagas; e ciò persuadeva il Senato a destituirli, benchè nominati a vita. Ricorrevano costoro all'autorità competente; ma ne uscivano col danno e le beffe, perchè la loro reità restava luminosamente confermata da fatti e testimonianze; e l'autorità in persona, che era il Vicerè Caramanico, ordinava e comandava: «Che il Senato cacci via i sei Contestabili che assistono i Senatori ed il Contabile maggiore che assiste il Pretore per affari di annona; ne eliga, in vece loro, altri tanti in pieno congresso per un bienno, da scegliersi dal ceto delle maestranze le più circospette e cittadini onorati, amovibili ad nutum etiam sine causa» ecc.227.
A titolo di onore ecco i nomi dei coraggiosi che ruppero contro questa malnata associazione di malfattori: 1. Bald. Platamone, Duca di Belmurgo, Pretore; 2. Ignazio Branciforti; 3. Fr. Parisi, Principe di Torrebruna; 4. Carlo Cottone, Principe di Villarmosa; 5. Gius. Amato, Principe di Galati; 6. Ignazio Migliaccio, Principe di Malvagna; 7. Pietro Ascenzo, Principe di Alcanà.
E giacchè la risoluzione assodava responsabili di gravi negligenze i «maestri d'immondezza», che mangiavano il pane a tradimento, con un tratto di penna venivano destituiti anch'essi, e soppresso il loro ufficio; il quale dalla Deputazione dei Nobili per la pulitezza delle strade veniva affidato ad uffiziali addetti a consimili incumbenze228.
Lasciamo il processo che, proprio al chiudersi del secolo, si andava compilando contro i Deputati di piazza229, frodatori del pubblico e del Comune quanto coloro che nel 1796 avean prestato braccio a quel ladro di Giovanni Cane, di cui è parola nel cap. dell'Asilo sacro. Questo processo finirà come molti altri: col «non luogo a procedere» d'oggi.
Quello però che accadeva al Pretore Regalmici è mostruoso.
Richiesto dal Governo di Napoli, il Talamanca La Grua nel 1779 spediva nel corso di venti giorni duemila salme di farina. Chi poteva sospettarla adulterata? Eppure lo era: e la spiacevole notizia egli la apprese per una gran lavata di capo venutagli dalla Corte di Napoli, egli primo magistrato della città, pieno di energia e di zelo per tutto ciò che fosse pubblico bene. Ah no, il Regalmici non meritava quel rimprovero! E quando la Corte di Napoli e quella di Palermo se ne accorsero, bandirono il taglione contro il colpevole, Giuseppe di Maggio di Cristoforo, il quale pensò a salvarsi in tempo230.
Non del tutto dissimili procedevano sovente le sorti di alcuni istituti filiali del Senato. La grotta di S.a Rosalia sul Pellegrino e la Cappella di S.a Rosalia nel Duomo, la Cappella della Immacolata a S. Francesco e la chiesa di S. Rocco, la Deputazione per le quarant'ore e quella per la Casa di S.a Caterina da Siena, con l'altra della Casa e Rifugio delle malmaritate, la Suprema generale Deputazione di salute e la Deputazione del Molo, delle torri, delle strade, quelle della Biblioteca, della Villa Giulia, della Fontana Pretoria, delle Nuove Gabelle, dei Corsi d'acqua, del Monte di Pietà, della Tavola, dell'Ospedale grande e nuovo, dell'Ospedale S. Bartolomeo, del Pantano di Mondello; e poi le altre per la terra della Bagheria, pel feudo della Baronia di Solanto, per la Terra di Partinico, e per la Sicciara (Balestrate), tutte avevano amministratori proprî, dipendenti però dai centrali del Comune (1784-85).
I più eran modello di rigidi amministratori; alcuni però per vecchi abusi d'ufficiali, per fiacchezza od inesperienza erano da meno, pur non potendosi incolpare di opere disoneste; ma ve ne erano degni del carcere e della corda.
La indelicatezza dalle basse sfere montava alle alte.
Il rigore che vuole apportarsi oggi nelle amministrazioni pubbliche leva al cielo i passati tempi vantati avversi a gratificazioni e compensi di qualunque maniera. È un richiamo che tradisce la ignoranza storica. Le gratificazioni, i compensi, anche per servigi privati, v'erano anche allora: ma portavano altro nome, e alcuni, quello di «toghe d'allegrezza». Nel capitolo sopra il Senato ed i Senatori ne abbiamo detto qualche cosa, anzi più che qualche cosa: il che ci dispensa da nuove spiacevoli indicazioni.
La Tavola (Banco) poi ne offriva il peggiore esempio col pretesto di nuove nomine di alti rappresentanti dello Stato: e l'esempio partiva ab alto, dai Governatori. Nel 1780 si adunavano essi pel conseguimento di siffatta toga all'arrivo del Presidente del Regno D. Antonio de Cortada y Bru: e credevano di non venir meno ai doveri di convenienza, di dignità, di rispetto alla qualità loro, attribuendosi quei favori. Il Cancelliere della Città, che ne veniva a conoscenza, «faceva sentire la sua voce acciò si dessero pure a lui, segretario del Banco, le toghe d'allegrezza e di lutto [anche pel lutto se ne aveano!] ogni qual volta si ripartivano ai Governatori ed agli alti ufficiali». Di più ancora: nel 1784 si deliberava di chiedere il permesso che si spedisse il pagamento non di una ma di due toghe, cioè di allegrezza e di lutto a favore del Principe di Mezzojuso, Sindaco: e nel 1785, per un nuovo parto della Regina, altre toghe si distribuissero fra loro i Governatori231.
Le severe proibizioni ai Governatori del Monte ad ammettere nella Conservatoria di S.a Lucia ragazze che avessero oltrepassata l'età voluta dai regolamenti e che non fossero orfane rompevano contro il capriccio o il favoritismo dei Governatori medesimi. Quante volte non si passava sopra questa ultima e radicale condizione di ammissione, con pregiudizio di orfanelle povere ed abbandonate! Nel solo anno 1780 e in una sola consulta si fecero entrare fino a sette fanciulle, i genitori delle quali eran vivi e sani. Vivo e sano il padre della ragazza Gerfo, ammessa nel 1781; vivo e sano il padre di Rosa Sabatino nel 1782; vivo e sano quello di Marianna Ciminello nel 1783232 e, scandalo forse unico nel genere, che disonora tutta una amministrazione, fu lo iniquo voto che ammetteva al sorteggio di un secondo legato di maritaggio Maria Anna Noto (1787), la cui sorella poco prima di lei altro ne avea conseguito233.
Di parzialità in parzialità il Senato confermava in carica Governatori scaduti, per virtù di capitoli, non rieleggibili; ed i Governatori eleggevano avvocati soprannumerarî del Monte Salv. Coglitore e Girolamo Maurici, Francesco Ardizzone e Giuseppe Eschero: un collegio di forensi, al quale tutto poteva abbondare fuori che cause e litigi, e nominavano altresì avvocato straordinario con dispensa di un atto necessario e quindi indebitamente Domenico Candia.
Era tuttavia sonora l'eco delle tremilaseicento onze dai Governatori del Monte di Pietà spese per la copertura dell'edificio (1776); si parlava delle regalie che questi avean prodigate ai sopraintendenti delle imprese, e delle gratificazioni più che vergognose che si erano essi attribuite234; e già nel 1785 veniva in luce un nuovo gravissimo fatto, che gettava la desolazione nei poveri, lo sgomento nel paese: il fallimento dell'istituto. Gregorio Spadafora, «Amministratore e Razionale del ripartimento del Prèstamo», presentava un ammanco di 60,000 scudi circa. Alcuni ufficiali gli avean tenuto il sacco, e si eran salvati con la fuga. Della reità dello Spadafora nessuno dubitava: un lungo capitolo in versi accusava, amaramente scherzando, il reo, che a giustificare le agiatezze alle quali si era abbandonato dava a credere il rinvenimento d'un tesoro235.
Disastro così grave ne metteva in luce un altro meno generale, ma non meno grave. Ignazio Mustica, cassiere del civico Banco, falliva d'una ingentissima somma: chi facevala ammontare a cinquanta, chi a settantamila scudi. Come avea potuto egli trascinare a così inattesa iattura il paese? Con la connivenza e la cooperazione di alcuni ribaldi: il libreri (ragioniere) Giuseppe La Rosa e lo scritturale Salvatore del Carretto; coi quali, appena scoperto, prendeva il largo, più destro e fortunato degli autori delle frodi e falsità commesse contro la fede pubblica pel Caricatore di Sciacca (1772)236. Caracciolo, irritatissimo, bandiva una taglia di cento onze (L. 1275) a chi li trovasse. La gente, indignata dei Governatori, ne reclamava la punizione: e la Corte pretoria mandava per mezzo dei suoi soldati di marina a catturar costoro, i quali non si sa quanto ci entrassero. Erano essi il mercante Innocenzo Lugaro e gli ex-Senatori nobili Corrado Romagnolo (quello da cui prende ora nome la deliziosa contrada oltre la Villa Giulia) e Vincenzo Parisi: che però, infermo, rimaneva carcerato in casa sotto mallevaria del Duca di Cefalà: tutti e tre issofatto deposti dal Senato e sostituiti con altri più coscienti dei doveri elementari di giustizia e di onestà.
Un erudito, testimonio del fermento dei Palermitani a tanta frode, se ne addolorava non solo pel danno economico che alla Città ne derivava, e pel discredito della nazione presso il mondo, ma anche perchè c'era di mezzo un Vicerè napoletano, il Caracciolo, il quale detestava i Siciliani.
Egli, peraltro, ordinava una inchiesta sulle opere filiali del Senato e sulle regie237. Evidentemente, le inchieste dopo un disastro, non sono provvedimenti o lustre recentissime!
Delitti, se non identici, simili a questi due, ripetevansi quasi contemporaneamente (incredibile!) negli anni 1798 e 1799 tanto nel Monte di Pietà quanto nel Banco. Furti ed imbrogli nell'uno, furti ed imbrogli nell'altro: e noi lasceremo al Sindaco ed ai Governatori, venuti a capo delle frodi commesse dai loro ufficiali, la briga d'istruirne il processo, ed al Governo, l'ordine di una nuova inchiesta. Così l'avessero fatta per le duemila onze state spese per la costruzione del portico del Monte di Pietà nel 1790!238.
Non irragionevoli sospetti sulle amministrazioni dei due spedali Grande e di S. Bartolomeo lasciavasi sfuggire il Villabianca. Gli spedalieri, egli diceva, son perpetui, ed «è facile assai e assai [più] di una volta prevaricare. Non vi è più dannoso nelle opere pubbliche, e sopra tutto opere pie, che la perpetuità di officio nei loro rettori»: e lo diceva lamentando le cattive condizioni di entrambi gl'istituti di carità.
Altra maniera di frodi era quella della usurpazione di suolo pubblico per parte di alti personaggi del Governo d'allora, e perchè alti, lasciati in pace a godersi l'altrui. Data dal 1767, e quindi lontano dal tempo del quale ci occupiamo, il complemento della casa Asmundo Paternò di fronte alla Cattedrale. L'Asmundo, padre di quel G. Battista palermitano, che fu Presidente del Concistoro e del Supremo Magistrato del Commercio, e più tardi (1803-6) Presidente del Regno, ne decorò sontuosamente il prospetto, e vi fece alzare pilastri di grandi dimensioni che uscirono fuori i limiti del palazzo, sporgendo sul corso. Ma il Paternò era Presidente del real Patrimonio, e nessuno ardì richiamarlo al dovere. Ben lo richiamò invece, ma senza frutto, perchè l'abuso passò senza una parola del Senato, le seguente canzonetta:
Mentri si fabbricava la casa di lu sù Presidenti Paternò.
Avanti c'era un muttu cu sta frasa:Lu Prisidenti è un cunigghiu di ddisa;Ma ora chi crisciu cu la sò casa,Si chiama la tartuca catanisa.Lu Cassaru strinciu cu la sò spasa:Omu putenti pigghiau chista 'mprisa,Pirchì la giustizia è vastasaE a cui c'incumbi si la pigghia a risa.Pri civiltà la manu si ci vasa:Ma 'un si ci loda sta spasa e sta spisa.Un palmu e menzu si ritiri e trasa,E a cui nun voli ci vegna la scisa239!
Non ostante che lontano da noi, questo abuso concorre a lumeggiare l'ambiente, e giova a farci capire come potessero avvenire certe cose anche fuori la città murata.
Andando verso i Colli, presso la Favorita, è una villa, che fu già superba di marmi, busti, mobili e vasellame. Il denaro vi fu profuso con larghezza principesca. Innanzi ha una ampia piazza, chiusa da inferriata, che ingombra la strada, e solo da pochi anni fatta rientrare dall'Autorità municipale per rendere estetico il luogo. Dietro è un parco che potrebbe dirsi reale. Quel terreno fu affermato proprietà del Comune, ed un signore aver potuto farlo suo, perchè Presidente del Tribunale della Gran Corte e Luogotenente di Maestro Giustiziere. I contemporanei ebbero per lui parole più che severe, l'eco delle quali ripercotevasi in accuse ben determinate alla Corte di Napoli; donde il 6 febbraio 1786 come fulmine a ciel sereno giungeva un decreto di destituzione. Quella villa, già delizia ed orgoglio, fu baratro del possessore: e quando il potente di ieri non ebbe più modo di rialzarsi, lo si chiamò responsabile di sentenze inique contro il Principe di Belvedere, di basse compiacenze al Caracciolo a carico del patrimonio di S. Orsola, di rovina del commercio esterno: giudizî che vuolsi esser cauti ad accogliere, giacchè molto può avervi concorso la leggerezza dei facili novellieri, l'invidia dei non favoriti, le ire di parte lungamente represse.
CAP. XIV.
ASILO SACRO, O IMMUNITÀ ECCLESIASTICA.
Avanzo odioso di Medio evo, al quale i venturi stenteranno a credere se non ci fosse il conforto della storia, è quello dell'asilo sacro, sia altrimenti detto immunità ecclesiastica, reclamato dalla chiesa, conceduto dai governi.
In forza di esso un reo che voleva sfuggire ai rigori della giustizia, senza discorrer sopra la natura della reità commessa, poteva — e qui sta bene mutare il presente in passato — correre come a luogo intangibile verso una chiesa. Una volta bastava ch'egli mettesse piede in un circuito di 40 passi se la chiesa fosse maggiore, di 30 se minore240: poi, giudicata anche dagli stessi canoni troppo severamente tanta larghezza d'interpretazione, venne da una bolla pontificia ridotta. Pure bastava sempre che il reo raggiungesse un gradino del recinto, o toccasse con le mani una porta o le mura, o si appoggiasse con le spalle al fabbricato della chiesa, perchè potesse ritenersi uscito dalla competenza della giustizia ordinaria e passato a quella ecclesiastica. Sotto di essa allora godeva la immunità, salvo a doversi poi accertare fino a qual punto potesse egli accamparsi sotto le grandi ale dell'Ordinario della sua diocesi o, dove fosse sede vacante, dell'Ordinario della diocesi più vicina.
Fatto sociale, politico, giuridico di tanta gravità fu tema di lunghe e non sempre calme controversie sul vecchio privilegio, divenuto abuso di delinquenti, ostacolo al libero esercizio della giustizia, ribellione aperta alle leggi divine, ai diritti della ragione, che vogliono punito chi abbia fatto del male con la coscienza e la volontà di farlo.
L'esistenza di una Congregazione della Immunità in Roma fa supporre con che ardore si dovessero guardare le liti di questo genere, sulle quali non si arrestavano recriminazioni di vescovi, risoluzioni di cardinali, bolle di pontefici e, che è più, minacce di censure ai violatori dei luoghi immuni. Siffatte bolle non sempre si volevan ricevere dai principi, perchè essi vi vedevano menomata la loro autorità, lesi i diritti dello Stato a beneficio dell'individuo «di bassa estrazione», ed a pericolo della sicurezza pubblica.
In Sicilia entrarono nello spinoso campo del contrastato diritto Francesco Gastone, P. Gambacurta, M. Cutelli ed altri giureconsulti d'incontestabile valore241: e se non fosse intervenuta l'opera moderatrice di Benedetto XIV, forse omicidî, fallimenti fraudolenti, debiti al fisco o al pubblico ed altri delitti contro la retta ragione si sarebbero anche tra noi a lungo accresciuti con la larva della legalità di asilo. Le restrizioni del sapiente pontefice ridussero la immunità, ed in Palermo fu concessione di lui il divieto di rifugio privilegiato nelle due chiese di S. Sebastiano e di S. Paolo dentro il quartiere militare degli Spagnuoli (oggi S. Giacomo). Ma la immunità fu pur sempre un privilegio, che certi nemici di essa o accettarono senza discussione, o subirono a favore di chi senza sua volontà o per puro accidente trascorresse ad eccessi anche gravi contro le persone. L'accettarono o si rassegnarono a subirla «per una cosa ragionevole e legittima, com'è quella dell'offesa commessa nel calor dell'ira o della rissa, se l'offensore sia stato provocato acerbamente, e in guisa tale che il delitto possa dirsi quasi involontario ed estorto dall'umana fragilità più che dal consiglio ed animo deliberato di nuocere altrui»242.
Altri invece non si seppero rassegnare, e tra essi un ecclesiastico e nobile palermitano, il quale nel 1775 scriveva:
«Lascio di far parola del danno che fa alla Republica l'abuso del diritto d'asilo, che nei suoi limiti è venerabile e sagrosanto, ma nei suoi eccessi è la maggior onta che possa darsi a' malfattori, ladri, assassini, omicidi per devastare con sicurezza i beni e la vita dei cittadini, e per turbare la pubblica tranquillità».
E venendo a quelli che della veste talare si giovavano per la impunità dei loro reati aggiungeva:
«Chierici di ordini minori vogliono approfittarsi soverchiamente dell'immunità personale in oltraggio della Repubblica, e secondo loro torna a grado fan cadere e fan crescere i capelli della loro cherica, tolgono e rimettono al loro collo l'azzurro lenzuolino per aver largo di commettere impunemente i maggiori delitti»243.
Lasciamo a chi voglia di proposito occuparsi di questo strano fenomeno legalizzato, che offre curiosi documenti delle conseguenze alle quali può condurre l'applicazione d'un diritto e d'un privilegio di siffatta natura. Certo, la storia della legislazione penale avrà molto da dire sul proposito anche in Sicilia. Cronache e pubblici strumenti ci ricordano quel Carlo Cento, «locatario della gabella del pesce», che nel 1784 fallì per debito di una grossa somma, e «non potendo pagare, prese il rifugio della chiesa in compagnia di suo genero e fidejussore per esimersi di persona dalle coercizioni giudiziarie fattegli dal magistrato.»244. Ci ricordano quel Vincenzo Stroncone, carcerato a nome della chiesa nella Vicaria, pel quale con una disposizione pari a quella relativa al celebre Ab. Vella, si ordinava dal Vicerè la scarcerazione dalla Vicaria e la detenzione in casa in luogo di chiesa245 (povera chiesa, pigliata anche qui a prestito dalle autorità politiche per coonestare infrazioni di leggi, come più tardi, la mondanità degli spettacoli teatrali!246). Ci ricordano la fuga del Duca di Sperlinga Saverio Oneto nella chiesa dei Cocchieri, immediatamente dopo ucciso il provocante D. Michele.
E poichè la immunità era il salva nos dei frodatori del denaro pubblico e privato, ecco nel 1794 il fallimento per migliaia e migliaia di scudi a danno del Senato da parte «dei gabellotti del partito della neve di provvista della città». Giusto allora un certo Principe, «amministratore generale della neve, si cautelò sopra la chiesa dei PP. Mercedarî del Molo alli Cartara», (chiesa demolita non è guari), e «Girolamo Tagliavia ed Adamo se ne scappò da Palermo», anche per fallimento a danno di parecchi altri negozianti.
Giovanni Cane, «carbonaio di estrazione nell'arredamento della provvisione del carbone a male per la città», per molti mesi vendette a 14 o 15 tarì la salma il carbone che avrebbe dovuto per accordo ed ordine del Senato vendere solo a 12 tarì (L. 5,10). Guarentito dai suoi amici, scampava il carcere; ma il ribaldo lasciava nelle peste i suoi benefattori col solito rifugio sacro; come a breve distanza di tempo facevano nella chiesa di S. Domenico certi rei di tumulto247.
Ecco G. B. Salerno, per mancata fidejussione, sottrarsi in una chiesa ai rigori della legge e dopo cinque anni di perduta libertà, stando sempre dentro o innanzi la chiesa, impetrar grazia al Re che volesse condonargli la pena in considerazione d'una paralisi ond'era stato colpito durante lo asilo e della estrema miseria alla quale e lui e la sua famiglia si eran ridotti248.
Ma nel privilegio erano tante condizioni, eccezioni, riserbe che l'osservanza di esso rendeva eccessivamente complicata la procedura ecclesiastica e, peggio, la criminale e civile ordinaria, quando ci fosse stato mezzo di afferrarsi ad un addentellato qualsiasi. Vi sono esempî di salvaguardia accordata dall'autorità ecclesiastica per ragioni del tutto frivole: ed un Conte, dopo d'essere stato per due mesi nel convento di S. Francesco li Chiodari, volendosi costituire alla giustizia civile, otteneva una salvaguardia della sua persona nel convento medesimo249.
E non pur complicata, ma anche elastica era quella procedura. Nelle chiese nelle quali mancavano luoghi comodi, il reo era facoltato ad uscire ogni volta che un bisogno lo imponesse. La immunità accompagnavalo anche per questo: e nessuno, in quel prosaico quarto d'ora, o per condizioni speciali patologiche, le quali potevano prolungarsi o ripetersi più volte al giorno, avea diritto di coglierlo in infrazione di legge d'asilo250. Guai allora, o nel momento della funzione fisiologica, o stando egli comodamente in chiesa, a mettergli le mani addosso!
Il 4 ottobre 1785 tre soldati della Compagnia rusticana di Capitan reale di Palermo strappavano violentemente dalla chiesa del convento francescano degli Scalzi un secolare testè rifugiatovisi per non so quale delitto audacemente commesso. Quei poveri soldati dovevano averne le tasche piene: sicchè, ghermitolo appena, lo bastonavano di santa ragione e lo graziavano d'una coltellata. Ne nasceva un putiferio, ed il Governo si affrettava a punire quanto più severamente potesse i suoi agenti infliggendo loro anche la condanna di farsi assolvere della scomunica nella quale erano incorsi.
Se vogliamo saperne qualche cosa, chiediamone al Villabianca il quale fu presente e descrisse la scena.
«L'assoluzione, egli racconta, fu data da uno dei canonici della Metropolitana, Orazio la Torre dei Principi la Torre. Vestito pontificalmente con mitra in testa e con cappa magna di color violaceo, costui si postò a sedere in sedia privata sopra di un talamo di tavole, apparato di tela azzurra, e senza coltra, che fu innalzato innanzi la porta falsa della chiesa di Porto Salvo nel Largo della Marina. Due vivandieri, o sian prebendati del Duomo, furono ad assisterlo, sedendo su due banchetti coperti di panni neri assieme con parecchi rossolilli, che son li ragazzi sagrestani della maggior chiesa. E qui facendosi salire li scomunicati, si denudarono ad essi le spalle. In questa situazione di cose gridò tosto il Canonico una erudita ed elegante concione al popolo che vi stava di sotto, concorsovi innumerabile, a portar rispetto alla chiesa, e battendo più volte i rei nelle spalle con verga di granato, s'ascoltò in tale atto la intonazione del Miserere dei defunti ad petendam Dei misericordiam fattavi dai suoi assistenti. Passò alla fine all'assoluzione pubblica, che a quelli concesse in ampia forma, giusta il rito di Santa Chiesa, con che prese termine il tetro, triste spettacolo»251.
E pensare che era Vicerè D. Domenico Caracciolo.
Guardando con serenità agli effetti dell'abusiva interpretazione del diritto d'asilo sacro, il Vicerè Principe di Caramanico nel 1787 evocava le antiche discipline in proposito, ed ordinava:
«Quando gl'inquisiti prendono l'asilo della chiesa, deve da tutte le Corti capitaniali osservarsi la seguente regola: se sono rei di omicidio o di grave ferizione, che possa cagionare la morte, o pure fossero pubblici ladroni e stradarj, o rei di lesa Maestà divina ed umana, in primo vel secundo capite, o di dolosa decozione o di altro qualunque delitto, escluso dall'immunità ecclesiastica per l'ultima bolla di Benedetto XIV, esecutoriata in Regno, in tali casi, chiesto il braccio ecclesiastico, si prendano e si carcerino per la chiesa coll'avvertenza dello spettabile Avvocato fiscale. Tali carcerati non si possono citare, nè subire, nè restringere sino alla sentenza dell'esclusione dell'immunità, ma si devono cautelosamente custodire. Proferita quindi la sentenza esclusiva dell'immunità locali, si devono ripetere i testimonj citato reo. Se dal Vicario locale del Vescovo si niegasse il braccio, o pur si ritardasse al segno che potesse temersi la fuga del reo, si prenda dalla chiesa e si carceri senza il braccio ecclesiastico e se ne dia subito conto allo spettabile Avvocato fiscale con mandarglisi la relazione degli officiali, a' quali venne negato il braccio ecclesiastico».
Come si vede, qualche restrizione, un po' timidamente se si vuole, ma con una certa precisione, è fatta. Pure la preoccupazione per le conseguenze d'un passo falso, d'un abuso anche piccolo a danno dei godenti il diritto d'immunità, si tradisce in ogni parola, ed è evidente nel seguito dell'articolo:
«I rei di tutti gli altri delitti non esclusi dal sacro asilo, si lascino sopra chiesa, e sia della cura del Capitano e degli altri officiali il coglierli fuori chiesa. Se però facessero abuso del sacro asilo in qualunque maniera o con uscir fuori, o con commettere nella chiesa medesima delle enormità e tresche scandalose, o con ripostare in chiesa i furti da altri commessi: col braccio ecclesiastico, nella maniera sovra espressata, si prendano e si carcerino per la chiesa colla suddetta avvertenza; e per non incorrere nelle conseguenze di così grave partito, si compili colla maggior sollecitudine il processicolo del fatto abuso, e si mandi al Tribunale o allo spettabile Avvocato fiscale».
E per gli ecclesiastici?
«Se un prete o un chierico in minoribus, regolare e secolare, commette un atroce delitto, a norma del reale rescritto del 1777, la Corte Capitaniale ne compila il processo, e, finitolo, col braccio del Vicario ecclesiastico, deve arrestarlo. Se non che, pel chierico importa assicurarsi se, giusta i due requisiti del Concilio di Trento, prescritti pel godimento del foro ecclesiastico, egli abbia portato l'abito e sia andato a tonsura»252.
E già prima del Caramanico altre disposizioni particolari volevano che quelli «che sono rifugiati in chiesa, non potendo star in giudizio, non possano essere intesi se non si presentano nelle forze della Giustizia» ordinaria; e che se «il reo trovasi rifugiato sopra la chiesa, la citazione o sia per affissione o per pubblico proclama sarebbe nulla»253.
Di quest'ordinamento, che costituisce tutta una legislazione, come abbiam detto, complicata, ed una procedura più complicata ancora, che cosa rimane oggi?
Null'altro che vaghi ricordi tradizionali. Una frase del dialetto parlato accenna all'ultima forma nella quale pare essersi ridotto il privilegio. Chi spinte o sponte faccia delle spese eccessive o superiori alle proprie forze, e sia o si presuma o voglia farsi credere nella via della rovina finanziaria, dolendosi di chi o con chi sia causa continua del minacciato disastro che lo porterà a fallire, esclama: Jennu di sta manera, vaju a pigghiu la chiesa di pettu (andando di questo passo, io sarò costretto a correre verso la chiesa). Pigghiari la chiesa di pettu significa: ridursi al verde, fallire: frase, in questo senso, non interpretata da nessun vocabolarista del dialetto!
Nei giuochi siciliani ve n'è uno, solito a farsi specialmente di sera, nel quale una frotta di fanciulli raffiguranti ladri si appiatta in un dato posto; un'altra, di birri, va in cerca di quella per catturarla. Vedendosi scoperti, i ladri si danno a precipitosa fuga; e i birri ad inseguirli fino alla sbarra, o meta, che in una delle molte varianti del giuoco si chiama chiesa. Se gl'inseguiti vengon presi innanzi di giungere alla meta o chiesa, vanno sotto, e pagano la pena; se no, appena toccano chiesa, luogo immune, non possono più esser molestati e rimangono intangibili.
Chi avrebbe mai detto che un privilegio che diede tanti grattacapi a Vicerè, che turbò tanti sogni di Capitani giustizieri, che fece tremare tanti giudici, dovesse un giorno andarsi a confinare tra i divertimenti dei monelli!254.
Tout passe, tout casse, tout lasse!
CAP. XV.
OZIOSI, VAGABONDI, ACCATTONI, «CASSARIOTE», CARESTIA.
All'ozio d'alcuni della società partecipava con altra forma, e in maniera non sai se più riprovevole o disgustosa, l'infima classe del popolo, e, in minore intensità e numero, la mezzana.
Il lavoro difettava; troppi i maestri perchè tutti potessero trovarne; scarsi gli espedienti a campare la vita, per naturale ignavia, per suggestivo esempio di chi poltriva, resa talora inetta.
Al primo giunger tra noi i forestieri rimanevano sorpresi nel vedere «il turbine di popolaglia che, dopo di aver esaurita la campagna, rigurgitava in città, dove dietro un'abbondanza indolente, si moltiplicava come gl'insetti, sui quali non è dato conoscere le vedute della natura, e che pur sembrano nati per consumare. Codesta gente, difatti, si vedeva abitualmente formicolare, ronzare nei mercati, attorno a' commestibili»255.
Gli stessi paesani ne rimanevano sconcertati. «Basta passeggiare, diceva uno di essi, una sera d'està alla Marina, o entrare in una chiesa, ove sieno le quarant'ore, per veder l'abbondanza di questi allegri pezzenti. L'Italia in verità n'è troppo ripiena, e gli oltramontani che approdano ai nostri lidi, gli osservano con maraviglia. Or non si dubita che tutti questi vilissimi sfaccendati sieno la feccia, il capo morto, anzi la peste della repubblica: il saggio braccio del Governo tante volte ha cercato darvi riparo, ma l'erba selvaggia per germogliare in un campo non ha bisogno di agricoltore». E conchiudeva: «Questa gente è detestabile: chi non ha talento per gli studi, vada alle arti; chi non è abile alle arti, faccia il facchino, piuttosto che l'ozioso»256.
Altro siciliano, assai più autorevole, il Meli:
«Migliaia d'infingardi datisi al commodo mestiere d'accattoni, vanno trascinandosi per la città, infingendosi ciechi o storpi, e studiando con comico artifizio assalir da tutti i lati la commiserazione della pia gente, soffocando con lamentevoli strida la fioca voce de' veri poveri, perchè inabili alla fatica, sottraendo e perciò rubando loro le necessarie elemosine»257.
Sul far della sera codesti lazzaroni gridavano a perdifiato fino a mezzanotte cercando d'impietosire e di scroccare qualche poco di limosina. Hager li sentiva gridare: «La divina Pruvidenza!.... Puvireddu mortu di fami!... O boni servi di Diu, faciti la carità!» Ma non si commoveva nè punto nè poco, come «nessuno si commoveva alla loro povertà esteriore. Il loro aspetto era così orribile che io, dice Hager, non vidi l'eguale in altra città; ed è paragonabile solo a quello dei fakiri dell'India»258.
Se poi di giorno guardavasi la turba degli accattoni, poteva studiarsene la natura e la provenienza. Molti di essi erano d'un ordine relativamente agiato, i quali «col solito merito della poltroneria si divorano la mattina due pagnotte calde, ben condite con lardo e salsicce; poi verso il mezzodì si comprano in un parlatoio di monastero un buon piatto di maccheroni ben incaciati, e dopo di aver trincato del vino in una taverna, si sdraiano su di una panca a dormire spensierati»259.
Noi li abbiam veduti fino a quarant'anni fa questi comodi neghittosi, mangiare a due palmenti le pietanze che uscivano dai monasteri.
Il Governo li conosceva uno per uno, e sapeva chi di essi fosse vagabondo, chi ceraolo260, chi romito, addestrati tutti alle male arti di spillar danaro con false apparenze. Contro i quali il 20 giugno del 1789 richiamava le antiche leggi, intese ad impedire il propagarsi della faziosa turba, che sotto colore di domandare per Dio, entrava nelle chiese elemosinando, e sotto forma di esercitare qualche mestiere, si dava a quello molto facile di commetter truffe261.
Ma il bando riusciva inefficace a spazzare il terreno da tanti malvagi parassiti. I forestieri che si trovavano in Palermo ne vedevano sempre un gran numero assediare importuni i frati nei chiostri, i devoti nelle chiese, i civili nei pubblici uffici, i signori innanzi ai loro palazzi con parole lamentevoli molto acconce alle circostanze262; sicchè alla distanza di quattro anni, il bando era seguito da un altro più particolareggiato e più severo:
«Oziosi son coloro che abili a qualunque fatica, robusti, accattano la limosina innanzi o dentro la chiesa, in istrada, nei caffè, affettando piaghe e sconciature nella persona; coloro che conversano nelle taverne e si ubbriacano, che vivono frequentando bagordi, compagnie diffamate, i ladri di sacchetta, i giocatori di vantaggio, i camorristi, ecc.» Tutti «costoro saranno condannati con le catene ai piedi»263.
Truffatori in diversa maniera, ma oziosi e vagabondi, componevano altra malnata genìa che adescava al giuoco i semplicioni e gl'ingenui. Ed eccola in una buona giornata correre nelle vicine campagne, ingombrarla qua e là «di varie ruote di giocatori di carte o di dadi con molte frodi del giuoco stesso e con l'intonazione musicale di orrenda bestemmia. Infelice il vincitore di oggi; sarà il perditore di domani, e, se mai la sorte seguirà a favorirlo, sarà tosto beccato dagli avidi rostri dei malandrini suoi pari; porzione taglia da sicario, da brigante, da sgherro, e fa il guardaspalle la notte a qualche ricco licenzioso; ed in questa s'inchiude la gente di servizio basso, che per lo più costa di araldi rei d'illecite voluttà e di guappi custodi di contrabbandi notturni; porzione è necessitata a fare all'amore coll'altrui roba, e si dispone a visitar le carceri, le galee e forse anche le forche; e porzione, la più inocente, sceglie il mestiere comodo di limosinar per la città»264.
Particolarità degna di ricordo è quella di certe oscene canzoni che questi pericolosi vagabondi cantavano nei luoghi più riposti della città, dove essi si riducevano a consumare il frutto della illecita loro giornata. Tra siffatte canzoni una ve n'era che tutte le avanzava di scostumatezza: Fra Giunipero, contro la quale invano avean tonato bandi vicereali, editti arcivescovili, ed ultimi, sovrani rescritti, determinati specialmente da un richiamo fatto dai parrocci in una rappresentanza al Re in Palermo265.
A più increscioso argomento conducono le donne reclutate nel vasto campo di Citera; le quali molto da fare davano alla polizia e ne rendevano inutile la vigilanza, inefficaci i rigori. Il Governo, nelle sue disposizioni, le accomunava sempre agli oziosi: e nel bando viceregio del 29 maggio 1793 rivelava le abitudini, i fautori ed i posti loro. Quel bando è una pagina di storia della più amara evidenza. Leggiamolo:
«Poichè è giunto alla notizia di S. E. di esser troppo avanzato il numero delle donne impudiche, che passeggiano di notte le strade e luoghi pubblici di questa Capitale insidiando colle loro lusinghe troppo scandalose i cittadini di bassa condizione per indurli a commettere disonestà in mezzo alle strade, d'onde poi ne deriva notabilissimo pregiudizio a questo pubblico e fino alla salute della gioventù; perciò volendo S. E. assolutamente ovviare simili disordini e pubblici scandali, che recano giornalmente gravissimo nocumento a questa città e suoi abitanti, ordina, provvede e comanda che da oggi innanti, suonata che sarà ora una di notte, le suddette donne impudiche, che pubblicamente e notoriamente costerà di esser tali, non possano andar camminando per le strade di questa città, o sedere sopra li scalini delle chiese e cemeterj, anco sotto il pretesto di domandar la limosina, nè restar sotto le pennate266, tanto fuori le porte della città e della Marina e Cala di questa città; quanto nella Bocceria della Foglia, della Carne, Ballarò, Feravecchia, Cassaro e in diverse altre piazze e parti dentro e fuori di questa città, per quale cosa sogliono accadere i suddetti inconvenienti, sotto pene alle suddette donne di mal affare della frusta con otto azzottate (frustate), e di rader loro i capelli la prima volta, e con venti se saranno recidive, e di rader loro le ciglia»267.
Tanto scandalo non ha bisogna di comenti; bensì è da osservare che esso continuò ancora dell'altro senza speranza di fine: prova il rescritto sovrano dianzi citato, nel quale si rileva «che le donne di pubblico commercio trovansi indistintamente ad abitare ne' luoghi più frequentati della città, e col loro cattivo esempio avvelenano le innocenti e rovinano la gioventù. E talune di esse si vedono in tempo di notte girar per le strade ed ardiscono di penetrare financo dietro le porte delle chiese»268.
Qui una osservazione cade opportuna. Quel che si è detto sopra le cassariote potrebbe far sospettare nel basso popolo una corruzione che assolutamente non esiste. Giacchè bisogna distinguere donne perdute (e queste rappresentano sempre un numero sparuto di fronte alla gran massa della popolazione, ed uno stato di delinquenza) da donne che si serbano quali nacquero e non tentennano nè all'aura dell'ambiente, nè al vento che spira dalla terraferma. Il popolo si mantiene come si manteneva refrattario a qualsivoglia esterna influenza di corruttela, legato sempre alle sue tradizioni di rispetto a se stesso, di devozione alla morale, checchè possa esser venuto da fuori, o essersi fecondato dentro, e qualunque sia l'esempio altrui.
Questo nei tempi ordinari; che dire poi degli straordinarî?
Nel 1793 le condizioni della città erano lagrimevoli, desolanti. A cagione della precedente siccità e di una serie di errori economici del Governo e del Senato, il paese, privo di frumenti, era in piena carestia.
Gl'indigenti, uomini e donne, brulicavano come vermi. Furon viste in alcune contrade di Palermo persone cibarsi di erbe selvatiche, altre raccogliere fichi immaturi e cuocerli in aceto, altre strappare il pane che i padroni avean gettato ai cani, altre morire269.
Il Meli vide che
L'erbi cchiù vivi e inutili,Li radichi nociviCu l'animali spartinuL'omini appena vivi.
E senza uscire da Palermo osservò pure che
'Mmenzu li strati pubbliciLu passaggeri abbuccaCu facci smunta e pallidaCu pocu d'erba in bucca270.
La salute pubblica per conseguenza ne soffrì tanto che le febbri putride furon cagione di grande moria.
Il Monte di Pietà chiude gli sportelli. Le case dei popolani mancano delle suppellettili necessarie. Scarseggiano i letti, perchè, venduti gli stramazzi, la maggior parte dei cavalletti erano stati portati come ferro vecchio a Napoli. Appena le coperte bastano di notte a tutelare i corpi271.
Allo spettacolo di tanta desolazione Vicerè, Arcivescovo, signori, benestanti, aprono i loro forzieri. Il Senato acquista quanto più può di grano, e lo distribuisce a grandi forni, che mettono in vendita pane a dodici grani il rotolo: un rotolo quindi ed ott'once, ed anche due rotoli, un tarì la forma volgarmente detta guastidduni272. Tutte le case religiose regolari largheggiano di minestra e di pane ai bisognosi, che a quelle dei Cappuccini si presentano a decine di centinaia.
Allora il bisogno di rimandare fuori la città, nei loro paesi di nascita, i poveri, che sempre, in ogni grande calamità, affluiscono alla Capitale, come a luogo di rifugio e di salvezza. Il Principe di Caramanico a sue spese provvede per alcuni giorni del necessario alla vita quanti ve ne sono: e su carriaggi, col sussidio di quattro tarì per uno, li fa accompagnare da soldati di marina fino a Termini. Ma più ne manda e più ne vengono, finchè sopraffatto dal numero li raccoglie in un sito a Mezzomorreale.
Solo con questo mezzo e per pochi mesi la desolata città si libera del lurido vermicaio, e per esso dalle cassariote, cresciute all'infinito per la infinita miseria273.
Certo il Caramanico non fu solo in tante opere di carità.
La storie del Val di Mazzara, come di tutta la Sicilia, chè la Sicilia tutta fu vittima della epidemia della Capitale, è piena di nobili slanci di abnegazione.
Nella sola Cefalù il vescovo Francesco Vanni fece miracoli di beneficenza. Una iscrizione del 1797, murata da quel Senato, lo addita ai posteri: ed un'altra al Barone Giuseppe Agnello, ricorda la compra da lui fatta di 20.000 scudi di frumento per salvare il paese dalla carestia e dalla fame274. Ma in Palermo il Caramanico fu la vera provvidenza.
Tanto spettacolo di dolore non era nuovo. Quante volte la Sicilia fu travagliata da carestia, Palermo venne invaso dalla poveraglia dei paesi. La attrattiva delle grandi città, ove i mezzi di vivere si presumevano abbondanti, la nomea della Capitale, e, più che altro, la notizia certa che in essa il pane non facesse difetto, (giacchè il Senato non guardava a spese per tener largamente provvista di grani la città medesima pur quando dovesse perdervi metà della spesa) cacciavano come lupi affamati verso di essa quanti eran regnicoli miserabili o bisognosi. Le scene del 1793 richiamavano agli attempati quelle non lontane del 1764, di triste memoria per una epidemia gravissima. Branchi di poveri giungevano ogni dì cercando pane: raccogliendole il Senato nei suoi magazzini dello Spasimo.
Eran centinaia, migliaia di uomini, di donne, di fanciulli, nei quali la macilenza, il sudiciume, il difetto assoluto di aria sviluppava esalazioni putride ed il morbo castrense. La cittadinanza, sgomenta, atterrita, chiedeva per quelli e per sè pronti rimedî; e se non fosse stato per la Deputazione di salute, la quale ricacciava nelle rispettive terre di provenienza gli ospiti pericolosi275, si sarebbero visti rinnovati gli orrori del 1624.
Il disagio economico nei tempi ordinarî non dà luogo a dubitare della ressa dei mendicanti della Città. Una pagina d'un anonimo francese nel 1778 è una fiera requisitoria contro coloro che non se ne curavano...276. Trent'anni dopo, richiamandosi alla fine del secolo, Galt traeva ragione del rincrudirsi della piaga dal concorso dei pezzenti alle porterie dei frati. «L'effetto di questo concorso, attrista. La povertà diviene ogni giorno peggiore, ed in Palermo il numero dei limosinanti è visibilmente cresciuto negli ultimi vent'anni»277.
Tutto questo nella Capitale; uscendo però da essa ed affacciandosi nell'interno dell'Isola, la miseria, vera o simulata, appariva nella crudezza più ributtante. Vediamo come ce la descrive il Meli:
«Il primo aspetto della maggior parte dei paesi, e dei casali del nostro Regno annunzia la fame e la miseria. Non vi si trova da comprare nè carne nè caci, nè tampoco del pane; perchè, tolto qualche benestante, che panizza in sua casa per uso proprio, tutto il dippiù dei villani bifolchi si nutrono d'erbe e di legumi, e nell'autunno di alcuni frutti, spesso selvatici e di fichi d'India.
«Non s'incontrano che faccie squallide sopra corpi macilenti, coperti di lane sudicie e cenciose. Negli occhi e nelle gote dei giovani e delle zitelle, invece di brillarvi il natural fuoco d'amore, vi alberga la mestizia, e si vedono smunte, arsicce, deformi sospirare per un pezzetto di pane, ch'essi apprezzano per il massimo dei beni della loro vita.
«I padri di queste infelici si reputano fortunati se al Natale di N. S. o alla Pasqua possono giungere a divider con la loro famiglia il piacere di assaggiare un po' di carne. Il pane istesso (se pur merita questo nome un masso di creta) loro non si accorda che nelle giornate di somme fatiche, nelle quali, oltre [che del]le zuppe di fave e fagiuoli, vengono ancora gratificati di un vinetto detto acquarello»278.
I visitatori italiani e stranieri non riuscivano a vincere il senso di sdegno e di ripugnanza che in loro nasceva nel vedersi qua e là assaliti dalla turba di sempre nuovi accattoni. Il lombardo Rezzonico della Torre raccontava: «Ai belli Frati (Villafrate) ragazzi ignudi o coperti di cenci, che nè di dietro nè d'avanti nulla celavano, assediano i viaggiatori, e chiedono importunamente l'elemosina; ed io dovei dividere con esso loro il pane e l'uva, e giunsero fino a rubarmi dal piatto le spolpate ossa, e le reliquie del tumultuario desinare, che ai cani si destinavano ed ai porci, di cui qui sono numerose le greggi.»
In Alcamo, «con le sue merlate mura e le torri, ora quadre, ora rotonde del suo castello... regna la miseria e lo squallore, avvegnachè vi siano alcuni ricchi cittadini e qualche bella casa di magnifica apparenza.» Anche quivi il Rezzonico veniva sopraffatto «da miserabile volgo di storpj, di muti, di cenciosi... gravissimo flagello dell'umanità, dal quale la Sicilia non si vedrà mai liberata»279.
In Cefalù l'inglese Galt trovava «un tempio senza pari e una miseria senza nome»280.
Potrebbe chiedersi: Ma nessuno del paese levava la voce contro così ributtante piaga morale? Oh sì! Uno scrittore di Palermo, stomacato più d'ogni altro a tanta indegnità, pubblicava nel Giornale di Sicilia del 1795 un articolo sugli oziosi. Costui esaminando le varie leggi e costumanze antiche e moderne contro la «infesta genia», diceva che dove i governi sono stati provvidi ed attenti nel farle osservare «si vede che bandita la mendicità e la scostumatezza fioriscono le arti.» E finiva così: «Ciò che si è fatto e si fa altrove potrebbe ancora farsi tra noi. A questo effetto basta che si esamini e si calcoli il danno cessante ed il lucro emergente. Basta che si rifletta che in vece di questa povertà importuna, oziosa e libertina, ugualmente perniciosa ed alli buoni costumi ed allo stato, si vedrebbe rinascere la povertà dei primi tempi, umile, modesta, frugale, robusta, industriosa, e che questa medesima povertà diverrebbe la madre fertile dell'agricoltura, la madre ingegnosa delle belle arti e di tutte le manifatture»281.
Inchiostro perduto! Il Governo avea tutt'altro pel capo che il saggio consiglio dell'articolista palermitano. Proprio nel 1795 la caccia ai Giacobini era una delle sue occupazioni ordinarie.
CAP. XVI.
LITI, AVVOCATI, FORO.
I tempi, le leggi, i costumi mantenevano un esercito di persone che vivevano di liti. La parola esercito non è iperbolica. A centinaia si contavano gli avvocati, i patrocinatori, i causidici, i curiali che assiepavano i tribunali, e dalle lagrime dei litiganti ritraevano chi pane e chi agiatezza.
E che cosa poteva farsi in un paese dove gli espedienti del vivere erano scarsi? e dove, quando si apriva sbocco alla gioventù disoccupata la milizia, «nell'esercito di fanteria e di cavalleria non vi eran promozioni, e quelle che v'erano andavano a beneficio dei cadetti?»282.
Si guardi all'indole siciliana e alla sua avversione a qualsivoglia prepotenza, alla naturale inclinazione a litigare anche per un nonnulla (Pri un granu si fa causa, dice un proverbio), all'indomabile passione di stravincere vincendo: si tenga presente l'amore che il palermitano nutre per i processi, ed il carattere suo inconciliabile283: quella specie di rassegnazione di ogni isolano a perdere, non per pacifico accordo, ma per sentenza del magistrato. D'altra parte, si pensi alle malfondate promesse di certi accattabrighe, che facevan vedere di facile vittoria quel che le leggi non potevano consentire, e il trionfo venale di una causa cui la giustizia onesta non favoriva, o piuttosto comprometteva: e si giudichi se non dovessero moltiplicarsi a vista d'occhio i parassiti della società di Palermo. Il poeta siracusano Gomes scrisse tutto un poema sopra La vita delli amari litiganti, ed i proverbî sentenziano che Cui litica e vinci, nenti vinci, che Di 'na liti nni nàscinu centu; che La vurza trema avanti la porta, con ciò che segue284.
Il lettore conosce, per quel che ne abbiamo detto285, le due antiche statue in marmo del Palazzo pretorio, rappresentanti, secondo la volgare interpretazione, due fratelli, a furia di litigare tra loro, ridotti ignudi come vermi e senza un tozzo di pane. Or la presenza di quelle statue era una lezione continua a quanti fossero tentati di cercare giustizia per via giudiziaria, e la leggenda in proposito metteva in guardia contro espediente cotanto pericoloso:
Cu' acchiana 'n Tribunali a fari litiSciuni a la nuda comu li du' frati.
Ma i processi di successione all'infinito per leggi feudali in vigore, «e fondatamente sostituiti al primogenito e sostituiti liberi d'ogni altro gravame che non fosse quello delle pensioni dei cadetti o delle doti delle ragazze»286 erano miniere inesauribili per una falange di sfruttatori, i quali — eccezione fatta di una pleiade di onorati ingegni, gloria del Foro siciliano — dal paglietta scendevano all'infimo scribacchino, uso a copiare, a carattere grande per guadagnare nello spazio della copiatura, citazioni, memorie, istanze e notifiche, e dal dottore in legge andavano al chierico; a cui, per lungo, invecchiato abuso, era libito l'esercizio di agente e procuratore nei tribunali287.
«E così, dice l'Ab. de Saint Non, si arricchisce un popolo di persone di affari delle quali Palermo è piena. Il diritto deve penare sovente a trovar appoggi e difensori; e la Giustizia vi è divenuta un ramo di commercio che fa colare tutto il denaro del Regno in questa città entrando pel canale dei tribunali e riversandolo in seguito nel pubblico col lusso dei membri di essi. Così Palermo non si risente per nulla della povertà e della miseria che si vede in quasi tutta la Sicilia»288. Oh avea ben ragione quel signore a noi ignoto, che conversando col Bartels in Siracusa sfogava il suo dolore per le condizioni miserrime del tempo!
«I tribunali che restano quasi tutti in Palermo, gli diceva, chiamano tutti i negozî giudiziali del Regno in quella Capitale, dove a spese dei litiganti vivono più di ventimila persone, le quali mantengono oziosi i rispettivi servitori, che sono altrettante braccia che mancano alla campagna in un'isola spopolata»289.
Noi abbiamo visto innanzi quanto fosse di vero in quest'ultima proposizione, come in quella dell'Ab. de Saint-Non. Infatti «non v'era casa in Palermo che non avesse un processo; e talune ne avean fino a cinque o sei». Questo afferma il Dr. Hager che dovette saperlo con fondamento290.
In ragione delle cause, i difensori legali. Il Duca di Terranova, in condizioni normali, teneva non meno di otto avvocati e quattro patrocinatori, retribuiti con annuali salarî fissi di diciott'onze i primi, di dodici i secondi; ed erano tra gli avvocati i più valorosi d'allora: Costantino M.a Costantini, in letteratura conosciuto per un buon poema didascalico sopra Il Colombajo, Antonio Vaginelli, Michele Perramuto, Agostino Cardino, Antonio di Napoli291.
Nessuno meglio dell'Ab. Meli ritrasse questa condizione di uomini e di cose tra noi, del Meli diciamo che mise a nudo una piaga, incronichita dai secoli inciprignita da circostanze. Nelle Riflessioni sullo stato presente del regno di Sicilia intorno alla agricoltura e alla pastorizia da noi più e più volte citate, il poeta, anticipando di un secolo le teorie che doveano agitare le società civili del novecento, cauterizzava quella piaga col ferro rovente. Le Riflessioni, delle quali nessuno si è accorto finora, son pagine eloquentissime, e lo storico dovrà ricorrervi come a documento di singolare importanza.
Sentiamo quel che esse ci dicono.
L'autore la piglia molto larga aprendo un limbo, anzi una bolgia generale.
«Che dirò di tante migliaia di uomini sparsi e perduti per la società, come se nati fossero a far numero soltanto, e peso alla medesima, e a consumar dei viveri inutilmente? Tali sono, a mio avviso, quelli, che traggono tutta la loro pingue sussistenza dal cicalio del foro, dalla cabala e dallo intrico: quelli, che sussistono per le sole ciarlerie: quelli, che vivono lautamente professando soltanto il ladroneccio, il giuoco ed altri vergognosi mestieri: dell'immenso numero di uomini destinato allo strabocchevole lusso dei ricchi: quelli che vivono agiatamente con alcuni speciosi pretesti di rubare, colorati col titolo onorifico d'impieghi, tutto il superfluo seguito della Curia decorati coi titoli di Maestri d'atti, algozzini, uffiziali, portieri etc., dei quali la centesima parte basterebbe per servizio dei tribunali, qualora questi s'appagassero di un discreto vassallaggio. Insomma, io intendo parlare di tutto quell'immenso numero di parassiti, di cui abbondano le città del Regno, e specialmente la Capitale che, a guisa di mignatte, succhiano e si nutrono del sangue e dei sudori degli uomini onesti, utili ed industriosi.»
Venendo però ai particolari, eccolo fermarsi sopra i legulei, gli attuarî, i sollecitatori, pei quali già da tempo egli avea composta la epigrammatica ricetta morale:
I possessori di fondi campestri, che avrebbero voluto raccogliersi a godere un po' di pace, nol potevano, «costretti a starsene lungi per difendere il loro feudo, il loro podere nei tribunali, e per reclamare il bestiame... stato loro derubato, o i limiti usurpati, o per impetrar equità all'esorbitanza degli oneri, o per ottenere giustizia contro l'abuso dell'autorità dei giurati e degli uffiziali, delegati per la erezione delle tende e delle gabelle.»
Se un contadino con l'industria ed il sudor della fronte era riuscito a rendere il poderuccio fertile e ubertoso, per l'avidità del vicino prepotente, che avea mandato i suoi figli, o fratelli, o nepoti agli studî pei tribunali, si vedeva subito tagliata la strada. I figli, i fratelli, i nipoti eran baluardi a custodia dei beni del vicino, baliste e catapulte all'assalto dei beni del contadino, costretto per ciò a sostenere le sue ragioni.
Ed eccolo nella Capitale, ove il Meli lo vede e descrive, ed ove con le sue parole lo descriviamo anche noi.
«Le mance per i servitori, e per gli uscieri, le spese per le portantine dei professori che marciano a piedi o con le lor carrozze294, quelle per le citazioni e per i libelli, i terzi dell'onorario per gli avvocati, per i compatroni, per i causidici, per i curiali, per gli agenti etc., etc.; ed ecco consumato in questi primi passi il profitto di dieci, dodici anni delle sue penose fatiche! Se azzarda quest'infelice di aprir la bocca per somministrar le sue ragioni, i termini tecnici del suo rustico mestiere e l'accento particolare del suo villaggio muovono a riso tutti gli astanti; egli insomma appena è ascoltato, niente è capito, come dal suo lato niente capisce del nuovo gergo legale che sente risonare in bocca dei suoi professori. Nonostante questa confusione di lingue, in virtù dei terzi sborsati e dei complimenti, viene distesa una lunga allegazione, della quale se ne formano infinite copie a costo della borza del litigante; si mandano, e si ritornano con un circolo vizioso le liturgiche citazioni; si fissano i giorni delle comparse. Indi si postergano: si tornano a fissare: si scusano: sopravvengono frattanto le ferie, le villeggiature, indi le festività di Natale di N. S., indi li lieti giorni di Carnevale, poi la Pasqua etc., ed ecco le parentesi di mesi ed anni intieri.
«Si maturano intanto i nuovi terzi dell'onorario: si tornano a pagare, e così scorrono successivamente le serie degli anni, di maniera che quest'infelice resta inviluppato nell'inestricabile laberinto del foro, d'onde non ha più speranza di uscire, se non vi lascia financo la pelle istessa.»
Questo dolorosamente osservava il Meli, il quale tornava a battere sul medesimo chiodo:
«L'istesso succede quando ad un contadino viene derubato il bue, l'asino, o il mulo. Quante cure, quante sollecitudini non gli costano le ricerche! E quanti pericoli ancora non incontra per rintracciarne i vestigi! Se non giunge a trovarlo, piange la sua disgrazia. Ma se riesce, la piange doppiamente: imperciocchè le spese per le spie, per la ricognizione della bestia e del legittimo possessore della medesima, per la recezione dei testimoni, per gli offiziali e per le legali formalità, unite all'infinita perdita di tempo, e perciò del lavoro, oltrepassano di gran lunga l'importo della bestia dirubata; di maniera che il miglior partito che gli resta ad eligere è quello di mai più ricercarla, nè più ripeterla dalle mani della così detta Giustizia. Ne siegue da ciò, che i furti non si curano, o s'ignorano; ed i ladri, allettati dall'impunità, si moltiplicano a dismisura.
«Se i coloni sono così scherniti e scorticati dai cittadini e dalla gente del Foro, non minore è la disgrazia che incontrano presso i medesimi li fondi rusticani. Per convincersi di questa verità, basta gettare un colpo d'occhio a quei poderi caduti nelle mani del fisco o di altro magistrato cui s'è affidata la cura dell'amministrazione, e si vedrà, che uno o due anni di siffatta amministrazione equivalgono ad un grande incendio»295.
Idee non dissimili aveva il Meli espresse nel suo poema eroicomico Don Chisciotti e Sanciu Panza: ed i seguenti versi su Giove ne sono la sintesi:
Avirrà multu assai forsi chi diriDi l'avvocati e di li professuri,Genti chi a liti, sciarri e dispaririCi ànnu attaccatu l'utili e l'onuri;La società fratantu àvi a nutririSti tali a costa di li soi suduri;L'apa cogghi lu meli in ciuri e in frutti,Ma ciarmulìa l'apuni, e si l'agghiutti296.
L'organamento di questa vasta associazione per interessi personali era come una immensa rete che niente lasciava sfuggire e a nulla rinunziava per raccogliere i cercatori di giustizia. Il Vicerè Fogliani in una prammatica che è «un novello e stabile regolamento alle sospensioni che si voglion de' giudici da parte de' litiganti dietro alle clientele e avvocazioni che ne hanno quelli tenuto prima dell'atto di vestir la toga di loro giudicatura», ha questo paragrafo che è una rivelazione: «I litiganti sogliono tener salariati alcuni avvocati occulti, i quali non vanno a patrocinare la lite nel pubblico tribunale, ove il giudizio è pendente, ma solo assistono presso qualche giudice che deve decidere la causa»297.
Avvocati e professori erano pertanto legati da cause comuni. Il professore, persona pratica, riceveva i clienti, la causa dei quali diventava faccenda tutta sua. Egli sceglieva e suggeriva l'avvocato, che perciò avea per lui la considerazione imposta dalla importanza della causa.
I larghi guadagni erano incentivo a spese non solo di necessità, ma anche di lusso. Le famiglie dei forensi non rinunziavano a quello che potevano, e si permettevano anche quel che non potevano: spese per vivere, spese per vestire, spese per agi, che consumavano le più pingui entrate. In poche classi del ceto civile si spendeva più che in questa dei forensi, tanto spensieratamente facile a buttare nella follia d'un divertimento, nella vanità d'una villeggiatura una somma pari alla dote d'un modesto artigiano. V'è da maravigliarsi di cosiffatto sperpero, sovente non consentito dagli stessi introiti.
Il dì 21 luglio del 1778 per i soliti luoghi della Città si leggeva un lungo avviso a stampa, che principiava con queste parole:
«La estrema indigenza in cui sovente si son vedute cadere le vedove ed i figli non che dei curiali, dei procuratori causidici, degli avvocati, ma talvolta dei defunti ministri, perchè rimasti dopo la morte dei loro capi sprovveduti di tutti gli umani soccorsi per vivere e sostenersi; e i tristi deplorevoli effetti che quindi ne sono succeduti, i quali, con non poco rossore de' ceti così rispettabili, li han trascinati alla mendicità, o dati in braccio al vizio ed alla scostumatezza, indusse l'animo del Procurator causidico D. Stefano Tortorici a promuovere il plausibile mezzo della erezione di un Monte di vedove, con cui accorrere al riparo di così gravi disordini ed al sovvenimento e sussidio delle povere desolate famiglie»298. Condizioni per partecipare alla nuova istituzione: un contributo annuale. «Arrolandosi in esso tutti coloro che saranno avvocati causidici, curiali e professori qualunque siansi di curia, godranno del mantenimento delle lor vedove e parenti alla ragione di tarì tre o tarì sei al giorno pagando ogni anno onze tre od onze sei al Monte».
Ma che erano essi i tre, i sei tarì al giorno per una famiglia che ne sciupava cinque, sei volte tanti in feste di città e di villa, in ricevimenti e addobbi?
Checchè se ne pensi, il disegno tradotto ad atto dal previggente Tortorici era degno del valore di lui di procuratore criminalista, e meritò il plauso dei buoni.
Qui agli occhi del lettore si delinea un punto interrogativo.
Come si moveva l'amministrazione della Giustizia in mezzo all'ambiente non del tutto sano del tempo?
Ci affrettiamo a cancellare questo punto interrogativo affermando che la integrità della vecchia magistratura siciliana metteva i membri di essa fuori qualunque sospetto e discussione. Se non ci fossero altri esempî, basterebbe quello solo della sentenza di morte profferita dalla G. C. Criminale in persona di Emanuele Caniggia palermitano, paggio amatissimo del Principe di Caramanico, con vero strazio del vicereale padrone decapitato nella Piazza Marina (10 ott. 1789)299.
Se poi casi contrarî possono trovarsi, sarebbe ingiustizia farne ragione di giudizio generale men che favorevole. Le eccezioni, abbiam detto altrove e ripetiamo qui, non fanno regola; e tra queste eccezioni, per dir tutto, rileviamo una incomprensibile.
Nei conti della già cennata Casa del Duca di Terranova si riscontrano spese per distribuzione di carbone a grandi dignitarî politici e giudiziarî del Regno. Queste distribuzioni son chiamate regalie solite e ve n'è di 200 quintali (chil. 16000) al Vicerè, di 50 al Segretario, di 50 al Consultore, di 20 per uno (il lettore faccia attenzione!) ai Presidenti della R. G. Corte, del Patrimonio e del Concistoro; e di 12 per uno al Maestro Razionale del Patrimonio, all'Avvocato fiscale della R. G. Corte e a quello del Patrimonio.
La diciamo incomprensibile perchè ordinaria, e come tale, alle illustri autorità che la ricevevano non dovea parere lesiva della loro onestà e della loro indipendenza.
Ma si trova anche qualche regalia straordinaria a giudici, proprio nel momento che liti della eccellentissima ducale amministrazione pendevano in tribunali. Ecco in proposito un modesto appunto: «Pagate per prezzo di carbone, regalato straordinariamente a D. Emmanuele Bottari, giudice della R. G. Corte Criminale, e D. Luigi Mattias, primo officiale della Segreteria di S. E. Sig. Vicerè, ed altri ministri di questi Tribunali, per le cause del nostro Ecc.mo Duca, vertenti nei medesimi, onze 24,20 (L. 314,50) prezzo di poco più che cento quintali (kil. 8000) di carbone.
Forse la pentola della giustizia, no: ma certo quella dei giudicanti deve aver bollito abbastanza rigogliosa col carbone di un litigante come il potente Duca di Terranova.
Ma v'è ancora di più, che non è bello, nè buono.
Un altro appunto dice così: «Pagate a D. Giuseppe... giudice della R. G. Corte Criminale, per mani di D. Ingarsia ed alla presenza di D. Giuseppe Prado, agente, e di D. Giov. Batt. Pedino, per decidere l'articolo contro il Sac. D. Vincenzo Insinga, che si agitava nel detto Tribunale di R. G. Corte, onze 32».
Copriamoci gli occhi per non leggere altro. No, non si tratta più, osserva giustamente un egregio uomo, di un gentile dono di carbone che il ricco produttore e proprietario delle carbonaie di Caronia facea ai magistrati che doveano decidere delle sue liti; «ma bensì di un donativo in denaro corrente, nella cifra ragguardevole per tempi di onze 32, pari a L. 408, che un potente litigante facea ad un giudice decidente; e che colui che pagava (ch'era il curiale della Casa), onde non si potesse dubitare di un suo abuso di fiducia, eseguiva alla presenza di due testimoni, che egli avea la prudenza d'indicare; dei quali l'uno (il Prado o Prades) era l'Agente generale della Casa; sicchè tutto potrebbe far sospettare che si trattasse di un vero e proprio peculato»300.
Con la maggior semplicità del mondo troviamo notato un pagamento analogo nelle carte del nobile Collegio degli Aromatari di Palermo. Sullo sdrucciolo delle protezioni, Governo e Senato dispensavano indebite licenze. Il Collegio faceva opposizioni e rimostranze. L'opera degli avvocati e procuratori era quindi necessaria, e non è a dire con che scapito del patrimonio sociale. Giunte (consulti) si succedevano a giunte; ed era un continuo spendere per liti che non finivano mai.
Il 17 dicembre del 1785 il Segretario del Senato La Placa intascava un regalo in moneta corrente di tre onze per una consulta favorevole da lui presentata al Pretore sopra un memoriale del Collegio301. Il La Placa, uomo saputo nelle patrie istituzioni, riceveva egli il premio d'una giustizia dovuta o d'una ingiustizia indegnamente provocata? Se d'una giustizia, fa nascere il sospetto d'una vendita; se d'una ingiustizia, è addirittura un traditore della fiducia che il Senato riponeva in lui e commetteva un crimine da codice penale.
CAP. XVII.
CARCERI E CARCERATI.
Di carceri non era scarsezza in Palermo: e tanti ce n'erano quante le giurisdizioni, i ceti, i sessi. Fino al 1782 facevano tremare quelle del Sant'Uffizio, specialmente le cosiddette filippine; ma vi erano pure le ecclesiastiche sotto il Palazzo arcivescovile; le senatoriali dentro il Palazzo pretorio e presso di esso e di S.a Caterina; donde, già tempo, si passava a quelle di fuori Porta di Carini ed alle altre della Vetriera per le donne. Più famose tra tutte, le carceri della Vicaria (dopo il 1840 divenute palazzo delle Finanze) pei plebei, e del Castello pei nobili e pei civili.
Strane le vicende della Vicaria!
Nata come fondaco della Dogana e come sede dei tribunali fra il 1578 ed il 1593 sotto tre Vicerè: Marcantonio Colonna, il Conte d'Albadelista (il famoso jettatore del ponte di Piedigrotta alla Cala) e Arrigo de Gusman, a spese del Senato, l'eterno banchiere che vi erogò centinaia di migliaia di scudi; essa stette sotto la giurisdizione dell'autorità municipale, la quale ne fece pubbliche prigioni.
Come per irrisione, ai lati della ferrata d'ingresso rumoreggiavano gaiamente le argentee acque di due fontane. All'angolo destro sporgeva la grande trave della vergogna. Sopra, per tutta la facciata meridionale e torno torno all'edificio, correvano finestre a grosse spranghe, che dalle prime ore della sera alle prime ore del mattino venivano incessantemente martellate da vigili guardie. I vicini non si sapevano assuefare a questo molesto rumore notturno, che col sonno toglieva loro la quiete, e molto meno ai «sospiri, pianti ed alti lai» che dal tenebroso luogo uscivano. Miss Cornelia Knight, signorina di compagnia della Principessa Carlotta di Wales, nei pochi giorni che vi stette vicino (gennaio 1799) udiva tutta la notte «i gemiti ed i lamenti delle povere creature» chiusevi dentro302.
Dopo la prima entrata nel doloroso luogo ve n'era un secondo conducente all'atrio, abitazione del carnefice. Nell'atrio, sinistri arnesi di dolore, spiccavano i tre legni delle forche, le scale, lo steccato per gli atti di giustizia. I tumulti del settembre 1773303 spinsero una turba di efferati fra le più scure tane di questo carcere; ruppero inferriate, sbrandellarono le divise del boia, ridussero in frantumi i ferali strumenti, e portaron via il più odioso ricordo del triste albergo, una pila in pietra, che ogni siciliano nominava con terrore, oggetto della più brutta imprecazione: Chi putissi vidiri la pila! come per dire: Che tu possa andare in galera!304.
In questo carcere, nello spirare del settecento, se la tradizione non falla, avrebbe avuto origine altro motto, erroneamente riportato all'epoca del Vespro siciliano. Perchè, essendo stati per certe loro discolerie arrestati in Palermo e chiusi in uno stanzone della Vicaria, in attenzione di risoluzioni, o a disposizione di un console estero interessato, non so quali marinai stranieri, appartenenti ad un legno francese, dimenticati da tutti, mal ridotti in arnese, passarono in proverbio sotto il nome di francesi: e camerone dei Francesi fu detta da quel giorno la lor notevole dimora, e francese cominciò a significare persona senza un quattrino305.
I carcerati eran tenuti malissimo in Palermo; orrendamente nelle terre feudali. Il Caracciolo, impietositosene, emanò un bando a loro favore. Questo il 25 aprile 1785. Dopo 10 anni il bando attendeva dell'altro la sua attuazione. Il 12 agosto del 1794 il Caramanico, impressionato delle frequenti fughe di detenuti, pigliava provvedimenti acconci ad impedirle; ma non presumeva che il trattamento sarebbe continuato com'era stato fin allora.
Qualche cosa di nuovo frattanto si ora cominciata: separate le donne dagli uomini, i giovanetti dagli adulti; le male femine, condotte alla Vicaria, non vi si fermavano che per esser mandate al loro carcere della Vetriera; i minorenni delinquenti allontanati dagli uomini induriti nel vizio e nei delitti, ed isolati nella Quinta Casa, al Molo (29 maggio 1787). Prima marcivano nell'ozio, fomite a mal fare; ora, col nuovo istituto, rigenerati pel lavoro, attendavano, i maschi a fabbricare ceste e funicelle, le fanciulle a filare. Avean sofferto il digiuno, la sete, il freddo: ed ebbero pane, minestra, cacio, verdure, vino, letto, vesti, quanto insomma potesse bastare alla vita; ma ebbero pure qualche cosa che non avrebbero voluto avere: carcerieri, ed un firraloru, che a sferzate li metteva a dovere306. I delinquenti del Molo perciò potevano dirsi felici a paragone di quelli della Vicaria. Qui i detenuti per reati civili vivevano confusi coi criminali, i debitori coi ladri, i falsari coi violenti. Fosse, dammusi, «segrete», eran sottoterra, buie, grondanti umidità, sudice, muffite, angustissime307. Codesto carcere, già sin dal 1773 orribile, parve atroce dopo i subbugli di quell'anno. Rifatte in grosse spranghe di ferro certe grate di legno, impiccolite le celle, divennero per difetto di aria e di luce sepolture di vivi. I canti popolari sull'argomento sono d'una evidenza spaventevole.
Lì languivano mesi ed anni, in lenta agonia o in angosciosi palpiti disfacendosi, stracciati, scalzi, seminudi talvolta, centinaia e centinaia d'imputati in attesa di un giudizio che non veniva mai308. Salvo i rari casi di delitti atroci e clamorosi in città, i quali venivano giudicati in forma direttissima e con giustizia esemplare, tarde le istruzioni, lente le procedure, eterna l'aspettativa dei giustiziandi; e quando non ci si pensava più, ecco la esecuzione!
Diego Colombo da Messina, omicida del 1783, catturato nel 1793, veniva condannato a morte nel 1796. Allorchè gli si fece la grazia di vita, egli era più morto che vivo. Se non fosse stato pel procuratore dei carcerati poveri D. Stefano Tortorici (1788-93) e per D. Antonino Igheras (1794)309, se non ci fosse stata l'opera della nobile Deputazione della Vicaria, che con carità senza pari si occupava di questi disgraziati, amministrandone lo scarso assegno, chiedendone con viva insistenza ed ottenendone dal Re l'aumento, e convertendo questo in pane310, che essa ogni mattina andava pietosamente a distribuire, quanti di questi infelici non sarebbero morti di fame!
E sì che le carceri ogni anno venivano sfollate di un centinaio di reclusi, o per grazia di libertà, o per riduzione di pena, o per condono di debiti, loro concesso dal Vicerè nella festa di Natale, e dal Capitan Giustiziere in quella dell'Assunta311.
Macerati dall'ozio i carcerati in comune cercavano romperne la insopportabile monotonia con passatempi pei quali non occorreva loro altro che una moneta e ciò che il sudiciume purtroppo non fa mancare in tanta miseria: gli insetti312. Il pediculus capitis e la mosca erano i preferiti; e da essi prendeva nome il passatempo, quanto schifoso altrettanto alieno da inganni. «I carcerati, dice Villabianca, son quasi ignudi; prendono una moneta e vi fanno volare le mosche della camera. Vince quello sulla cui moneta viene a posarsi la mosca, detto perciò Jocu di pidocchiu, o di la musca, o di carcerati313.
Ora a sì lento logorio di corpo e di spirito non erano da preferire le malattie, per le quali potevasi sperare o la fine di tanti strazî o un temporaneo trattamento umano?
E le malattie si facevano purtroppo vedere.
«O quante migliaia di questi miserabili muoiono lì dentro d'angosce, di miserie e di febbre contagiosa, detta dai medici di carcere o castrense!» esclamava quell'anima onesta di Giovanni Meli. Così almeno poteva l'infermo vedere il viso di un medico umano, e all'Ospedale grande e nuovo prima, alla infermeria del carcere poi, ricevere un po' di conforto314.
Al Castello si stava non molto disagiatamente, ma i cammarotti, dove agli imputati di crimenlese, con le più strette ed insidiose subizioni si cercava di strappar di bocca confessioni di fatti, erano quanto di più formidabilmente feroce avesse ideato l'umana nequizie. Un infelice, certo Mosca, giovane a 26 anni, confessava tra i tormenti un delitto de nefando, del quale era in sospetto. La penna si rifiuta a descrivere il suo supplizio, incominciato col trascinamento del corpo a coda di cavallo e finito col vivicomburio: ma la penna scrive a lettere di sangue che dopo sei anni bruciato, il Mosca veniva riconosciuto innocente!
Prima di chiudere l'argomento di questo capitolo giova richiamarsi ad un documento uscito dalle mani del Vicerè Caramanico: Istruzioni per l'amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause e materie criminali. Esso ci rivela che il rigore delle leggi contro i rei e gli imputati tendeva un cotal poco a rimettersi da quel che era stato. Ci si sente l'aura dei tempi che mutano, e vi alita sopra come uno spirito, non vogliam dire umanitario, ma meno duro che pel passato. La crudeltà delle leggi vi si spunta per via di interpretazioni a favore degli imputati e dei testimonî: e si giunge fino a vietare l'uso dei ceppi se mai per caso le gambe del reo diano indizio di piaga, ed a consentire che si mandino in carcere a casa sua, previa guarentigia, il reo gravemente infermo315.
Tutto questo è progresso. Eppure resta tanto e tanto di brutto e di crudele che l'animo anche più indurito ne rabbrividisce.
Lasciamo alla Pratica di D. Zenobio Russo316 tutto l'arsenale delle vecchie e delle nuove leggi, e spigoliamo nelle Istruzioni provocate dall'Avvocato fiscale della Gran Corte D. Giuseppe Guggino qualche novità processuale.
Eccone una:
«Li testimoni che, carcerati o ristretti nei dammusi, non depongono o che depongono quanto dissero nel primo esame avanti al Giudice; non devono pagare spesa alcuna di carcere nè diritto alcuno alla Corte e subalterni sotto qualsivoglia pretesto: salvochè tarì uno (cent. 42) al carceriero se sia stato in dammuso, per il servizio prestatogli».
Eccone un'altra:
«Al reo o testimonio ristretto nei dammusi non si possa negare il pane in grana sei al giorno allorchè se gli somministra dai suoi congiunti o amici; se però il pane per la sua povertà se gli somministra dal Barone o dall'Università, non possano l'una e l'altra esser obbligati che a grana quattro (cent. 8) al giorno, come si prescrive nelle circolari; eccetto il caso di una insolita penuria, per cui il pane fosse meno di once sei (gr. 400) per ogni quattro grani, poichè allora il Barone o l'Università gliene deve contribuire grana 6 al giorno. L'acqua deve somministrarsi senza limitazione.... Deve il dammuso essere provveduto del vaso necessario alle corporali necessità...»
Un'altra ancora:
«Tormenti straordinari son lo manette, i ceppi, le catene, i grilletti.
«Si possono apporre ai rei al più due paia di ferri alle gambe, che non devono essere più di rotoli dodici di peso per ognuno di essi317. Si proibisce però generalmente che i ristretti in dammuso, o rei, o testimonî renitenti che siano, per qualunque delitto si spogliassero delle vestimenta, ed ignudi, o in camicia si obbligassero stare in dammuso: dovendo essi restar vestiti secondo la stagione che corre; e deve altresì permettersi a' medesimi una covertura ne' tempi d'inverno»318.
Non passava anno che qualche bandito, o ladro, o scorridore di campagna non capitasse nelle ugne della Giustizia. Allora lo conducevano alla Capitale, quando a cavallo la compagnia che lo avea catturato, ai servizî o col nome di un comune o di un gran signore del Vallo (ed eran celebri le compagnie del Principe di Butera, di Randazzo, del Duca di Terranova, di Monreale), quando a piedi i birri della Gran Corte.
Nel solo 1797, di queste condotte ne avvenivano tre: a maggio, a luglio, a dicembre.
Il bandito procedeva strettamente legato in mezzo a coloro che l'avean preso, il capo inghirlandato di erba, di fiori, di oleandro; il collo cinto da una gàrbula, o cassino, cerchio sottile di asse da crivelli e tamburi. S'egli andava a cavallo, le redini della mula erano raccomandate al boia, il quale chiamava allo spettacolo a suon di tromba e indicava il cartello che il reo portava addosso. Era un vero trionfo della Giustizia rivendicata, o piuttosto degli uomini che erano riusciti al gran colpo. Sommo perciò il giubilo degli interessati, reso più intenso da frequenti squilli di tromba e da non men frequenti spari di archibusi, da ultimo ripetuti con una scarica generale innanzi le case dei ministri di Giustizia319.
Quando il bandito era stato ucciso nello scontro, la festa si facea medesimamente, ed il suo capo, pur esso coronato di fiori, veniva infisso ad un'asta sorretta come trofeo dal boia o da uno della squadra.
Particolarità raccapricciante: quando il dì 11 maggio 1797 si menarono in giro tre teste, ed un giovane con esse veniva trascinato a ludibrio della folla, una di quelle teste era del padre suo!
CAP. XVIII.
IL BOIA E LE ESECUZIONI DI GIUSTIZIA. GRAZIA DI VITA. DOLOROSA STATISTICA DI GIUSTIZIATI.
Il boia era, come il porta-lanterna, l'essere più abbietto della Giustizia.
Vestiva sempre casacca, calzoni, berretto e calze di panno, metà rosso, metà giallo, sì che da un lato aveva il colore del sangue e dall'altro quello della morte: livrea ufficiale, non creata ma riprodotta sulle fogge italiane del sec. XIV. Egli non poteva mai smetterla; ed al bisogno la copriva con un cappotto d'albagio nero, dietro il quale era disegnata una forca320.
La provenienza del boia era degna del suo mestiere. Egli era stato un condannato a morte o alle catene perpetue; ma avea ricevuta la grazia della vita a condizione che la togliesse agli altri con tutte le forme legali della giustizia: orribile baratto, che fa tremare di ribrezzo!
Un giorno uno dei due boia (giacchè non ne occorrevano meno)321, nell'apparecchiare a S.a Teresa le forche pei compagni di F. P. Di Blasi, va giù per terra e si rompe le noce del piede. Rimasto inabile a giustiziare, si pensa ad un altro, anche interino. Si crederebbe? tra condannati e liberi, ben venti si offrirono all'infame ufficio, nuovo genere di caccia all'impiego, che dava appena venticinque grani il giorno (cent. 53) contro i trentacinque che ne avea il boia maggiore. Se non che, questo avea dei procacci, gl'incerti del mestiere, che po' poi eran certi, in quanto di giustiziandi non era mai penuria, e le fruste coi relativi emolumenti erano frequentissime. La pubblica voce poi gli attribuiva altri guadagni, provenienti dai risparmî sulle mule che trascinavano il carro dei rei; mule stecchite, bolse, veri ronzinanti, pagati a poche grana (centesimi) dal carnefice, ad onze dalla Giustizia322.
Il boia stava pronto a tutte le chiamate. Nun manca pri lu boja, diceva il proverbio; e chi passava dalla Vicaria vedevalo sempre seduto sopra una pancaccia, quando dentro, quando fuori del portone. Se gli occorreva di andare in un sito, di toccare qualche cosa, non poteva farlo altrimenti che con una verga, non dovendo egli posare le mani nefande su nulla. Era sempre accompagnato.
Varie e diverse le pene, varie e diverse le funzioni del boia. Come in segno del mero e misto impero e della giurisdizione feudale all'ingresso delle terre dei baroni fuori Palermo eran piantate in permanenza le forche, così alle Quattro Cantoniere era un cavalletto pei ladruncoli ed altri delinquenti del giorno. Legato mano e piedi su quello, a carni nude, il reo riceveva sulle parti posteriori del corpo le nerbate ordinate dal Giudice, e veniva, senza più, condotto al carcere o alla galera; se ragazzo, era trattato con sonore sferzate.
Non men grave la berlina, che variava in ragione dei delitti, delle giurisdizioni e del capriccio del giudice. Ordinariamente però il boia conduceva a mano la mula e di tanto in tanto chiamava il pubblico con isquilli stridenti di tromba. I birri gli davano braccio forte, e dove un tempo, per la divisa comune, si confondevano con gli artigiani, dal 1774 destavano un senso di timore con quel giamberghino rosso, e quella loro giamberga turchina, sul cui petto splendeva minacciosa l'aquila inargentata. Un lordone, ossia uno della nazione lombarda, di S. Orsola, veniva condotto in giro sopra un asino per mercimonio di moneta spicciola, e portava legato al collo un sacco di cosiffatta moneta (1773). Ma egli era più fortunato di quel cancello (vetturale), a cui per essere andato a cavallo in città veniva inflitta la pena della vendita del mulo che gli dava da mangiare!
Per ragioni di furti soggetti alla giurisdizione pretoriana alcuni giovani, d'ordine del Pretore, eran messi (1774) sopra altre bestie di vetturali e portati alla berlina pel Cassaro fino alla Vicaria. Malgrado che ai lati camminassero i soldati di Marina, il boia non mancava; e perchè non faceva sentire abbastanza il suono della sua tromba, redarguito vi metteva maggior forza. Una canzone relativa allo spettacolo ha questa strofe:
E ddu scintinu bojaLa mula chi arrinava:La trummetta sunava,E spiavanu chi fu.
Per furti soggetti alla giurisdizione ordinaria il delinquente andava soggetto ad un segno di conoscimento ed anche d'infamia sopra una spalla, segno che era la lettera F. colla data del delitto. Così era facile leggerglisi, p. es.: F. 93 (Furto, 1793). Gli studiosi di criminologia moderna gradiranno sapere che queste marche eran tatuaggi, segni fatti a punta d'ago sulla viva carne323.
Un facchino di piazza coperto d'uno straccio simboleggiante la toga senatoriale, camuffato da Senatore per le grasce, camminava per Ballarò. Lazzari e monelli in frotta, gridando e sghignazzando, lo seguivano, pronti a svignarsela non sì tosto comparissero i soldati di Marina. Al giunger di questi, si chiama il massaro dell'Ospedale dei matti, e gli si affida con le catene ai piedi il malcreato, il quale stavolta senza boia, da Ballarò, pel Cassaro, Porta Felice, la Marina, viene condotto in carcere a S. Giovanni dei Leprosi, manicomio e spedale delle malattie di pelle.
Analogo a questo, altro delitto, che prende forma di profanazione o di sacrilegio; e analoga alla pena del facchino è quella toccata al sartore e sagrestano Ignazio Gulotta, reo d'essersi finto sacerdote celebrando non so quante messe e confessando.
Vestito da pazzo con robone di tela bianca, cingolo di corda e collare di cartapesta, in piedi, viene appoggiato ad una tavola, sopra un alto sgabello dietro la fontana raffigurante l'Inverno alle Quattro Cantoniere. Lo scartafaccio che tiene in petto pubblica il suo delitto, e la condanna inflittagli dal tribunale per la R. Gran Corte criminale, cioè la relegazione alla Pantelleria per sette anni di penitenza. I boia colle loro divise gli stanno ai fianchi, toccando ogni quarto d'ora la tromba, finchè, durato per tre ore in tale vergogna, viene ricondotto alle regie carceri... Il concorso del popolo è così straordinario che la folla ferma il passo.
Ciò accadeva il 22 luglio 1784.
Le berline si moltiplicavano all'infinito e con forme che tutti conoscevano ed alle quali tutti erano abituati.
Proprio due mesi dopo di questa, altra se ne vedeva nel piano del Monte di Pietà. Il cappellaio Stefano La Manna, vecchio portiere di quello, ne avea fatte tante che la misura era colma. Ultima, avea preso dal Tesoro certi oggetti pegnorati, e come nuovi era andato a pegnorarli per suoi. Una però le paga tutte: e, catturato, veniva esposto alla berlina sopra uno steccato innanzi al palazzo del Monte. Ma avesse, o affettasse indifferenza, egli se la rideva non già sotto i baffi, perchè baffi allora non se ne portava, ma sotto il naso; e quando i due boia, uno di destra e l'altro di sinistra, toccavano a sua marcia vergogna la tromba, egli se la sbirbava chiedendo e sorbendo rinfreschi324.
Altro degli uffici sinistri del carnefice, e questo il più esilarante pel popolo grosso, il bruciamento d'un libro, d'un oggetto, sentenziato contrario alla religione, alla morale, ai ministri, al re. Il più celebre di questi spettacoli fu insieme il più vandalico: lo incendio dei registri dell'Inquisizione, durato tre giorni, nel Piano della Marina per ordine del Caracciolo, gongolante della abolizione.
Ma a quando a quando scenette consimili nel mezzo della Piazza Vigliena, sopra un fonte, o una impalcatura, o sul nudo basolato offrivano divertimento ai monelli con piccole ma vivide fiammate di opere proibite, di ventagli con figure oscene, di legni medicinali sia avariati, sia ritenuti dannosi alla salute.
Poco dopo dei registri del S. Uffizio, sotto il medesimo Caracciolo, seguì l'arsione (1783) di due trattati del celebre giureconsulto messinese Pietro De Gregorio, solo per certi paragrafi contro la regalia ed a favore della potestà baronale in Sicilia325. Condanne come queste partivano sempre dal palazzo vicereale, dove, compiacenti custodi dei regi diritti, i Vicerè asserviti alla Corte di Napoli tonavano contro i diritti del baronaggio, dagli autori siciliani sostenuti e in certi casi interpretati superiori ai regî.
Non meno ridicolo quello d'un opuscolo del canonico catanese Malerba contro i ministri del Governo, venditori di giustizia, e contro i loro assecli, bollati come solenni truffatori; ma più ridicola ancora la pena a lui inflitta, nelle carceri dell'Arcivescovo (5 nov. 1791), quella dei ceppi; laonde il March. Villabianca esclamava indignato: «Questi ministri non si vergognano di esser disonesti, e somigliano a quelle donnacce che si danno, e poi si ribellano quando per poco si dica loro baldracche!»326.
Sullo spirare del secolo, l'a. 1798, una cassa di libri giunti da Venezia con carte giacobinesche, dopo maturo esame del P. Sterzinger incontravano la solita sorte327; ed il 6 aprile 1799, una scena di codesto genere assumeva tutta la pompa del soppresso S. Uffizio. C'era presente P. D'Angelo, il quale, tornando a casa, prendeva quest'appunto: «Si son portati molti libri venuti di fuori Regno, e per ordine del Governo, impediti ad entrare in dogana, son portati alla Piazza Vigliena, ed ivi si son dati alla fiamme a suon di tromba del boia; dopo di che il sac. Arcieri (prete rimasto proverbiale) fece in quel luogo un sermone in cui dimostrò la vanità e la pazzia del secolo creduto illuminato»328.
Trattamento non meno indegno, a ricordo dei nostri vecchi curiali, fu fatto al Codice di Napoleone, del quale Pietro Colletta ebbe ad attestare che «per comodo del Re, fu nella piazza di Palermo [proprio ai Quattro Cantoni] qual sacrilego libro dalla mano del boja lacerato e bruciato»329.
Esecuzioni di giustizia contristavano con frequenza incredibile l'animo dei buoni. Il S. Uffizio diede pure il suo contingente allo spettacolo della morte; ma che cosa fu esso a fronte degli altri tribunali quando l'ultimo auto-da-fè portava la data del 1724? Abolito che fu, la potestà regia, ossia il tribunale di giustizia, rimaneva unico e solo esercente del diritto di opporre la violenza della pena alla violenza del delitto.
Appena fissato il giorno della esecuzione l'Avvocato fiscale (oggi Procuratore del Re) nella G. C. Criminale, o il Capitan Giustiziere nella Corte Capitaniale, ne dava partecipazione al nobile Governatore della Compagnia dei Bianchi e gli rimetteva le chiavi del dammusu, ove stava il condannato. Da quel momento la Compagnia entrava in possesso di lui, e ne avea per tre giorni il governo materiale e spirituale. Nessuna giurisdizione alterava od attenuava la sua; ed il Governatore la esercitava piena, scrupolosa fino nei minimi particolari.
Dall'oscura segreta il reo era dal pietoso Capo di Cappella fatto salire nell'anti-oratorio, ove con tre altri suoi confrati gli apprestava i possibili soccorsi del corpo e dello spirito. Per tre giorni i buoni signori si moltiplicavano per assisterlo a ben morire: e non era in lui desiderio che essi nei limiti della loro facoltà non si affrettassero a soddisfare. A tutto provvedeva di suo quel funzionante Capo, e non solo pel reo, ma anche pei nobili assistenti. I quali, se prima si davano tra loro poche ore di scambio recandosi per brevi riposi fuori la Vicaria, e la sera, finiti gli esercizî spirituali, andavano a svestirsi nella loro Compagnia alla Kalsa, dal 1770, dopo cioè che alcune stanze nuove furono quivi costruite, essi non si staccavano un minuto dal paziente330.
La prima sera che questi entrava in cappella, a due ore di notte (due ore dopo l'Avemmaria) la campana della chiesa degli Agonizzanti dava tanti rintocchi quanti erano i rei da giustiziare; il suono si ripeteva anche la vigilia: ed a quei rintocchi, a quell'ora, specie nelle sere crude d'inverno, ogni persona si faceva il segno della croce, e pensava chi mai potesse essere il disgraziato e per quale delitto condannato. I confrati della congregazione con voce lamentevole andavano questuando per la elemosina delle messe da celebrarsi per l'arma di stu puvireddu.
I tre giorni di preparazione a ben morire sono proverbiali (Li tri ghiorna di cappella, ed anche: Li tri ghiorna di lu 'mpisu) e passavano in continui esercizî di pietà, di preghiera e di religione: lì, nella cappella del Crocifisso, un sacerdote del sodalizio amministrava giorno per giorno i sacramenti: ed il Capo di Cappella scrupolosamente riceveva le confidenze e le dichiarazioni che a sgravio dell'anima sua il reo gli faceva, e che egli religiosamente notava in un registro della Compagnia, il quale va appunto sotto il titolo di Scarichi di coscienza. Nessun occhio profano si posa ora su quel libro, nessuna indiscrezione consente rivelazioni che servano a pascolo di curiosi. Quei registri sono storia di grandi delinquenti, di omicidi forse involontarî, forse di imputati di delitti non commessi. Al momento di presentarsi al tribunale di Dio costoro vollero aprirsi tutti a chi paternamente, amorosamente li assisteva e li consolava, a chi ne condivideva gli affanni e ne tergeva le lagrime331.
E che avranno essi voluto tacere quando non avevano più nulla da sperare, nulla da temere dalla Giustizia umana? Perchè non dire in qual maniera procedettero le cose, e non rivelare circostanze che forse servono di lenimento ai lor cuori esulcerati?
Son le 22½ (un'ora e mezzo prima dell'Avemmaria), ed ogni persona non ha più niente da fare. Il fatale momento è giunto. Un fabbroferraio si affatica a schiodare i ferri dai piedi dell'afflitto, come lo chiamano i Bianchi; il quale si dispone a lasciare il troppo lugubre albergo, la Vicaria, dove non ritornerà mai più.
Domani il vecchio «D. Alfonzo Ruiz de Castro, Alcaide, seu Castellano delle pubbliche carceri del nuovo Edificio di questa Felice e Fedelissima Città di Palermo, del quale è proprietario il Tribunale della R. G. C. Criminale», manderà la solita bolletta di discarico d'un detenuto.
Il vasto Piano della Marina è il posto ordinario, ma non unico, del truce spettacolo, già teatro di raccapriccianti auto-da-fè e di brillanti mostre d'armi, della decapitazione di Andrea Chiaramonte sotto gli occhi di Martino II, e della barbara luminaria dei registri del S. Uffizio, e alla presenza del gongolante Caracciolo, di corse di tori e di splendidi tornei, ed ora di marionette, di carrozze, di oziosi d'ogni genere332.
Sullo Steri (palazzo del S. Uffizio), sventola la bandiera rossa col motto: Discite justitiam, populi. I prigionieri aggrappati alle spranghe della Vicaria, gli ammalati della Infermeria specialmente, fissano atterriti il mare di teste che fluttua irrequieto. Dalle finestre, dalle terrazze, dai tetti, dai cornicioni si affacciano, si protendono, penzolano come grappoli di corpi umani migliaia di persone. I venditori di semi di zucca e di acqua fresca a grande stento si muovono in mezzo alla calca non cessando dal gridare a squarciagola la loro merce.
La inferriata del carcere stride sui cardini e si rinchiude subito alle spalle d'un lugubre corteo. Un improvviso mormorìo generale cresce in frastuono assordante. Algoziri e ministri di giustizia a cavallo, con verghe nelle mani, seguono lentamente, misuratamente il regio stendardo rosso, e precedono la Compagnia dei Bianchi associante il reo, legato sopra un carro. Granatieri con baionetta in canna, o, secondo i tempi, alabardieri e soldati a cavallo, formano steccato e controsteccato impenetrabile alla folla sterminata, che pallida, allibita, ma sempre curiosa, non rinunzia al vecchio spettacolo. Le forche si levano alte in ragione della gravità del delitto. In altioribus furcis, nelle più alte forche, secondo la sentenza, vengono appiccati gli stradarii, i grandi assassini. In altioribus furcis venne strangolata il 5 settembre 1789 la più fredda avvelenatrice del secolo, Anna Bonanno, soprannominata la Vecchia di l'acitu, alle Quattro Cantoniere; in altioribus furcis il parrucchiere Giuseppe Mantelletti, a 19 anni uccisore d'un sacerdote.
L'afflitto ascende la scala del supplizio, e lontano lontano si odono i lenti rintocchi cella chiesa degli Agonizzanti, e vicino vicino quelli della campana maggiore della chiesa di S. Francesco li Chiovara: e tutti, vicini e lontani, invocano la Madonna della Buona Morte, perchè voglia concedere buon passaggio all'anima dello sventurato.
Tamburi e trombe rumoreggiano improvvisamente, incessantemente. Un fremito convulso invade ogni astante: l'umana giustizia è fatta! I Bianchi ginocchioni pregano pel trapassato; il cappellano ne benedice il cadavere, che, non più come per lo addietro, rimane fino a tarda sera, per una giornata, penzoloni, ma vien presto rimosso, e se i delitti non esigano altro, trasportato entro una cassa alla chiesa dei decollati, nel vicolo S. Antoninello lo Sicco, sepoltura ordinaria dei rei di Stato; intanto che la folla superstiziosa si precipita verso la forca, affamata d'un brincello della sozza fune, già diventava prezioso amuleto.
Ben altro però ha da fare il carnefice se il giustiziato è stato un ladrone di campagna.
Per questo malvagio non v'è quartiere d'inverno. L'arbitrio dei giudici tien luogo di legge, sentenziando caso per caso la esemplarità della punizione. Questo solo è certo: che per siffatta gente non vi è pietà: e la sicurezza dello Stato esige le forme anche più disumane di giustizia.
La loro impiccagione ha luogo in varî punti della città, così dentro come fuori, al Piano del Carmine, a quello del Monte, a Porta di Vicari (S. Antonino), a quella di Termini (Garibaldi), a quella di S. Giorgio, fuori Porta Nuova, fuori Porta Montalto: siti di loro nefande geste e quindi di espiazione. Ma tra tutti hanno triste preferenza le Quattro Cantoniere.
I diari palermitani hanno pagine orrende di codesti spettacoli: ma chi scrive quelle pagine rimane impassibile come di cose ordinarie della vita, delle quali non sia quasi da maravigliare. Già si sa: chi ha ucciso in campagna, chi ha assassinato in un posto qualunque, deve esser condotto al supplizio sopra un carro con le mani legate alla coda della mula. Ma fino alla metà del secolo, peggio: veniva sopra una tavola trascinato per terra a coda di cavallo. I suoi avanzi rimanevano pubblico esempio nei luoghi nei quali i suoi misfatti avevano terrorizzato cittadini e campagniuoli. Mani e testa, mozzate alla vista del popolo, chiuse entro gabbie di ferro, venivano attaccate — macabri trofei — agli archi, alle porte della città, ad un bastione, ad un palazzo, alla porta della Vicaria e financo dentro di essa sotto gli occhi dei carcerati. Il corpo, se così voleva la sentenza, squartato e distribuito ai varî paesi che ne reclamavano la triste eredità, poichè ne avean sofferto le geste feroci. I canceddi, bordonari (mulattieri), dentro sacchi trasportavano le infami membra, che andavano a pendere da un albero, da un muro in campagna, a Gibellina, presso il convento di S. Spirito in Palermo, e quasi sempre nel famoso Sperone all'Acqua dei Corsari, ove andavano a compiere la tragedia.
Questa contrada prende nome dai ganci d'una forca in muratura quivi piantata. Il 19 gennaio 1770, venendo per terra da Messina, Brydone, nel vederla scrivea: «Presso alla città (Palermo) passammo per un sito di supplizio, nel quale le membra squartate di un gran numero di ladroni erano appese ad uncini come tanti prosciutti. Ve n'erano di recente suppliziati e offrivano un aspetto molto ributtante. A Palermo, ci fu detto che un uomo con tre altri era stato pochi giorni innanzi catturato, dopo una ostinata resistenza, durante la quale parecchi dei suoi e della giustizia eran caduti, e che egli piuttosto che arrendersi, si era piantata la spada nel petto morendo in sull'istante; gli altri, arresi erano stati impiccati333».
Una ventina d'anni dopo lo scellerato arnese veniva demolito, ed il Villabianca scriveva (maggio, 1798): «La forca fatta di fabbrica per pianca (beccheria) di carne umana è nella via pubblica di mare conducente a Bagheria. Viene spiantata in questo maggio: alzata nel 1500, mostra di vendetta, di giustizia, terrore dei malviventi del Regno. Ma poichè le giustizie oggi si eseguono nei luoghi dei delitti, restando così noto a tutti l'atto capitale che per l'avanti era ignoto a moltissimi, questo segno mortifero venne tolto. La vista di cosce, di braccia ecc., pendenti dagli uncini, le ossa ammucchiate nel pozzanghero di essa pianca recava[no] orrore ai passeggieri, specialmente alla Nobiltà, che si recava a Bagheria. Di notte la mente funestata da quelle viste, provava pene indicibili. Fin dal 1604 con lo sperone era una piramidetta con iscrizione oggi scomparsa»334.
Se col secolo volgente alla sua fine lo Sperone veniva demolito, le cose rimanevano le stesse. Al 5 maggio del 1791 a Porta S. Giorgio eran rizzate le forche: e due aridarii in campis vi eran trasportati mezzo ignudi su carri tirati da buoi. Strangolati, ai loro corpi venivano spiccate mani e teste e appese all'arco della porta, ove rimanevano ingabbiate fin dopo la rivoluzione del 1848; e le membra squartate, a Sampolo, ai Colli, a Porta di ferro sotto Bagheria, alle Torri di Termini, terrore dei passeggieri.
Scene orribili come questa si ripetevano per altri simili delinquenti anche allo spirare del secolo. I giudici, in ciò inesorabili, facevan pagare occhio per occhio, dente per dente. Il 27 settembre del 1798 Raffaele Grillo da Racalmuto, legato come di consueto sopra un carrozzone da buoi, seminudo, veniva senz'altro afforcato; indi trasportato dai boia alla casa della Vicaria, tagliato in sei pezzi, fatti appendere qua e là alle cime degli alberi nei passi delle portelle e nelle gole dei monti335.
Dai capi attaccati a ragione di esempio prende nome il Ponte delle Teste sul fiume Oreto, ove, crani spolpati e bianchi, fino a mezzo il secolo XIX, si vedevan sospesi ad una piramide336. E ve n'erano, come abbiam detto337, anche al Palazzo pretorio, avanzo di casieri ladri, i quali pagarono sul patibolo il danaro mal tolto in un tempo, in cui i fallimenti dolosi non si chiamavano apropriazioni indebite, ed i furti del pubblico erario venivano puniti non con pochi anni di carcere, a pasticcini, ma con la condanna nelle galere dello Stato a vogare per tutta la vita.
Nè ancor pago, a perpetua infamia dei rei, o a trofeo della famiglia, Andreotto Abbate faceva murare sulla facciata della casa sua, che fu poi di G. C. Imperatore, rimpetto a Porta Felice, due maschere in tufo calcare dei felloni chiaramontani, non essendosi potuto conservare le teste di carne e di ossa per lungo tempo quivi esposte. Fasti non invidiabili, questi, che il Marchese Villabianca nel 1777 consacrava nella sua palazzina di Piedigrotta col mascherone di Mariano Rubbioni, capo popolo nella sollevazione di G. D'Alessi, ucciso da un antenato di esso Villabianca.
La pena di Morte variava nella forma secondo che il delinquente fosse plebeo, nobile o civile. La forca era per la bassa gente, e perciò l'odioso motto: La furca è pi lu poviru; pel nobile, la decapitazione, che era molto rara, more nobilium; e quando la sentenza voleva essere più che severa, non potendosi togliere il privilegio della decapitazione, toglievasi quello dei distintivi. Decapitetur absque pompa, decretava la Gran Corte il 2 settembre del 1771, dopo 82 anni di una pena simile (1689), nel condannare a morte Francesco Paolo Carnazza dei baroni Piscopo, da Castrogiovanni, giovane non ancora diciannovenne, imparentato con molte famiglie patrizie di Palermo; perchè la pompa era un distintivo al quale non si rinunziava dai parenti. E non era egli un distintivo quello di mangiare in un servizio d'argento? di dormire sopra un materassino invece che sulla nuda jittena, giacitoio di pietra? di uscire dal Castello invece che dalla Vicaria? di portare agli occhi la benda di seta bianca invece che quella di cotone? Il suo costume peraltro era un distintivo esso stesso: giamberga, calzoni, scarpe nè più nè meno che usava l'alto ceto: costume lì per lì improvvisato appositamente da un sarto; la sola differenza, il nero imposto dal caso.
La distinzione si estendeva anche al palco, addobbato con panni neri trinati d'oro, messo in iscena con vasi d'argento e servitori in livree di lutto. Essi, non il boia, potevano raccogliere la testa rotolante nel tinozzo; ma le loro mani dovevano esser coperte di guanti: distinzione eccezionalmente concessa (1789) al benamato paggio del Vicerè Caramanico. La quale provocò mormorazioni di coloro che sostenevano non potersi applicare il taglione a chi pei suoi natali meritava il capestro; e, data pure la piacenteria dei giudici, non doversi permettere un paggio inguantato preso alle Quattro Cantoniere, ma il boia comune con le mani nude e sordide338.
Ultime distinzioni: la sepoltura ad libitum dei parenti ed i pubblici funerali.
Gli è vero che tutto questo cerimoniale, diciamolo così, imponeva regali a destra ed a sinistra ai carcerieri, ai carnefici, ai paggi, in ragione del grado nobiliare e delle condizioni economiche del condannato: ma la spesa d'un migliaio di scudi soddisfaceva l'amor proprio della famiglia, che sapeva non esser andato il suo caro a morte come un volgare malfattore.
Altra forma di supplizio, la fucilazione; ma non ne troviamo se non un solo esempio, l'anno 1796, in persona di due militari, e non più. Il militare, napoletano o straniero, andava accomunato all'ordinario delinquente nella pena infamante della forca. Una volta un soldato del Reggimento estero sassone, reo d'omicidio, non si poteva giustiziare senza il boia pratico; ma questo avea dei conti da fare col Tribunale ed era sotto processo. E allora lo si prese entro sedia volante e, accompagnato alla sua volta dai birri, si portò a compiere il suo ufficio nel piano di S.a Teresa e quindi si riportò in carcere339.
La stranezza delle contraddizioni non potrebbe raggiungere colmo maggiore.
Ciò avveniva il 5 gennaio 1797: e l'anno, aperto in così triste maniera nella milizia estera, si chiudeva peggio nella nostrale. Il 14 dicembre due soldati palermitani del Reggimento reale di Palermo, venivano impiccati fuori Porta S. Giorgio concedendosi un premio speciale agli esecutori.
Passiamo ora alla liberazione da morte.
Il privilegio di grazia era dalla nobile Compagnia dei Bianchi esercitato con alto sentimento di umanità e con piena coscienza d'un diritto devoluto al Capo supremo dello Stato.
Il Governatore del pio istituto all'appressarsi della Settimana Santa mandava al Vicerè il nome del condannato da graziarsi. Il Vicerè approvava, e la grazia era fatta.
Accadeva che i condannati fossero più d'uno e talora tanti che la Compagnia restava imbarazzata nella scelta. Le preghiere, le suppliche, gli scongiuri, le alte e le basse influenze si moltiplicarono, si milliplicavano. Trattavasi di vita: e nessun mezzo si lasciava intentato per salvarla a chi era in pericolo di averla troncata.
L'anno 1777 i condannati a morte eran dieci, ed il graziando doveva essere uno. Per uscire di impaccio e liberarsi dalla persecuzione dei supplicanti il Governatore dei Bianchi che fa? imbussola i dieci condannati e ne estrae a sorte uno: questo fortunato era un uxoricida: Giovanni Di Pietro palermitano340. Ordinariamente però la Compagnia presentava una terna di nomi: ed il Vicerè decideva; ma nè la Compagnia poteva chiedere secondo la primitiva concessione del privilegio di Filippo II (1580), nè il Vicerè si permetteva concedere la grazia ad uno scorridore di campagna.
Il Caracciolo infirmava nel 1782 il secolare privilegio: la grazia pasquale non avea luogo, ritenuta abolita pel Caracciolo, sospesa pei Bianchi, i quali se ne richiamavano al Re. In agosto una donna da giustiziarsi veniva graziata in virtù del contrastato privilegio. Giungeva il Venerdì Santo, ed il pubblico correva come a festa allo spettacolo. Tra il sì ed il no, passarono quasi vent'anni senza che un rescritto sovrano troncasse la grave questione. Finalmente il 16 aprile del 1800 il Re con grande soddisfazione di tutti reintegrava nell'antico privilegio la Compagnia341.
Se al lettore non rincresce, noi passiamo a descrivere la pietosa funzione della grazia.
Il condannato a cui era toccata la sorte della vita veniva estratto di buon'ora dalle segrete; dai nobili a ciò designati gli si lavavano i piedi, gli si indossava un camice bianco; lo si preparava alla comparsa.
Siccome tra gentili alme si suole,
la Compagnia dei Bianchi era in buone relazioni di vicinato con quelle della Pace e della Carità, nobili entrambe. I confrati di queste erano in parte confrati di quella. In omaggio a cosiffatte relazioni, esse coglievano qualche solenne occasione per darsi pubblici attestati di stima. Quale occasione più acconcia di questa a fare onore a sodalizî che s'intitolavano dalla Pace e dalla Carità e che l'esercizio dell'una e dell'altra avevano per loro istituto? Ed i Bianchi invitavano i nobili confrati a condividere con loro la vestizione del graziando: e l'invito veniva cortesemente e con soddisfazione tenuto.
Giunta l'ora solita della giustizia, la Compagnia moveva dal carcere conducendo il reo, facile a conoscersi pel suo speciale costume e per la gran torcia che recava in mano. Recto tramite tutti si avviavano al luogo del supplizio, dove il Governatore faceva girare al graziato il palco della mannaia, o facevalo passare sotto le forche, baciandole, secondo che egli fosse condannato a questa o a quella maniera di supplizio. Quale impressione dovesse provare costui, immagini il lettore; certo però che «poco è più morte».
Nel Piano della Marina fermavasi la immancabile popolazione; e quando il graziato, come di frequente accadeva, era delle classi superiori, giacchè il giustiziando del ceto elevato era sempre preferito da questo, signori e civili prevalevano tra gli spettatori. Il 23 marzo del 1769 (citiamo un fatto caratteristico, benchè non vicino alla fine del secolo) «comparì — dice il Villabianca — l'aggraziato Guzzardi vestito di bianco in drappi di seta con una veste e mantellina bianca regalatagli dal Superiore Chacon».
Il lettore comprende subito la distinzione del costume in seta da quello in cotone onde apparisce il plebeo; e ricorderà la benda, egualmente di seta bianca, con la quale i Bianchi coprivano gli occhi dell'uomo da decapitarsi diversa da quella di cotone o di lino del plebeo da impiccarsi.
«La folla del popolo fu straordinaria, e vi fu anche folla di dame e cavalieri per la curiosità di vedere un nobile lor parente sotto il peso di questa disgrazia»342.
Guardando da una finestra dell'albergo di Madama Montaigne, W. Goethe vide il dì 13 aprile del 1787 uno di questi graziati. La impressione che ne riportò non fu favorevole. Ott'anni dopo, il 20 maggio del 1795, passando dal Piano di S.a Teresa, Hager vide per caso decapitare F. P. Di Blasi: e ne restò penosamente colpito. Il futuro autore del Faust parve sorridere della toletta del graziato; il giudice dell'impostore Vella si rammaricò del giustiziato: entrambi visitatori della Città e in molte cose di un medesimo parere. Ma il secondo era ignaro delle impressioni del primo, la cui Italianische Reise, venuta in luce solo nel 1816343, egli, spigliato scrittore dei Gemälde von Palermo, non potea conoscere, pure incontrandosi in molti punti con essa.
Pazienti ricerche sopra un manoscritto che fu del celebre Gabriele Castelli Principe di Torremuzza e sopra un altro della Compagnia dei Bianchi344; notizie attinte a diarî e cronache mss. ed a pubblicazioni del tempo e sul tempo, ci mettono in grado di fornire la dolorosa statistica delle esecuzioni capitali di Palermo in meno di mezzo secolo.
Dal 1752 al 1800, raggiungono la cifra di 160. E non son tutte!
La Compagnia dei Bianchi fin dal 1580 godeva, come abbiam detto, il privilegio di una grazia annuale; privilegio che per 48 anni salvò quarantotto condannati. In uno dei dodici parti della fecondissima Maria Carolina, quello cioè del 1773 (Maria Luisa, che poi fu moglie di Ferdinando Granduca di Toscana) veniva graziato il giustiziando più vicino. Il dì 27 settembre 1800 il Re tornando da una gita in Bagheria e sboccando con la sua carrozza nel Piano della Marina, trovava, senza aspettarselo, un reo in procinto di essere afforcato. Beato sovrano, che poteva dimenticare una sentenza di morte da lui soscritta, e godersi una partita di caccia mentre un suo suddito agonizzava all'imminente supplizio!... La folla grida ad alte voci: Grazia, Maestà! ed egli sorpreso, assordato, confuso, con un cenno della mano concede, e pel Cassaro si affretta verso il Palazzo.
Queste cinquanta mancate esecuzioni, aggiunte alle 160, portano la somma spaventevole di 210 condanne capitali, che per 48 anni costituiscono una media biennale di nove circa, poco più che quattro all'anno.
Riducendo di quasi un terzo, cioè a trentuno, i quarant'otto anni, dal 1753 al 1783, e non contando le condanne, del resto scarse, di militari, abbiamo, peggio ancora, 147 esecuzioni con 32 grazie (una pel ricordato parto della Regina, 31 per la consueta annuale grazia dei Bianchi) e quindi 178 giustizie tra eseguite e graziate, con una media di 6 all'anno.
Nè pel viceregno del Caracciolo mutavan le cose, poichè con lui, abolitore della Inquisizione, le scene di sangue in tutte le forme legali proseguirono come prima: e se mancarono nel 1784, mancarono anche negli anni posteriori alla sua partenza ed erano mancate anche prima. Da quell'anno al 1800 la media delle esecuzioni scese: e vi furono anni che si sottrassero alle ordinarie ferali contribuzioni.
Ma ahimè! Quel che mancò pei delitti comuni venne qualche volta dato dai delitti politici e militari. Mentre le tabelle di assistenza dei Bianchi son vuote per gli anni 1787, 1793, 1796, 1799, si dibattevano sulle forche ora due soldati francesi (1787-1793), ora un soldato veneziano (1796), ora il portabandiera del Duca Oneto, Salv. Rubino; ed il tenente napoletano de Losa assiste per la prima ed unica volta in un secolo alla fucilazione di due militari stranieri ai servizi del Re (1796)345.
Il terrore del Giacobinismo prende luogo di salvatore delle istituzioni!
Dopo ciò, quali malinconiche riflessioni vengono a turbare il nostro spirito! Tanti rigori di carceri correggevano essi i delinquenti che n'eran vittima?
Risponda per noi l'amaro canto popolare del dolore:
Cu' dici mali di la Vicaria,Cci facissi la facci feddi feddi;Cu' dici ca la càrzara castia,Comu vi nni 'ngannati, puvireddi!La càrzara è violu chi vi 'nvia,Chi vi 'nsigna li strati e li purteddi346.
Tanta efferatezza di sentenze e di esecuzioni diminuì essa il numero dei delitti più atroci di sangue?
Il Marchese Villabianca in un momento di resipiscenza disse che «con questo patibolo, cioè colla morte di capestro, si ci hanno accomunato i popoli e appena ci hanno avversione», e precorreva all'aguzzino mangia-liberali del Congresso de' birri del Giusti: osservando che «vi muoiono specialmente i plebei ben sazii, bene assistiti nell'anima a segno che tali ignoranti vengono a sospirarne le pene»; ma egli scantonava come un avversario di Cesare Beccaria, e non se la intendeva col suo amico Tommaso Natale, quando affermava che le giustizie a base di sangue «fanno oh quanto più impressione che non fa la forca!»347.
Proprio il contrario di quello che insegna il diritto penale moderno!
CAP. XIX.
I GIORNALI E LA PUBBLICITÀ.
Il giornale politico quale lo intendiamo oggi non esisteva348, ed è tale la differenza che corre tra questo e quello, che ad un paragone manca qualunque termine, salvo che quello del nome: nome, com'è facile comprendere, generico, perchè qualunque titolo esso portasse era sempre e comunemente inteso gazzetta o foglio349. Gazzettieri erano chiamati i giornalisti: e spesso filosofi e politici quelli che vi discutevan sopra o ne professavano le opinioni e le idee.
Forma e sostanza non avevano nulla di simile. Il giornale era in ottavo a due colonne con una testata di piccoli tipi, a forma di libro. A vederne uno oggi, si crederebbe ad un foglio di stampa di un'opera; mentre l'amatore ha di fronte una ghiotta curiosità bibliografica.
Nel contenuto poi era un semplice notiziario generale notizie stantie di un mese, due, secondo le contrade e le distanze, sì che quando esse giungevano, le cose potevano aver mutato aspetto; perchè, degno di attenzione, le notizie erano più di fuori che di dentro la Sicilia.
Di titoli suggestivi, piccanti, come quelli che la partigianeria, la scrocconeria, la malvagità dovea inventare un secolo dopo, neppur l'ombra. La gazzetta poteva sostenere, anzi sosteneva, le parti del Governo, ma non era fatta per solleticare col minaccioso nome i cercatori di scandali, per intimorire chi dalle rivelazioni d'un foglio potesse veder gettata fosca luce sulle proprie opere, o perpetrati ricatti. Gli uomini non eran da ciò, e la legge non avea ancora trovato ragione di colpire così raffinata maniera di corruzione.
Dei fogli usciti nella seconda metà del settecento, nessuno era giornaliero. Uno solo eccettuato, il quale usciva due volte la settimana e visse oltre una dozzina d'anni; tutti gli altri erano eddomadarî e non superarono i tre anni di vita.
Il più notevole, anche per un po' d'interesse che prendeva delle cose della Capitale, fu quello delle Novelle Miscellanee di Sicilia, cominciato il 20 luglio de 1764 e cessato il 28 agosto del 1767. Esso però è fuori del periodo delle nostre ricerche, ed è da metter da parte come Il Nuovo Postiglione degli anni 1771-72, il quale farebbe supporre un Postiglione precedente, da non confondersi con l'epistolario di S. Francesco di Paola.
Per un ventennio infatti non si parlò più di giornali.
Ed ecco la Raccolta di notizie, gazzetta lungamente e vigorosamente vissuta, e forse la sola sopravvissuta ad altre che con essa e prima e poi poterono esistere.
Stampata da D. Pietro Solli, per tredici anni (1793-1805) se non più, apparve ogni Martedì e Venerdì con uniformità e inalterabilità impassibile. Interi anni l'Isola nostra non esistette per essa. A ben altro che alla Sicilia essa guardava. C'era Livorno, centro di corrieri; c'era Napoli, con Ferdinando; Madrid, con Carlo III; Vienna, alla quale pensava sempre la figliuola di Maria Teresa, Carolina; c'era Francoforte, Londra, e quella Parigi che figurava come oggetto di curiosità timorosa e di non celata avversione. Nessuno dell'infima classe sociale sapeva della gazzetta, ma molto la nobile e un poco la civile e molti partecipavano all'odio pei Francesi dell'89 e del 93, le geste dei quali, per vie dirette e indirette, giungevano col marchio della ribellione a Dio e al Re. Attraverso ai cento e più numeri annuali della Raccolta, si potevan seguire le evoluzioni degli stati, le vicende delle corti d'Europa, ma non trovarvi una parola ch'escisse dalla misura, un'aspirazione anche tacita a principî di libertà. Man mano che ci allontaniamo dal 1793, il giacobinismo è per la Raccolta il nome più triste, l'associazione più pericolosa. La umana miseria non tangeva la Raccolta: e se in essa la Sicilia cominciava a figurare per qualche ricordino, ciò era solo quando, fuggiaschi da Napoli (26 dicembre 1798), giungevano i sovrani, quando essi recavansi a S. Francesco, o tenevano cappella reale a Casa Professa (Cattedrale provvisoria) e baciamano al regio Palazzo, o quando assistevano ad una processione, ovvero quando la Regina visitava i monasteri ed il Re andava a fare una partita di caccia o di pesca. Ma la casa nostra non c'entrava mai. Per poco men che tre lustri quel giornale rimase cristallizzato, e lo si vide tale nel morire quale sul nascere, assiso tra due secoli, senza un fremito di gioia allo spuntare del nuovo, senza un rimpianto per lo sparire del vecchio.
Pure ad una osservazione del tutto moderna si presta questo tredicenne arcavolo di centinaia e centinaia di pronipoti, nati nel sec. XIX e vissuti chi la vita di uno o più anni, e chi la vita di un giorno solo: la pubblicità. Se la réclame è un avviso, spesso ciarlatanesco, per chiamar l'attenzione della gente su cose commerciali, per farsi nome o per altro, la Raccolta di notizie ne porta la prima radice in Sicilia. Alla fine di qualche numero, era ogni tanto un annunzio. Ora chiamavano avventori alle loro botteghe i librai; ora i mercanti partecipavano l'arrivo da Marsiglia di una partita di eccellenti bastoni di tabacco di nuova fabbrica ad onza una il bastone del peso di rotoli due e mezzo l'uno, e cristallame, e frumento.
Originale questo avviso del 26 marzo: «Si è perduta una borsa con monete d'argento, cinque once, un gigliato fiorentino, altro simile da tre, e un'ottava di doppia di Spagna. Chi l'avesse trovata, la porti al p. Preposito del Monastero dei Teatini della Catena (attuale R. Archivio di Stato), che gli saranno regalati quaranta tarì.» Avviso ingenuo, perchè della Raccolta pochi sapevano, e chi avea trovata la borsa poteva bene serbarla pei suoi bisogni.
La réclame è in embrione, modesta, misurata, nè spropositata come quella strepitosa fin de siècle di Bisleri, che il suo ferro-china digestivo stomachico, annunzia stomatico, che è quanto dire di bocca.
Ma la vera réclame si ha nel Giornale di Commercio. Principiato il dì 7 aprile, questo periodico continuò di Lunedì in Lunedì fino al 28 luglio 1794, che fu il 17º numero. Costava, come di consueto, 5 grani il numero, un tarì il mese per gli associati. Avea il solito formato in-4º a due colonne, ma la pagina non era più grande dell'ottavo ordinario.
Primo e forse unico modello di giornale locale, diverso da quanti n'erano sorti prima e dalla contemporanea Raccolta di notizie, questo foglio aprì diciassette rubriche, sotto le quali apprestava «le novità confacenti».
Date le difficoltà d'allora, non si poteva compilare diario più rispondente allo scopo pel quale esso era venuto fuori. Vero cimelio giornalistico, esso andrebbe attentamente svolto.
Avete bisogno di persone di servizio? c'è «un giovane che vorrebbe impiegarsi per cameriere e sa far la barba e pettinare da uomo e da donna». La pettinatura era uno degli affari più gravi della vita ed i peli rappresentavano travi. «Mariano Tusa, nella Piazza Bologni, sopra la bottega del parrucchiere collaterale alla chiesa del Carmine (Posta d'oggi), vende due segreti di due semplici erbe per far crescere capelli e per far cadere peli» (n. 1).
«Una persona di abilità e che sa pettinare e far la barba vorrebbe impiegarsi come cameriere in qualche nobile casa» (n. 4).
«Un prete palermitano cerca d'impiegarsi come ajo» (n. 2). E s'impiega.
Avete denaro da spendere? Tenete a mente le offerte di portantine, di carrozze, di mobili, di montres d'oro alla francese.
Un giorno se ne smarrisce una di sommo valore e per ricuperarla vien fuori il seguente avviso: «S'è perduta una mostra d'oro montata alla francese, a quattro quadranti; dei quali quello che denota li giorni del mese, ha li numeri scritti in oro sopra una striscia blò: come lo sono quelli dell'altro quadrante che mostra le ore ed i minuti, e che ha tutti li numeri in cifre. Tiene annessa una catena d'oro di Napoli, nel di cui centro è dipinto un bastimento in un ovale che comparisce da ambedue le parti sotto cristallo, e vi è pure appesa la chiave d'oro. A chi la porterà, anche per via di confessione, all'oriuolajo sotto la casa del Sig. Marchese di Geraci, saranno date once quattro di mancia».
Di siffatte preziosità, che ora farebbero perdere la testa ai commercianti di cose antiche, se ne vendeva spesso. Ora una «scarabattola (scaffarrata) di tartaruga rappresentante la nascita di N. S. Le figurine son di cera ed è fornita di diversi pezzi di argento filato, il di cui peso sormonta la valuta di onze 7». Ora quadri sopra pietra, sopra rame, con cornici di tartaruga e di argento, ed uno «di Matteo Stoma (= Stomer) rappresentante la negazione di S. Pietro a lume di notte, offerto dal pittore D. Giuseppe Velasques». Ora crocifissi di corallo rosso delicatamente scolpiti e smaltati, e scatole di lapislazzoli legate in oro, e diamanti, e pietre preziose, e perle orientali del peso complessivo di oncia una e mezza circa, e due lumiere di cristallo ad otto braccia della Casa Monteleone, e un fornimento guernito di rame per una muta ad otto cavalli. Merce speciosa: «un libro di tavole numeriche relative al giuoco del Lotto», il quale, passato già nel Palazzo della Inquisizione (1786) e poi (1799) all'Università degli studî, dentro il Collegio degli espulsi Gesuiti, era in grande favore350.
Il Giorn. di Commercio finì per extinctionem caloris, cioè per mancanza di annunzî; talchè negli ultimi numeri le rubriche erano ridotte a sei, sette, e la materia non bastava più a riempire le quattro, od anche le tre pagine. Che cosa era avvenuto? era avvenuto questo: il paese non adusato a giornali, non ne prendeva l'associazione, anche perchè il G. di Commercio era troppo speciale, e non si occupava per nulla del mondo come avrebbe dovuto ogni foglio, e come purtroppo faceva la Raccolta di notizie. Laonde il Direttore trasformavalo in Giornale di Sicilia, e nel medesimo formato e carattere lo continuava con idee più larghe e con vedute più pratiche.
Fino al n. 36, corrispondente al 7 aprile 1795, il Giorn. di Sicilia continuava apprestando volta per volta articoli quasi sempre senza titoli, spesso in forma epistolare, di letteratura, di archeologia, di agricoltura, di argomento siciliano o con applicazioni alla Sicilia, e di chirurgia ed astronomia. Questi articoli erano la maggior parte anonimi e della brevità di una, due colonnette, sovente per mancanza di spazio interrotti da un brusco: sarà continuato. Vi collaboravano i migliori scrittori del tempo: P. Balsamo, G. Piazzi, F. Chiarelli. A questi articoli si accompagnavano e seguivano ora sì ora no brevi appunti su pubblicazioni recenti, avvisi di adunanze dell'Accademia del Buon Gusto, della Accademia di Storia siciliana, notizie di alte o nuove operazioni chirurgiche in Città, della Amministrazione della Giustizia, del Comune ecc. Quando il Vicerè Caramanico guariva della grave malattia onde era stato travagliato, gli faceva una gran festa; quando, l'anno seguente, nel 1795, moriva, un gran corrotto.
Nel n. 26, sotto la data del 27 gennaio 1795, il Giornale, scarseggiando di notizie all'uopo e volendo allargare i confini di esse, faceva alcuni quesiti, pregando di risposta i corrispondenti. Chiedeva da loro, almeno ogni mese, una lettera, nella quale fosse un ragguaglio: «1º Dell'apparenza e quantità dei seminati di quel territorio e delle vicine campagne. — 2º Dei prezzi correnti del grano, dell'orzo, delle fave, del cacio, dell'olio, del vino e di ogni altra mercantevole derrata. — 3º Delle principali e più interessanti circostanze della stagione, avvisando, se dentro il mese il tempo sia stato notabilmente piovoso, o asciutto, freddo, o caldo, nebbioso, nevoso, accompagnato da forti venti, o da violenti tempeste, della cui natura ed effetto» avrebbe gradito «una minuta descrizione, come delle alluvioni e dei traboccamenti di fiumi e torrenti.»
Chiedeva, inoltre, appunti intorno la «Storia naturale, le varie e singolari terre, o crete, o pietre, i varj bitumi, le varie acque minerali ecc., piante rare; quali le maniere di coltivare le terre che con particolare e considerevole profitto in quel territorio si praticassero». In altro ordine di vita, domandava «avviso degli omicidj, dei furti strepitosi, o altri gravi delitti, che accadessero in quello e nei vicini paesi. Altresì di ogni altro avvenimento che credesse il sig. Corrispondente interessare la pubblica curiosità ed utilità: sia che esso riguardi le lettere, l'agricoltura, le arti, il commercio ed i costumi di quella e delle finitime popolazioni.»
E conchiudeva imponendosi ogni riserbo sui nomi dei corrispondenti.
Questa circolare confermava ed allargava il programma del giornale: programma pratico e veramente utile al pubblico. Rilievo poi del quale i giornali moderni dovrebbero per debito di giustizia far ragione a questo che è dei più antichi, è la Cronaca siciliana, entrata nei principali giornali di oggi, solo dopo un secolo dalla comparsa del diario del quale diciamo.
Questo Giornale di Sicilia, a chi potesse oggi esaminarlo, parrà o una gran cosa o un'assai piccola e meschina cosa, secondo che si guardi con la conoscenza dei tempi e del paese o con le idee dei giorni nostri. Gran cosa, giacchè nulla di simile s'era tentato fino allora, che si occupasse della cultura dell'Isola. V'era bensì, come diremo, qualche periodico letterario; ma questo sapeva troppo di erudizione perchè si dedicasse alla letteratura spicciola, e troppo grave perchè potesse andare per le mani di molti; e poi costava tre, quattro volte il Giornale di Sicilia, che si pagava nove tarì (L. 3,82).
La stampa non era quindi solo politica e commerciale. Lettere, arti, discipline ecclesiastiche offrivano argomento di disquisizioni e di ricerche illustrative, non anonime come i giornali politici, ma soscritte dai più lodati uomini del tempo. E qui, dove apparvero le Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia e le Notizie de' Letterati, e fino al 1778 venti volumi di Opuscoli di autori siciliani; ad imitazione o continuazione di questi, dal 1778 al 1797, si arricchì il tesoro degli studî storici con altri nove, oltre che di una Nuova Raccolta di Opuscoli di autori siciliani.
Ad una serie di Notizie de' letterati, con estratti e giudizi delle opere più pregevoli del tempo (1772) si eran prestate le stampe del Rapetti; ma dopo un anno non c'eran più. La medesima sorte incontrò il Giornale Ecclesiastico di Salv. M. Di Blasi, il quale venne componendovi una «Scelta di vari opuscoli appartenenti agli studi sacri», estratti dal giornale dell'abate Dinouart. La materia fu composta in due tomi e lasciò di sè ricordo buono nel clero, ma non efficace tanto da determinare alcuno ad imitarlo e seguirlo. E se vent'anni dopo, nel 1793, il parroco Giuseppe Logoteta da Siracusa volle farlo rivivere, se lo vide morir subito fra le mani, al primo tomo, senza gloria e senza pianto.
La Conversazione Istruttiva, foglio interessante, fu il più piccolo formato dei suoi confratelli vecchi e nuovi, uscito tra il 7 gennaio ed il 7 aprile 1792.
Semplicissima la compilazione: un dialogo tra «Dama, Cavaliere, Medico, Avvocato, Filosofo, Abbate»: sei personaggi per sei tipi del tempo. Quattordici i numeri del periodico, quattordici i dialoghi, occupanti sempre o quasi sempre tutte le otto paginette, all'ultima delle quali era fatta la grazia d'una breve notizia di agricoltura, un appunto, o un consiglio di medicina. Se non che, gli apparenti quattordici dialoghi si riducevano a un solo, interrotto alla fine d'un numero e ripreso in principio d'un altro: dialogo lunghissimo, che solo gl'intervalli di una settimana potevano far digerire.
La dama era il perno della conversazione, nella cui casa questa si svolgeva: una dama che leggeva Fontenelle ed Algarotti, e cercava di coltivare la mente come facevano alcune del suo grado. Il cavaliere era un partigiano accanito del patriziato; il medico, un conoscitore del magnetismo in voga, uno spregiudicato giudice di Mesmer e di Cagliostro, un fanatico nemico dei sistemi che i clinici dotti ed i mediconzoli ignoranti si palleggiavano, un medico di una certa cultura, che di tutto discorreva un poco: di fisio-chimica, di anatomia, di malattie correnti e fin di quelle febbri putride che dominavano in Sicilia mentre egli settimanalmente chiacchierava, e che dominarono ancora dell'altro ed infierirono nell'anno seguente. Il filosofo, un severo censore della vita e dell'educazione contemporanea, mezzo scettico, mezzo platonico, panegirista della morale e della virtù. L'avvocato scodellava le sue cognizioni di giurisprudenza con le medesime lungherie del filosofo e del medico: e l'abate, un sacerdote poco untuoso, anzi un poco fervoroso ecclesiastico. Larghe e particolareggiate le notizie di Cagliostro (nn. 5-6).
Giungevano gli ultimi giorni di Carnevale e la Conversazione lasciava per la storia del Carnevale il famoso massone, che ripigliava in quaresima (n. 8) con una sfuriata contro tutti i cagliostri e le cagliostrate della società.
Gli ultimi due numeri alludevano alla Regina, additata come modello di madre!
Tra' consigli medici, ameno questo: «In gennaro senza necessità assoluta non si deve cavar sangue. Si deve usare vino bianco e delicato. Non si devono mangiare cose salse, non lavare il capo; usare spesso il miele rosato, i pomi freschi, e le mattine a digiuno si può pratticare il pepe pesto. Si dee guardare di andare fuor di casa e stare al più che si può lungi dal medico, e vicino ai cuochi» (n. 4).
CAP. XX.
IL CONTE CAGLIOSTRO.
Mentre questi fatti di vita ordinaria si svolgevano tra noi, altri straordinarî e clamorosi ne avvenivano fuori per opera ed in persona d'un siciliano: Giuseppe Balsamo, che delle sue strepitose geste riempiva l'Europa tutta.
«Giuseppe Balsamo!... chi era costui?» potrebbe chiedersi con D. Abbondio del Manzoni il lettore non bene informato: e noi lo toglieremo di dubbio aggiungendo che Giuseppe Balsamo era il Conte Cagliostro.
La celebrità del personaggio ci dispensa da una presentazione in regola; ma il lettore, che forse anzi senza forse lo conosce con questo nome di guerra all'Estero, non saprà ciò che egli da semplice Balsamo fece in Palermo: e se così è, qualche cosa giova pur dirne, se non altro perchè dal fanciullo si giudichi il giovane e dal giovane l'uomo.
Quando le prime vaghe notizie del futuro Cagliostro cominciarono a giungere nell'Isola, tutti sapevano delle prime capestrerie di Peppino Balsamo. E come ignorarle se la madre di lui, D.a Felice Bracconeri, in compagnia della figliuola Giovanna, nella recondita via della Perciata a Ballarò, era di continuo commiserata dalle comari del vicinato, e nota agli abitanti dell'Albergaria?
La fuga dal Seminario di S. Rocco, nel quale avealo collocato lo zio materno Matteo, non era un mistero per nessuno. Bisognava chiudere gli occhi per non vedere le sue monellerie, turarsi le orecchie per non sentire le sgridate giornaliere della povera mamma.
Affidato poi al P. Generale dei Benfratelli e condotto da lui a Caltagirone, Peppino vi avea vestito l'abito di novizio (ricordiamoci che si era al tempo in cui i voti monastici si professavano a 16 anni); ma buttato poco dopo il collare sopra un fico, se n'era tornato bel bello a casa come se nulla fosse stato. — «Che hai fatto?...» gli aveva chiesto dolorosamente sorpresa la madre. — «Oh che volete che facessi?! rispondeva; se tutta la giornata lavoravo come un cane ad aiutare l'aromatario, ad assistere gli ammalati, ad imparar la medicina?... E vi par piccola pena quella di leggere sempre a refettorio la vita dei santi?...» Ma i padri Benfratelli, la Casa dei quali era di fronte alla Perciata, raccontavano cose d'inferno del tristanzuolo, e fra le altre questa: che leggendo appunto, secondo le regole dei religiosi, il leggendario dei santi, ai nomi delle sante vergini avea più volte in pieno refettorio sostituito nomi di donne pubbliche di Palermo!
Tant'è: ritornato in patria, qualche occupazione doveva egli procurarsela: e se la procurava accompagnandosi coi monelli di Ballarò o buttandosi a capofitto in mezzo a tutte le brighe degli scavezzacolli suoi pari. Quando incontrava birri a condurre carcerati, era per lui una vera festa lo slanciarsi loro addosso per liberare la preda. Gli atti di ribellione alla forza pubblica avevano in lui la maggiore attrattiva, in lui, nato e cresciuto nel quartiere più rissoso della Città, ed alle risse per indole inclinato.
Lo zio Matteo Bracconeri cercava tirarlo a buona strada: ma tutt'altro che rallegrarsi poteva dell'opera sua educativa, assediato da ricorsi e da recriminazioni per la riprovevole condotta del nipote: e quando un brutto giorno ebbe la ingrata sorpresa d'un furto di roba e di danaro a suo danno, attore il suo beneficiato, non è a dire come ne rimanesse deluso. Tuttavia, non sapeva abbandonarlo: ne vedeva l'ingegno pronto e versatile, la rapida intuizione, la percezione piuttosto unica che rara, la copia degli espedienti e la parola arguta e suggestiva, e deplorava che tante qualità cospirassero ad opere malvage. All'arte del disegno parendogli più che disposto, pensò avviarvelo, e trarne ragione di mutamento delle malsane inclinazioni. Peppino vi fece progressi; ed acquistò in essa tanta valentia che un giorno visto in casa della zia un ventaglio, vi ritrasse con sì fine naturalezza due mosche, che mai persona l'ebbe a trovare spiegato che non allungasse la mano per iscacciarle.
Ma ahimè! della buona arte si servì a perfide prove, ora contraffacendo biglietti d'entrata al teatro S.a Cecilia ed ora falsificando un testamento a favore d'un Marchese Maurigi ed a scapito d'un pio istituto: il che non gli fu disagevole insinuandosi nell'animo d'un notaio suo congiunto.
Il bisogno ogni dì crescente di denaro e le difficoltà di procurarsene, acuivano in lui l'ingegno esuberante di trovati sempre nuovi e sempre audaci. Un tale s'era innamorato d'una giovane, cugina del Balsamo; il Balsamo se ne accorse e ne prese argomento per iscroccargli danaro: guadagnossi la fiducia del malcapitato, e combinò una corrispondenza in regola tra lui e lei, che non sapeva nulla, e che per nulla al mondo avrebbe osato scrivere un biglietto. Il carteggio procedeva attivo, caloroso, e quando il momento parve alla ragazza, o meglio al Balsamo, opportuno, la innamorata chiese del danaro, che lo innamorato affrettossi a mandare; sicchè non pochi furono gli scudi che l'abile autore di siffatta commedia cavò di tasca al cieco amante, il quale nulla negava a lei, neanche un orologio ed altre minuterie.
E non basta.
Scopertosi l'inganno, egli proseguiva per la sdrucciolevole via. Il superiore d'una comunità religiosa avea bisogno d'assentarsi dal convento. Conoscendo il Balsamo buono ad ottenergli una licenza, interpose l'opera di lui: e la ottenne. La licenza era falsa ed il povero baggeo l'avea pagata profumatamente.
Questa ed altrettali bricconerie non passavano sempre inosservate, nè sempre impunite. Più volte D. Peppino cadde nelle grinfe della polizia, più volte venne sottoposto a processo; ma o che le prove difettassero, o che la furberia in lui fosse maggiore dell'avvedutezza della Corte Capitaniale, o che valide aderenze di congiunti neutralizzassero il rigore delle leggi, egli ne usciva sempre impunito, e forse innocente. Una però dovea riuscirgli fatale; e a ben darsene ragione, bisogna premettere una notizia che più tardi acquistò credito in Palermo, cioè che il Balsamo fosse uno stregone.
Si raccontava che un giorno essendo egli con alcuni suoi compagni, e volendo essi mettere ad esperimento codesta sua facoltà, gli avessero chiesto che cosa facesse in quell'istante una nota dama della Città. Egli, segnato senz'altro un quadrato per terra, vi passava nel centro le mani, e tosto, mirabile a dirsi! appariva nettamente delineata la figura della dama nell'attitudine di giocare a tresetti con tre suoi amici. Stupefatti ed increduli, i compagni mandano sull'istante a verificare la cosa al palazzo di lei, e trovano la dama nè più nè meno che aveano visto nell'inesplicabile quadrato.
Con questa fama, non è da maravigliare della dabbenaggine di un argentiere d'allora, certo Marano, i cui discendenti esercitano ancora l'arte della oreficeria. Costui aggiustando fede alla occulta scienza del giovane si lasciò per inganno carpire la somma di sessant'onze (L. 765). Assicuravalo il Balsamo di un tesoro da scoprirsi, un gran tesoro, nelle vicinanze di Palermo; difficile, ma sicuro esserne il possesso e, conseguitolo, immense le ricchezze. Entrambi si recano sul luogo indicato; Balsamo comincia le operazioni: tira linee, recita parole nere, invoca spiriti e dopo lunghe misteriose pratiche vede apparire molti diavoli (amici suoi tutti, camuffati da demonî) che prendono a bastonate l'ingenuo argentiere. È un momento difficile per costui, a tutt'altro preparato che a questo trattamento; il quale però, vistosi in così grossolana maniera ingannato, si affretta a richiamarsene all'autorità, e giura sanguinosa vendetta del volgare giuntatore.
Palermo non faceva più pel Balsamo, e Balsamo partiva a rotta di collo.
Queste ed altre furfanterie, delle quali devono serbare ricordo gli archivi della Corte Capitaniale e della Corte Criminale del tempo, bastano a far presumere quel che D. Peppino fosse per diventare. L'isolamento del paese e le difficoltà di moderarne gli effetti facevano perdere le tracce dirette di lui; ma le indirette, vaghe, anche labili, non mancavano, e forse potevano comporre i fili del grande ordito di menzogne per le quali resterà memorabile la vita di sì famoso imbroglione.
Il romanzo (giacchè si tratta d'una specie di romanzo, quasi incredibile) si apriva a Messina e si chiudeva a Roma: a Messina, con l'amicizia d'un poliglotta ed alchimista greco o spagnuolo, Altotas, che riusciva a formar drappi a mo' di seta con la canapa ed il lino; a Roma, con l'arresto e la carcerazione in S. Leo, ove, ultima di sue geste, era il tentato strangolamento d'un confessore, da lui, reo convinto e apparentemente pentito dei suoi misfatti, richiesto, col perfido intendimento di evadere vestendone la tonaca. In questa trentina d'anni, quanti ne correvano dal precipitoso abbandono di Palermo alla morte, fu una successione tumultuosa, convulsa di avventure, che sfuggono anche al più diligente indagatore.
Da Messina ad Alessandria d'Egitto, a Rodi, a Malta, a Napoli (bisogna vedere che cosa fece lì con due siciliani, l'uno più triste dell'altro!), a Roma, a Bergamo, a Genova, ad Antibo, a Barcellona, a Madrid, a Lisbona, a Londra, ogni genere di frodi e di ciurmerie egli perpetrava, cooperatrice non sempre volontaria Lorenza Feliciani, ragazza da lui sposata a Roma e con raffinato lenocinio da lui resa complice di sua spudorata condotta.
Da tutto egli traeva danaro: dalle conoscenze che procuravasi, dalle commendatizie di alti personaggi, da amicizie che improvvisava, da un'acqua da lui composta per ridar la freschezza della pelle alle donne, da una bevanda per far ringiovanire, da un segreto per la produzione dell'oro; e poi dagli studiati abbandoni della moglie e dalle concordate sorprese. Eppure, spendereccio com'egli era per indole e per calcolo, non avea danaro che gli bastasse. Nel volger di due o tre anni dicesi avesse consumato non meno di centomila scudi, entrati per illeciti guadagni nella sua borsa. Sua caratteristica, la improntitudine, sia che egli spacciasse rimedî empirici, sia che assumesse titoli nobiliari, sia che si circondasse del fastigio di gran signore pompeggiando di mode, di parrucchieri, di maestri da ballo.
Lasciato che la Lorenza diventasse in Parigi Madama Duplesir, se ne richiamava all'autorità personale del Re; e mentre Luigi XV ordinava la cattura, in S.a Pelagia, della infedele — artificiosamente infedele — donna, egli, il Balsamo, in uno dei tanti processi a suo carico sosteneva non esser mai dimorato in Parigi. Arrestato un po' dappertutto, tante ragioni trovava, spesso sacrilegamente giurate sul Vangelo o sul Crocifisso, e così valide, da trarsi d'impiccio: ed avea il coraggio di tornare nei medesimi luoghi ond'era sfuggito rasentando la galera.
La truffa all'argentiere Marano nol trattenne dal rivenire a Palermo (1773): ma il Marano, implacabile contro di lui, avutone sentore, e denunziatolo, lo fece mandare alla Vicaria. Allora si volle esumare il processo pel testamento Maurigi: e buon per lui che un alto signore intervenne in modo violento; se no, gli sarebbe finita molto tragicamente.
Questo signore, amico intimo del Balsamo e più che intimo della Lorenza, prese sotto la sua protezione il catturato. Riuscitigli infruttuosi gli espedienti per liberarlo, nell'anticamera del Presidente del tribunale aggrediva il pratocinatore dell'avversario del Balsamo, e, forte com'egli era e manesco e sfrenato di volontà e potente e ricco, lo buttò per terra, lo calpestò, e forse l'avrebbe finito senza l'interposizione del Presidente. Il quale, debole e pauroso, non seppe punire il colpevole e, per la pusillanimità delle parti contrarie, mandò libero l'imputato351.
Diedegli però lo sfratto: e madre e sorella, non si sa più se sorprese del nuovo esser di lui e delle vecchie abitudini loro, lo videro stavolta per sempre, partire non senza avergli prima la Giovanna prestato quattordici onze (L. 178,50), frutto di risparmî, che ahimè! non le furono più restituite!
Notizie di alternative incessanti di scrocconerie e di accuse, di ricchezze e di miserie, di trionfi e di cadute, di truffe e di guadagni, giungevano per via dei giornali esteri e di qualche viaggiatore in Palermo. Si raccontava dell'arte sua di convertire il mercurio in argento, d'indovinare i numeri del lotto, di possedere il lapis philosophorum. Si parlava dei suoi titoli, ora di Marchese Pellegrini (da lui già assunto prima del ritorno a Palermo), ora di Marchese d'Anna, ora di Marchese Balsam, ora di Conte Fenix, e finalmente e definitivamente di Conte Cagliostro. Con questo specioso nome la fama di lui corse per tutto e vinse le barriere degli stati d'Europa. Entrato nella Società dei Liberi Muratori, ne divenne maestro e riformatore. Molti, infiniti i seguaci e gli adepti, ciechi nel credere a prodigi che non vedevano e che nelle esaltate loro immaginazioni ingigantivano. Giammai una verità fu dato di sorprendere in bocca di lui; tutto menzogna, tutto finzione, tutto mistero: ed in questo avvolgendosi, non mai fece sapere dell'esser suo, della sua nascita, della sua patria, della sua età, dei suoi parenti.
Viaggiava quasi sempre in posta anche col seguito di più legni: servito da corrieri, camerieri, lacchè, in isplendide livree, pagate fino a 20 luigi l'una. Quartieri addobbati con fasto principesco, laute mense, vesti magnifiche per sè e la moglie, audacia di presenza, sussiego d'andamento gli crescevan credito di uomo straordinario, sì che il ritratto di lui spargevasi a migliaia di copie pertutto, e ventagli, ed anelli, e medaglioni, e bracciali lo rappresentavano in disegno, in pittura, in rilievo, in ismalto; e bronzi con la iscrizione Divo Cagliostro servivano di ornamento ai salotti signorili. Si disse che i suoi occhi di fuoco leggessero in fondo all'anima, e lo si ritenne padrone della scienza e di tutte le lingue d'Europa e d'Asia!
E questo è poco.
Spargendo a larghe mani favori e beneficî, operando per via d'imposture e per fortuna di caso guarigioni, parve dove angelo di beneficenza, dove iniziatore d'una religione rinnovatrice dei corpi e delle anime, dove un intermedio all'uomo ed a Dio. In mezza Europa, ignoranti e dotti, plebei e nobili, popoli e principi se ne contendevano la vista, la parola, il tocco, l'amicizia, l'opera; ma andando però o fermandosi successivamente in Lisbona, Cadice, Malta, Pietroburgo, La Aia, Bruxelles, Venezia, Varsavia, Francoforte, Strasburgo, Napoli, Bordeaux, Passy, Basilea, Brienne, Aix, Torino, Roveredo, Trento, lasciava dietro di sè come una striscia di imbrogli, di cabale, d'inganni, di furti. Non solo l'indole irrequieta ed avventuriera lo spingevano di città in città; ma anche le conseguenze delle sue perfide arti di tutto falsificare, spillando, rullando a man salva somme talvolta favolose. E diciamo a man salva, perchè arrestato una ventina di volte, ebbe sempre la singolare abilità di salvarsi, ora corrompendo carcerieri, ora giurando il falso, come quando, imputato d'aver preso parte all'inganno d'una collana di brillanti fatto alla Regina Maria Antonietta, e chiuso nella Bastiglia, veniva dal Parlamento per mancanza di prove liberato; fatto del quale son piene le gazzette del tempo e libri usciti sotto i nostri occhi352.
Sembra di assistere a scene fantastiche, e si è invece a fronte della più ributtante realtà: e si chiede stupefatti come mai tanto potesse avvenire con le restrizioni dei governi e sotto gli occhi di Argo delle diverse polizie d'allora.
Gli è che ovunque egli andasse l'opera sua veniva sempre diversamente giudicata dai diversi personaggi e ceti, quali sbalorditi alle sue inesplicabili guarigioni, quali incerti se in quella figura dozzinale albergasse un genio incompreso o lo spirito d'un basso ciurmadore, se un taumaturgo sommo o un cabalista volgare, un pensatore profondo o uno scaltrito improvvisatore di favole, se un grande riformatore del secolo o un essere esaltato dei successi fortuiti della sua vita vagabonda.
Quando all'aprile del 1787 il Goethe metteva piede in Palermo era fresca la Lettera al popolo francese del Cagliostro (Londra, 20 giugno 1786): e faceva il giro d'Europa la polemica tra questo e Monsieur Morand, che nel Corriere d'Europa strappava la maschera al sedicente Conte. E però una delle prime cose che fece fu la ricerca dei parenti dell'audace impostore. Quella ricerca fu la prima seriamente e spassionatamente condotta.
La buona e dolce madre di Giuseppe Balsamo con la figliuola Giovanna, vedove entrambe, avevano abbandonata la via della Perciata e si erano ritirate in via Terra delle Mosche vicino il Cassaro353. Quivi accompagnato da uno scritturale di un valente avvocato, le trovò Goethe, modeste, ignare della sorte dell'amato congiunto, impazienti di notizie di lui, che per sentita dire sapevan già divenuto un gran personaggio, segno a gravi persecuzioni ed a culto presso che divino: e la Giovanna, nelle sue grandi miserie, si rammaricava che Giuseppe, nel mar di ricchezze nel quale nuotava, si fosse dimenticato delle 14 onze da lei prestategli nell'ultima sua venuta a Palermo354.
Avea ragione!
Cagliostro avea truffato centinaia di migliaia di scudi, senza mandarne uno alla santa vecchiarella della madre, alla sventurata sorella creditrice, che intristiva nella inopia con tre poveri figliuoli ed una disgraziata malaticcia che per carità teneva in casa.
Meno di tre anni dopo, il matricolato furfante, il Casanova della Sicilia, tentato dalla Lorenza, desiderosa di ritiro e di pace, rientrava in Roma. Fosse in lei stanchezza o paura, fosse debolezza o, come parrebbe, perfidia355, egli veniva arrestato e condotto nelle carceri del S. Uffizio al Castello S. Angelo. Molti conti avea da aggiustare col famoso Tribunale specialmente in materia di fede e di logge massoniche, ed il Tribunale, dopo un lungo processo, glieli fece pagare tutti fino all'ultimo.
Il processo fu reso di pubblica ragione a Roma, nella stamperia della Rev. Camera Apostolica, e tosto, a soddisfazione dei curiosi timorati, riprodotto in Palermo356. La Conversazione istruttiva ne dispensò per un buon mese ai suoi lettori.
L'anno 1795, «l'eroe degli scellerati», come lo chiamarono gli avvocati di Madame la Mothe, moriva, come abbiam detto, d'accidente357: proprio cent'anni dopo (1695) che nella medesima fortezza, pei medesimi misfatti di lui e per opera della medesima Inquisizione esalava il suo maligno spirito il celebre impostore Giuseppe Borri!358.
CAP. XXI.
L'AB. VELLA E LA SUA FAMOSA IMPOSTURA.
Non era ancora scomparso dalla scena del mondo tanto colosso di giunteria che un altro, meno famoso, faceva la sua apparizione a Palermo.
Stavolta la leggenda è più ristretta: ed il triste eroe ne è un prete. Giuseppe Balsamo da Palermo sceglieva a teatro delle sue brutte imprese l'Europa tutta; Giuseppe Vella da Malta svolgeva l'opra sua di falsificatore di codici e di creatore di favole nella sola Palermo: strana coincidenza di malvagità in un medesimo tempo e in un medesimo paese, tanto più strana in un periodo di non comune risveglio intellettuale.
Un giorno si vede a passeggiare per la città un sacerdote non prima conosciuto. Grave l'andare, studiati gli atti, affettata la pronunzia, bastardamente toscana la parola. Indi a non molto giunge da Napoli, sospinto da fortuna di venti, un Ambasciatore marocchino (17 dic. 1782). I due stranieri si avvicinano e s'intendono; e il sac. Giuseppe Vella (giacchè l'ignoto ecclesiastico si chiamava così) che col suo maltese riesce ad intendere ed a farsi intendere, si fa interprete di quello; e per incarico del Vicerè lo accompagna nella visita e nelle conversazioni per la Città. L'oscuro pretonzolo diventa subito illustre, e lo si comincia a credere un dotto arabista; ed egli, che neppur sa l'alfabeto arabo, s'atteggia a genio di quella lingua.
In una barca di corsari arenata nella spiaggia di Cefalù veniva trovato non so che libro turco. Vella in tutto sussiego lo esamina e lo dichiara un libro di tesori nascosti nei dintorni di quella città. Il codice invece parlava di sepolcri dei primi Califfi! Più tardi, all'apice della sua gloria e della sua lingua, i Canonici della Cappella Palatina lo pregavano d'un parere sopra un cofano con iscrizioni cufiche; ed il Vella lo sentenziava già ad uso di viatico, coi primi versi del Pange lingua in arabo. Ma poichè i Canonici gli facevano osservare il Pange lingua essere stato composto da S. Tommaso (sec. XIII) egli, correggendosi, lo affermava già consacrato alle reliquie dei Santi Apostoli. Il cofano invece era servito ad altri e ben diversi usi.
Mons. Airoldi, Giudice della Monarchia, amantissimo di cose sicule e delle vicende dei Mussulmani in Sicilia ricercatore premuroso, ma, perchè ignaro di Arabo, non fortunato, gli faceva allora domandare se si fosse mai imbattuto in alcun codice che portasse nome a quella dominazione tra noi: ed il Vella rispondeva uno averne veduto con l'Ambasciatore nella Biblioteca dei Benedettini di S. Martino, che narrava appunto della conquista musulmana dell'Isola; difficilissima però esserne la lettura, non che la intelligenza.
Alla insperata notizia l'Airoldi esulta, e sotto la sua personale responsabilità, ottiene in prestito dai monaci Benedettini il prezioso cimelio. Vella, eccitato a lavorarvi sopra, con l'obiettivo d'un largo premio, che per lui sarebbe l'Abbazia di S. Pancrazio, vi si consacra, com'egli dice, con ardore; ma in sostanza, con la flemma di chi perfidia a danno della verità.
E presenta le prime pagine. L'Airoldi va in visibilio; perchè vi trova nientemeno «un registro di tutte le lettere che dal principio della invasione araba in Sicilia aveano scritto di mano in mano gli Emiri prima a' Mulei dell'Africa Aglabiti e poi ai Sultani di Egitto Fatimiti, colle risposte di costoro. Per lo che queste lettere portavano in sè la fede della loro autenticità, e dimostrando l'amministrazione, le imprese, i politici regolamenti degli Arabi, formavano il diritto pubblico di quei tempi, ed erano secondo l'apparenza il più prezioso monumento della storia degli Arabi in Sicilia.»
Rozza quale l'uomo che la maneggiava la forma della traduzione: e questo grandemente concorreva ad accreditare l'autenticità del codice; giacchè il Vella, privo affatto di coltura, nessun sospettava capace di sofisticar l'originale, che nella traduzione orribilmente spropositata offeriva, secondo l'Airoldi, anzi secondo la comune opinione, una impronta nuova, la quale agli ignari di cose orientali poteva sembrare propria degli scrittori di quella razza.
L'Airoldi correggeva le sgrammaticature e prendeva per oro di coppella il contenuto del manoscritto. Aveva sognato una civiltà araba: e già la trovava nella nuova inattesa scoperta velliana. Le idee, le aspirazioni su quell'epoca, da lui espresse nei giornalieri conversari coi dotti frequentatori della sua casa, avevano nei nuovi testi addentellato e conferma. E non poteva essere diversamente se il Vella, partecipe ai geniali convegni, conosceva ormai i desiderî del buon Prelato, e creava a soddisfazione di lui un romanzo tutto immaginario.
E pensare che appunto per questa creazione il Vella veniva chiamato ad insegnare arabo nell'Accademia (Università) degli studî! e che, non conoscendone egli, come abbiam detto, neppure l'alfabeto, insegnava ai giovani i rudimenti della lingua maltese! E non è tutto: raccomandato dal March. Caracciolo, il neo professore otteneva dal monarca 1000 onze (L. 12750) per una missione scientifica nel Marocco, per la quale, accompagnato da tre suoi scolari, potesse raccogliere i materiali per la storia di Sicilia sotto i Musulmani.
Di tanto in tanto qualche nuvoletta sorgeva ad offuscare il sereno dell'anima di Mons. Airoldi. Quel nome, quella data, non sarebbero un errore di lettura? Ma il Vella, invitato a rileggere il testo di quel nome e di quella data, non avea nulla da rettificare, e sugli ordini sacri giurava che le cose erano proprio come avea detto lui. Avvalorava poi la lezione con nuovi codici arabi e con monete e lettere che egli con sempre nuove menzogne affermava ricevere da Fez, da quel medesimo Ambasciatore Marocchino Mohammed Ben Osman che egli avea accompagnato per Palermo, e che per lui era il provvido fornitore di carte e di documenti, il consigliere, l'amico, il fratello.
La traduzione, plaudenti i dotti che ne sentivano a parlare e gongolante di gioa l'Airoldi, procedeva a vele gonfie.
Ma ecco, quando nessuno se lo aspetta, un uomo di forte ingegno e di larga cultura levarsi a turbare tanta armonia di cuori e di voci. Rosario Gregorio sospetta la falsità del codice e la impostura del Vella: e con documenti e ragioni irrefragabili dimostra quanto dal vero siasi discostato il sedicente traduttore inventando date, fatti, luoghi, persone. L'Airoldi, che nel lavoro del Vella vede assicurato il suo monumento storico, ne rimane contrariato; sconcertato, ma non confuso nè vinto, il Vella. Il quale a nuovo suo titolo di gloria si affretta a metter fuori la sorprendente notizia della scoperta dei libri smarriti di Tito Livio, in uno di questi codici: scoperta che sa circondare di tanto mistero, da lasciare inquieti i letterati.
Allora l'Airoldi annunzia la stampa del primo foglio della traduzione: col quale si propone di render giudici del lavoro del Vella gli orientalisti oltramontani. Vella si vede perduto, e ricorre ad uno stratagemma tutto cagliostriano: mette le mani sul codice di S. Martino e lo interpola, lo altera, lo corrompe in guisa da non potersene più cavare costrutto di sorta. Il maggiore strazio è nelle prime pagine; e perchè non si possa scoprir la differenza dell'inchiostro recente della manomissione sull'inchiostro antico del testo originale, e le difficoltà portino la impossibilità di lettura, attacca sulle singole pagine una sottile pelle di battiloro. Così si tiene al sicuro. S'incide la prima facciata, che è una vera lettera del diavolo di Girgenti. I dotti convengono che testo e traduzione son barbari; e mentre alcuni ne mettono in dubbio l'autenticità, altri, e sono i più, dai difetti traggono fondamento alla sincerità del codice e del traduttore. Tychsen è di questi, e contro tutti sorge paladino del Vella. Sono col Gregorio, Simone Assemani, De Guignes, Barthélemy, Adler. All'Airoldi, manco a dirlo, va molto a sangue la opinione del Tychsen, che leva a cielo la perizia linguistica del Vella, battezzata per «incomparabile e quasi divina» (1787). Sotto il pseudonimo di de Veillant, nel quale sembra nascosto il Gregorio, esce in cattivo francese un'arditissima carica contro il saggio venuto in luce; tutti o quasi son contro il critico, e l'ambiente è saturo dello spirito arabico velliano. De Veillant è ritenuto un invidioso ignorante, e tra una velenosa risposta dello storico Di Blasi inneggiante al Vella, due lettere laudative del Tychsen al Torremuzza ed al Vella medesimo, pubblicate in Palermo (1788) e le deboli ma giudiziose controrisposte, le cose vanno tant'altre, che, prevalendo il giudizio dell'autorevole professore di Rostock, la impostura trionfa con la pubblicazione del primo volume del Codice diplomatico arabo di S. Martino delle Scale, e poi, mano mano di altri cinque, coi quali l'opera attinge alla sua fine359. Il Iº vol. porta una dedica a Ferdinando: il IIº, una a Maria Carolina; e in tutti e sei il verso di Lucrezio:
E tenebris tantis tam clarum extollere lumen.
Tychsen accoglie nel suo Elementare arabicum, come saggio di dialetto volgare mauro-siculo, l'apocrifa prefazione; Wahl ne prende ragione d'una storia e statistica degli Arabi in Sicilia; il Vescovo irlandese Woodward lo riassume in inglese, Sachard in francese. Canciani a Venezia, Carli a Milano riportano brani del Codice come reliquie preziose del medio evo; Rossi se ne serve a documento del suo diritto pubblico della Sicilia, Napoli Signorelli per fissare il grado di cultura siciliana ai tempi arabi. In Sicilia l'ab. Ferrara ne cava notizie di eruzioni etnee... non mai esistite, ed il sac. D'Angelo ne fa un estratto per un seminario di Messina. Ce n'è d'avanzo per cominciarne una traduzione latina; ma questa, col titolo di Codex diplomaticus Siciliae, arena al solo primo tomo.
L'Airoldi, soddisfatto di sè e del suo arabista, si riposa sui travagliati allori; e non si accorge di essere stato grossolanamente turlupinato!
Frattanto nessun premio giunge da Napoli al traduttore: non l'ambita abbazia, non la cantoria della Cappella Palatina, non la più volte implorata raccomandazione del Re al Gran Maestro dell'Ordine gerosolimitano per una Commenda di quell'ordine lungamente richiesta e sollecitata. Bisogna pur dire che gli uomini sono ingrati verso l'autore di un'opera così insigne!
Allora, vedendo fallire ogni vecchia e nuova speranza, egli volge la versatile mente al disegno d'un edificio, che tutta chiamerà a favor suo la Reggia di Napoli. Non ha egli felicemente compiuto un Consiglio di Sicilia per l'epoca araba, gloria dell'Airoldi e sua? Ora egli condurrà innanzi, a sua gloria esclusiva, un Consiglio di Egitto per l'epoca normanna. La materia è stata trovata: il mitico Ambasciatore del Marocco fornisce codici e documenti quanti ce ne vogliono. La forma è la solita epistolare, simile a quella del codice martiniano. L'argomento di vera, irrefutabile attualità: le prerogative e i diritti della Corona di Sicilia, tanto discussi nelle Corti di Napoli e di Palermo e nelle case signorili, e sostenuti a tutta oltranza nelle conversazioni del Circolo Airoldi.
Il nuovo codice, che dicesi arabo, è invece maltese; e mentre si spaccia copiato sull'originale di Fez, viene invece dall'attiva fabbrica del Vella. Nel Consiglio di Egitto sono largamente attribuite immense prerogative alla Corona nei tempi arabi; ed il traduttore nella sua dedicatoria al Re osserva che «i supremi diritti della regalia, non altrove quanto in questo codice ampiamente rilucono. Nè v'è dubbiezza storica che egli con le sue lettere ed in brevi parole non decida e richiari.» Nulla vi manca per solleticare la vanità di un sovrano e l'avidità di Ferdinando di Borbone; e quando l'audace imbroglione parte per Napoli ad umiliarlo ai piedi del trono, orientalmente prosternandosi con la fronte per terra ed offerendo a S. M. Siciliana un anello con lettere cufiche, che egli dice del Conte Ruggieri360, Ferdinando gli concede tutto quanto all'emulo del Casanova e di Cagliostro piace.
La pubblicazione del primo volume del Consiglio rivela che dieci anni di falsità e d'inganni non sono andati perduti: egli è già Abate di S. Pancrazio361.
Il Gregorio, fattosi già molto innanzi negli studî arabici, mostrava con l'ampia collezione Rerum arabicarum quanto valesse. Eppure alla sua solida scienza pochi prestavano omaggio, infanatichiti di quella bugiarda dell'Abate. Per poco che nel pomeriggio si andasse pel Cassaro, e si uscisse fuori Città, lo s'incontrava, il fortunato ciurmadore, nella sua nuova carrozza acquistata coi lauti beneficî reali, ricrearsi alla Marina ed alla Villa Giulia; e chi avea entratura nei palazzi magnatizî, lo vedea sedere a pranzi luculliani: molla dai nobili creduta potente per salvarsi da possibili deplorevoli conseguenze della pubblicazione del Consiglio di Egitto, demolitore dei diritti feudali a beneficio della regalità. E qua e là lo sentivano a vantarsi di una lettera del Pontefice, che gli raccomandava di aver cura della sua vista tanto compromessa dalle gravi fatiche sostenute.
Ma vengono presto i giorni neri!
Già il Conte di Stolberg al suo primo giungere a Palermo s'era stupito al racconto di tanta audacia; ma nello stupore avea confessato che solo un uomo di altissimo ingegno avrebbe potuto esser capace di tanto362. Ed avea ragione!
Richiamato dalla Corte a Palermo, dove per semplice diporto era stato nella scorsa primavera, il prof. Giuseppe Hager ritornava nella Capitale il 21 dicembre 1794. A spese del Re il bravo sinologo riceveva particolare incarico di studiare la questione dei due codici e di darne parere. Vella, che avea bravato per tanti anni gli avversarî, perdeva il coraggio e chiudevasi come smarrito in casa.
Hager chiede documenti all'uopo della sua missione: codici, stampe, manoscritti; ma Vella fa orecchie da mercante: e, datosi per infermo, crede giustificare il suo silenzio. Stretto dalle domande insistenti del perito, simula (8-9 genn. 1795) un furto di carte donde la sua rovina. Finge di ammalare dalla paura, di sputar sangue per tre giorni; prende il Viatico e si raccomanda per morto a Dio.
La misura è colma!
Il Vicerè caramanico è morto; succede Lopez Presidente del Regno: il teatro politico e morale si è improvvisamente mutato. Il Presidente Grassellini con un colpo di mano fa nottetempo assalire la casa del Vella, sequestrare le carte di lui, assicurare alla Giustizia la sua persona, a vista di due guardie. E qui si viene a sapere, un frate francescano maltese aver copiato mercè il compenso di 16 onze (L. 204) (e la copia, incredibile la grossolanità della impostura! in carta Fabiani di Genova) il presunto Codice del Consiglio di Egitto; avere il Vella da alcuni giorni bruciate carte e carte; una cassa piena averne messa al sicuro nell'abitazione di sua sorella, moglie di un certo Cutrera: simulazioni tutte il furto, la malattia, i gravi pericoli corsi; pretesto il Viatico.
Per un momento il turbine così foscamente addensatosi sul suo capo si arresta: e secondo alcuni minaccia, secondo altri promette di dileguarsi; giacchè un dispaccio del Segretario di Stato Simonetti chiama in Napoli il Vella: il che rianima i partigiani di costui. Ma un nuovo dispaccio di Acton toglie ogni speranza, e rincora gli avversarî. In una adunanza di cinque letterati, presieduta dal Marchese Dragonetti, Hager e Vella discutono dei due codici e della traduzione: e, siccome è partito preso che si debba schiacciare Hager ed esaltare il Vella, si conchiude luminosamente a favore di costui. Eppure tutti e cinque sono analfabeti in arabo!
Tornato a Napoli, il dotto orientalista dà il suo parere, che è una ragionata, incalzante, perentoria conferma della solennissima impostura.
Tutto questo raccontavano alla distanza di 28 anni il Dr. Hager e con minutezza di particolari Domenico Scinà, testimoni oculari, credibili in tutte le loro affermazioni363. Là dove questi dice che della traduzione si voleva tentarne una versione tedesca, egli mostra di non sapere che appunto quella versione fu fatta e che vide in parte la luce364: tanto si era lontani dal sospettare la misura della straordinaria furfanteria; e quando aggiunge che tutta la Città si divise in partiti; che «nelle conversazioni ed ovunque si parlava del Vella e dei codici arabici»; che «in ogni parte si altercava»; che «anche le signore vi pigliavan parte, e vi aveano tra noi Guelfi e Ghibellini», afferma cose più che vere.
Hager, infatti, raccontava che in Palermo, «per ben sei mesi l'argomento della conversazione giornaliera erano gl'inganni del Vella. Si sentivano donne a ragionare di codici normanni, di manoscritti martiniani e di lettere cufiche come se fossero tante diplomatiche. Quantunque non ne capissero sillaba, pure volevano parlarne e, quel che è più, darne giudizio. Presto si formarono due partiti; alcune sostenevano che Vella fosse innocente e che l'ingannatore fossi io; altri invece difendevano calorosamente me, ed in segreto mi dichiaravano di credere a tutto ciò che avevo detto io». E finiva con questa confessione un po' mondana: «Io mi curavo di tirare dalla mia le più giovani e le più belle, e non mi preoccupavo del malumore delle altre»365.
Dopo il severo verdetto di Hager, l'Ab. Vella affin di scampare dai rigori della Corte di Napoli, scriveva lettere giustificative della sua riprovevole condotta: parte scusando, parte confermando quel che di colpevole era nell'opera sua. Eppure, anche quelle lettere erano nuove menzogne e nuovi raggiri. La Corte si disponeva a dare all'Europa notizia di ciò che avea fatto per l'ingrato argomento; ma l'Airoldi, a cui, spettatrice l'Europa, veniva a crollare il grande edificio storico, chiedeva, non persuaso ancora, di appellarsi a giudice più competente di Hager.
Monsignor Germano Adami, Arcivescovo di Aleppo, greco melchita, col suo segretario Dakur, arabo autentico, veniva invitato ad un'ultima perizia in Palermo. A farla breve, il suo giudizio si compendiava nelle seguenti parole:
«Si rileva evidentemente essere questo codice (di S. Martino) interpolato e corrotto maliziosamente con linee e punti soprapposti di mano recente ed estera, specialmente sulla prima pagina, e col cassare totalmente le chiamate solite delle pagine per renderlo illegibile e così covrire l'impostura e la finzione della pretesa traduzione. Da varii periodi o parole sparse in questo codice, che sono sfuggite dalla maliziosa corruzione, si conosce evidentemente essere questo codice una collezione di varii autori musulmani contenente la nascita del loro profeta Maometto!...».
Del Consiglio di Egitto dice: «Essere una traduzione dalla lingua italiana in una lingua araba corrottissima, ed essere più gli errori grammaticali che le medesime parole, non essendovi alcuna concordanza di casi, di generi, di tempi e di persone». La materia tutta di sana pianta presa, manipolata, accomodata, inventata dall'Autore.
«La tela — esclama Hager — cadde e la lunga commedia ebbe fine!»
Sottoposto a processo, il Vella veniva condannato (1 febbr. 1796) a quindici anni di carcere ed alla confisca dei beni: pena adeguata a tanta tracotanza. Partigiani e adoratori dell'idolo dai piè di creta ammutolirono, incerti se egli fosse un reo o una vittima innocente della umana perfidia. Degli illustri contemporanei trionfava Gregorio Meli, che avea per tanti anni fatto all'amore con l'Abbazia di S. Pancrazio, dettava un'ingegnosa lirica ridendo della minzogna saracina366. L'Ab. Carì scaricava cinque corrosivi sonetti addosso al Vella ed alla Commissione anarabica giudicatrice di lingua araba. Villabianca, sdegnatissimo, voleva mandato il Vella alla forca, della quale apprestava egli medesimo il disegno367. Più tardi (1799) Hager rivelava tutto al mondo intero in una memoria uscita contemporaneamente, in due lingue368.
Un gran bene da tanta bruttura dovea però derivare alla Sicilia. Gli studî di arabo quasi sconosciuti o molto negletti tra noi, diventavano un corredo degli studi storici. Senza la cagliostreria del Vella non si sarebbero avute le ricerche del Gregorio, nè quelle del suo scolaro, Salv. Morso; e forse di mezzo secolo si sarebbe ritardato per noi la conoscenza di monumenti, codici, lapidi, monete di quella dominazione che è tanta parte della storia di Sicilia dovuta all'Amari.
La tradizione della scuola araba tra noi ha ora resa possibile la tarda ma sicura e definitiva deciferazione del genuino testo del codice martiniano, reso astruso e presso che indecifrabile dalla manomissione del famigerato falsario369; il quale non aveva vergogna di caricare sul Monastero di S. Martino trent'onze (L. 382,50) di spesa per la pelle da battiloro!370.
CAP. XXII.
I MEDICI E LA LORO VITA. NOBILI ESEMPI DI CARITÀ. L'ACCADEMIA DEI MEDICI E LA PRIMA CONDOTTA MEDICA.
L'esercizio medico era distintamente diviso tra la medicina e la chirurgia. Il medico non era chirurgo; per la sua dignità, egli v'inclinava poco o punto, perchè il chirurgo stava al disotto del medico e ne dipendeva nelle prescrizioni, ch'egli talora eseguiva come il barbiere; il quale negli spedali teneva dietro, a rispettosa distanza, al medico fisico nella visita cotidiana delle corsie.
Molti dei fisici più conosciuti eran preti; e la medicina era in mano di non pochi tra essi, per istituto canonico non abilitati a maneggiar ferite nè a farne. Ecclesia a sanguine abhorret. Preti furono D. Andrea Gallina, D. Giuseppe Biundo, D. G. B. Meo, Fr. Cottonaro, medico del Vicerè Colonna, dal quale venne eletto Abate di S. Giacomo di Altopasso in Naro (1778), e D. Giuseppe Salerno: preti D. Raffaele Stancampiano e D. Giuseppe Serra, entrambi fisici maggiori degli spedali; prete quell'Ignazio Salemi che scrisse della Educazione medica371.
Nell'Ospedale grande e nuovo, sopra diciannove sanitarî, soltanto 6 eran chirurgi372, pagati Dio sa come!
A conseguire la laurea medica occorrevano tre anni di studio nella pubblica Università di Catania, e, pei Palermitani, nella R. Accademia degli studî di Palermo, alla quale per sovrana benignità venne esteso (1780) il privilegio di dottorato in medicina, limitato già a quella di Catania.
In una lettera intima ad un suo vecchio amico l'Ab. Meli (non sacerdote, ma semplice chierico) così pennelleggiava la sua professione: «La medicina vien giudicata in persona di un medico non altrimenti che coi sensi materiali, cioè dalla mole, peso, tono di voce, maniera di vestire e di marciare, dal salir le scale dei grandi, dalla spessa citazione di autori in lingue esotiche ed altre cose simili. Coloro cui mancano questi naturali requisiti ricorrono ai corteggi, agl'intrighi ed ai maneggi poco decenti, per cui questa nobile professione è oggi caduta nell'ultimo discredito ed avvilimento»373.
Il medico di grido conduceva seco uno o più praticanti. Codesto giovava alla istruzione dei giovani, ma giovava anche a lui, che, come dalla elegante gualdrappa era una volta giudicato dotto, così da questa compagnia traeva vantaggio alla sua buona riputazione.
A letto dell'infermo, l'uno, il medico curante, osservava; l'altro, il praticante (o i praticanti), riosservava: e l'ammalato dovea contare a due, tre, e sentire ripetere ad altri le sofferenze che gli sarebbe parso conveniente comunicare ad un solo.
Stando in compagnia di praticanti, il medico dettava ad uno di essi; solo, scriveva da sè la ricetta. Cifre e parole latine tecniche, dimezzate, abbreviate, fino alle sole lettere iniziali, ne eran la forma, che nessuno sapeva leggere, e che appena riuscivano ad interpretare gli aromatarî provetti, dai quali i giovani dovevano apprenderle. Ghirigori, arabeschi, accenni di linee, puntini: ecco la ricetta, che si stendeva in un pezzetto di carta in formole lunghe, misteriose, ritraenti dal caos del Gervasi. Un proverbio è rimasto documento di codesti geroglifici: Tri cosi 'un si ponnucapiri: ricetti di medici, pòlisi di 'mpignaturi e discursi di minchiuni. Di ciò anche il Filangeri si dolse nella sua Legislazione, rilevando che questo gergo, «questo linguaggio simbolico, che costa tanta fatica a medici per apprenderlo ed a farmaceuti per capirlo e che cagiona tanti equivoci, dovrebbe essere abolito»374.
Quello che sovente rafforzava il mistero era la espressione: R. aqu. ad nostram intentionem, sotto la quale con impostura non isventata mai da nessuno s'intendeva l'acqua da bere, che si spacciava a prezzo di medicina. Espressivo questo aneddoto: Un figlio di speziale nullatenente faceva all'amore con una ragazza civile ed agiata: quando il padre credette opportuno d'intervenire, andò a chiedere la mano di essa. — «Ma che posizione ha vostro figlio?» chiese il padre della ragazza. — «Farà lo speziale come me,» risponde il padre del giovane. — «E voi che cosa gli darete?» — «Un sacco di zucchero ed un pozzo d'acqua!» alludendo alla fonte dei guadagni dell'arte: lo zucchero per i cento sciroppi, l'acqua per tutte le tisane, gl'infusi, le emulsioni, le limonate, le soluzioni onde straboccava la farmacopea, guadagni che in parte, con una morale molto sommaria, andavano al medico, amico del farmacista, presso il quale, in ore libere, andava a sedere e conversare375.
Lento ma sicuro, benchè non sempre fruttuoso, il rinnovamento scientifico.
L'uso della idroterapia appassionava tutta una schiera di medici capeggiata da Giacomo Todaro. Ai gretti pregiudizi dell'influsso degli astri sulle funzioni fisiologiche contrapponeva ragioni fisiche Gregorio-Russo. La chemiatria, nata dall'ibrido connubio delle massime di Galeno e dei dommi di Paracelso, cadeva sfatata agli attacchi di Buonafede Vitale; e sotto i vigorosi, intelligenti colpi del catanese Agostino Giuffrida e del palermitano Andrea Gallina, plaudente l'Accademia dei Jatrofisici, crollava lo strano edificio del meccanismo flogistico di Boerahawe la cui autorità mal resisteva a quella di Van Helmont, di Stahl e di Hoffmann. Poi il sistema di Brown dominò sovrano: e dove prima si tenevano gli ammalati a rigorosa dieta, in seguito poi si vollero sostenere in forze con alimenti solidi e con eccitanti diversi. Contro il nuovo abuso gridavano i vecchi esperti: e Meli, pratico e temperato, dettava il sonetto: Di la sua vita all'ultimi simani, che è tutto un trattato sulle teorie dei medici novellini, facili seguaci del capo-scuola scozzese.
Questo volere e disvolere dei partigiani dei sistemi più celebrati facevano perdere la fede dei medici stessi nella scienza, incerti da qual parte stesse la verità e la salute: e fu scritto (1792) che «tolta qualche dottrina chimico-botanica, e qualche operazione chirurgica come la litotomia, l'innesto del vaiuolo ecc.», eran da preferire «gli antichi ai moderni, perocchè questi pativano molto di vertigini e di pletora»376.
Nel tumulto della vita mondana, in mezzo alle molte, spesso malintese manifestazioni d'una religione non sempre capita, si aveano pratiche non facili a comprendersi nell'ambiente in che ora viviamo. Una delle più importanti era quella della confessione per gli ammalati dopo tre giorni di febbre. Pramatiche viceregie e sinodi diocesani imponevano al medico curante il dovere di prescriverla, e gli minacciavano, contravvenendo, multe e carcere377. L'uso era comune e del frequente scampanio delle parrocchie come annunzio ed invito al Viatico, e del tintinnio pel procedere di esso nelle strade, nessuno si allarmava. Il medico Salemi ne disse qualche cosa anche lui, e ne fece un articolo di polizia medica, allargando (egli che scrivea nei primi dell'ottocento) un pochino le maniche per i fatali giorni rituali.
«A tre giorni di malattia, egli osservava, si facci eseguire la confessione, ed in più inoltrata malattia ordinare il viatico e l'oleazione sacra». E poichè questo era voluto dalle sanzioni canoniche come dalle leggi dello Stato, il medico «dovea notare il giorno in fronte alla poliza del Viatico sacramentale per potere in qualunque caso giustificare la sua condotta»378.
Negli spedali era ordine imprescrittibile che non si ricoverasse infermo non prima confessato. Lo afferma il Cangiamila, medico e sacerdote, il quale poteva saperlo379. Si vede che su questo punto non c'era da scherzare: ed i medici non volevano buscarsi il carcere di S. Eccellenza il Vicerè e la scomunica ipso facto di S. E. R.ma l'Arcivescovo.
Qui non è inopportuno un breve cenno di alcune malattie che nello studio del tempo si vedono ricordate da eruditi e da poeti. Lo facciamo come per una curiosità di patologia speciale.
Dalla tradizione e da rare erudizioni sappiamo che in numero straordinario erano le persone affette da malattie cutanee. La Deputazione dell'Albergo generale dei poveri lamentava che tra 400 ricoverati non pochi fossero scabbiosi380. Il Senato della Città se ne preoccupava: ed il Vicerè riceveva sollecitazioni delle cure ad essi dovute sul finire della primavera381. Un peritissimo speziale, il quale abitava presso la Madonna la Bella, nella via Macqueda, avea sì gran concorso nello spaccio di un suo specifico contro la scabbia, che a fin d'anno metteva in serbo guadagni favolosi.
Al facile e largo diffondersi di questa e di altre malattie di pelle concorreva l'erroneo concetto della natura di esse, i mezzi talvolta barbari, tal'altra banali di cura, il difetto di pulitezza personale, la assoluta trascuranza d'ogni elementare principio di igiene e, più che tutto questo, la superstiziosa ignoranza del volgo.
Un «Breve Ragguaglio di quanto praticano in questa Capitale le Figlie della Carità, serve delle povere donne inferme, nella loro pubblica Casa di protezione di S. Vincenzo de' Paoli, disposta da D. Ignazio Filippone»382 ci appresta le seguenti notizie, le quali se attristano per lo stato miserevole del paese, confortano con lo esempio delle opere buone praticate da anime gentili.
La Casa Filippone era ad un tempo spedale, infermeria, ambulatorio femminile. Gettiamo uno sguardo sulle ammalate che vi si ricevevano e sugli uomini che vi si medicavano. Quelle erano povere donne che non avevano dove andare, e le quali perchè non febbricitanti non venivano ricoverate negli spedali; eran civili, anche dame, vergognose di farsi visitare dagli uomini, e riluttanti a manovre chirurgiche. Nei pubblici spedali, dice il Ragguaglio, «non cadon sotto la cura moltissime infermità come sono la cecità, la sordezza, la itterizia, il salso, lo scorbutico, le impetigini, la tigna». Ebbene, al Filippone andavano le affette non meno da questi mali che da scrofolosi, da scottature e da altre esterne lesioni. «Istruite da uomini d'arte competentissimi, le suore curavano senza ferri; medicavano cagionando il minor dolore possibile, e distribuivano farmaci da loro stesse, addestrate in aromataria, preparati. Venti medici tra i più accreditati attestavano i vantaggi delle loro cure. Nella sola città facevano da undici a dodicimila indicazioni annuali, e davano da mangiare a tremilatrecento povere, e sussidî in danaro a più di millecinquecento persone. Nella loro Casa succursale di Mezzo Monreale, non solo apprestavano in parlatorio ad uomini infermi cure e denaro, ma anche ricevevano annualmente duemila donne in media383.
Concorrenza più formidabile di questa ai chirurgi non fu mai fatta al mondo: ma poche volte la storia della beneficenza scrisse pagine più sublimi di carità. Peccato che si perpetrassero da otto a novecento salassi all'anno!
Oltre a ciò compiangendo il gran numero di fanciulle affette da tigna, contro la quale non vedevano adoperar medicina che non fosse di tormento; onde «tante donzelle anco di riguardo rimanevano mezzo fra morte e vive, abborrite e escluse affatto dall'umano commercio»; le suore senza strappar capelli «(tormento replicato talora fino a 24 volte, ma inutilmente) avean trovato la dolce maniera di sanare felicemente, e senza prevalersi della pece. Così erano restituite agli ufizi tutti della civile società, da cui primo si vedevano escluse, e già molte passate a marito, ed abilitate altre ad un onesto maritaggio; oltre delle tante sottratte dall'ozio e dalla sfrontata mendicità che funestavano il paese ed infestavano le private famiglie»384.
In quest'ultima citazione si accenna ad una pratica, forse la più crudele che sia esistita per la cura della tigna, la cuffia di pece.
Questa cuffia fu comunissima nei secoli passati, e lo fu ancora nel XVIII. Il motto proverbiale: Lu santu chi fa la tigna, fa la pici, ne è un ricordo storico, eloquente per attestare, nessun rimedio essere più sicuro pel male ribelle e deformante. Una vecchia canzone popolare deplora il rincaro della pece a causa dei troppi tignosi.
Cooperatore delle epidemie era il vaiuolo, inesorabile sformatore di bellezze quanto funesto mietitore di vite specialmente infantili. I visi butterati, così rari oggi, erano ordinarî una volta. Quando ad una madre si lodavano le fattezze della sua creatura, ella, che aveva sempre l'incubo dello scellerato flagello, rispondeva malinconicamente e, purtroppo, con la esperienza dei fatti:
Nun si pò diri beddaS' 'un cci passa la pustedda;
e la pustedda era appunto la pustola del vaiuolo385.
La scoperta di Samuel Jenner tenne per un momento perplesso il Governo; ma finalmente venne accettata. S. Maestà Siciliana si decideva a farsi vaccinare, ed il Regno tutto, che n'ebbe conoscenza, pubbliche preghiere ebbe imposta e fece in centomila chiese per la salute di essa. L'operazione veniva coronata da splendidi risultati, e le chiese echeggiarono di ringraziamenti perchè tutto era andato bene; ma più tardi S. M., il figlio di Carlo III, come l'ultimo dei mortali, perdeva due bambini di vaiuolo!
Il 10 ottobre 1787 il Vicerè Caramanico ordinava allo Spedaliere dello Spedale grande che affidasse la vaccinazione al medico chimico Dr. Berna, bene istruito di essa dal cav. Gatti. Così egli avrebbe vinto i timori delle madri e scongiurati pericoli avvenire386. L'anno appresso, il Re consentiva che si chiamassero dalle principali città dell'Isola a Palermo, nella primavera e nell'autunno, volta per volta, otto barbieri ed otto levatrici, perchè venissero ad addestrarsi nel nuovo metodo preservativo del male387.
L'Accademia dei medici, già dei Jatrofisici, era secolare: ed aveva un attivo di benemerenze che la rendeva degna di distinzioni e di prerogative da parte del Senato. Benemerenze: l'aver contribuito all'abolizione del seppellimento dei cadaveri dentro le chiese e, in generale, dentro la città; la istruzione dei giovani medici; la discussione di tutto ciò che fosse materia di scienza. Distinzioni e prerogative: la benevolenza e la fiducia illimitata dell'Autorità municipale, che chiamava l'Accademia giudice dei posti da provvedersi negli Spedali; il titolo di Magistrato concesso ai reggitori di essa, quello di Principe al suo Presidente, ed un annuale assegno (concesso pure all'Accademia del Buon Gusto), un arazzo ed un'artisticaca mazza di argento, emblema non dubbio di riconosciuta autorità.
Il maggior titolo di benemerenza dei componenti quest'Accademia è però rimasto finora all'ombra: una specie di Condotta medica gratuita sorta per iniziativa loro nel 1770 e in seguito rinnovata. Trentasei medici fisici, divisi per otto parrocchie, spontaneamente si dedicavano alla cura degl'infermi poveri: guida e direzione, il Magistrato Accademico. Potrebbe non benevolmente pensarsi che questo essi facessero a sola ragione di pubblicità; ma quando si sappia che tra essi erano nientemeno il Cottonaro, il Fasulo, il Serra, il Gianconte, il Pizzoli, chiarissimi e di larghe clientele, ogni sospetto cade. Un piccolissimo cartellino a stampa è oggi il solo ricordo di questa istituzione: la quale quando non si sognavano ancora le multicolori croci di soccorso per gl'infermi a domicilio ed erano pio desiderio le condotte mediche comunali, provvedeva col sentimento della carità a disacerbare i dolori dei sofferenti privi di cure. Innanzi le porte delle chiese, questi cartellini, quasi invisibili nella loro forma, chiarissimi nel loro significato, indicavano i nomi dei medici pronti a qualunque chiamata di soccorso388.
Esisteva ab antico in Palermo e, contro il malvolere del Governo, prosperava un'Associazione detta del grano. Pagando un grano la settimana, quattro il mese (in moneta d'oggi, otto cent. di Lira), una famiglia godeva il beneficio dei medici per le malattie, della sepoltura per la morte. Che razza di medici dovessero aversi a questo patto, è facile immaginare! La celebre Giunta dei Presidenti e Consultore, il 5 marzo 1783 scrivea esser più d'una le opere del grano, per le quali gli ascritti «talvolta sono assistiti da imperiti medici che servono a rendere perpetue e più micidiali le malattie del popolo»389. Da siffatta istituzione volle trarre partito il Governo per un'assistenza medica ai poveri mettendo a profitto l'opera disinteressata dell'Accademia di medicina. La contribuzione del grano fu lasciata volontaria; si chiamarono per ciascuno dei quattro quartieri due bravi fisici ed un cerusico, retribuiti, quelli con 60 onze l'uno, questi con 20. Agl'indigenti furono concessi sussidî anche in danaro; ed ai morti, esequie e sepoltura. Semplice la burocrazia: un razionale ed un esattore; ben praticamente composta una deputazione di vigilanza per quartiere: il parroco, un cavaliere, un mercante, un forense, il qual ultimo ebbe la direzione del servizio, che per siffatto organamento procedeva pronto ed attivo. Basta vedere il programma viceregio del 21 aprile 1783 per comprendere come i nostri vecchi intendessero la beneficenza pubblica, la quale era nobile gara di carità.
L'Accademia attendeva allo studio del corpo umano. Dodici volte all'anno, nella sua sede di S.a Lucia, vecchi maestri in mezzo a giovani laureati, con premurosa attenzione assistevano alle dissezioni anatomiche. S.a Lucia era la casa che prendeva nome dalla vicina chiesa presso lo Spedale grande (palazzo Sclafani). Oggi essa è una semplice memoria; ma chi s'indirizzi per la via dei Biscottai e, giunto sotto l'arco dello Spedale, volti a sinistra verso la turpe via del Fondaco, scoprirà due basi di pilastri con due aquile palermitane nel mezzo. Quelle aquile, già ripetute anche dentro l'aula, guardano fermamente un sole con la leggenda: Altera felicitas. Era la felicità della protezione senatoria che i medici vantavano? Era l'aspirazione loro a levarsi arditamente a regioni altissime?
Non facciamo ipotesi di simbolismo: e fermiamoci un momento a veder passare qualche accademico che vi si reca per la riunione del mese (novembre 1794).
Questo è D. Paolo Sgroi, che prepara studî sul mal caduco; quest'altro è D. Antonino Bettoni che presto conquisterà la presidenza dell'Accademia, e diverrà medico di S. A. R. in Napoli. Il venerando D. Stefano Pizzoli, sorretto dai giovani Filippo Sidoti e Salvatore di Gregorio, chirurgo l'uno, medico l'altro, viene lamentando i suoi acciacchi senili, e richiamando la sua vita passata. D. Francesco Berna, astro che si leva sull'orizzonte professionale, è circondato da scolari e da amici. D. Carmelo Manzella, discendente da una famiglia di chirurgi, si avanza con D. Giuseppe Tineo, lieto di alte protezioni per meriti non suoi.
A S.a Lucia discutono animatamente. Della epidemia ond'è stato recentemente afflitto il paese (1793) indagano le cause probabili e la mortalità numerosa: ma non riescono ad esser d'accordo. Dopo tanta siccità c'era da aspettarselo che i vapori della terra dovessero infettare l'aria e produrre esalazioni pestilenziali. Il Dr. G. B. Meo, che vi ha stampato sopra una memoria390, non ha dato nel segno; qualche cosa invece ha indovinato D. Gius. Logoteta, medico siracusano, e D. Salvatore Fallica, catanese; perchè in conclusione le febbri putride di Siracusa e di Catania391 sono le medesime di quelle di Palermo, di Cefalù392 e di tutta l'Isola.
Due tra i medici più illustri non si vedono comparire: l'Ab. Meli ed il sac. Salerno.
L'Ab. Meli non è dei più attivi frequentatori dell'Accademia; ma i suoi colleghi ricordano una lettera di lui sopra Gli effetti straordinarii del veleno d'un ragnatelo393. Da alcuni anni il Meli divide il suo tempo tra le visite mediche, le lezioni di chimica e gli antichi e sempre caldi amori delle muse.
Il sac. Dr. Salerno posa come... un principe; e principe fu, dell'Accademia s'intende, e ne volle serbato il ricordo in una lapide a S. Lucia, la quale ora si conserva nella sede dell'Accademia (Posta vecchia), e dice:
Perdoniamogli la vanità, non unica nè rara nel tempo suo. Altro che questo offriva la seconda metà del settecento!
Il Salerno, che andava per la maggiore, cercava qualche cosa di più che l'intervento modesto dei suoi colleghi nella recondita casa di S.a Lucia. Egli voleva la pubblicità: e dove gli mancasse creavasela.
Nel 1789 volle fare una dimostrazione anatomica come non se n'era mai fatta. Ed eccolo in moto per ottenerla nel Palazzo Pretorio. Il Senato non si rifiutò, perchè volentieri coglieva le occasioni per fare atto di presenza.
La «messa in iscena» non poteva essere più solenne per un'accademia! La formavano non solo tutti i medici, non solo tutti i letterati, ma anche i nobili, i Senatori e, solennità straordinaria, S. E. il Vicerè! Se ci fossero stati giornali, che bell'argomento questo per un capo-cronaca! Ci fu però un cronista dei più fedeli, D. Girolamo De Franchis, il quale ne prese nota pel suo Ceremoniale.
Siamo in sul finire del 1789: ed il Capo della Città dirama il seguente nodiglio (circolare d'invito):
Il Conte di S. Marco Pretore la priega volerlo onorare di sua presenza per il 19 del corrente dicembre ad ore 22 nel Palazzo Senatorio in occasione di una dimostrazione angiologica sopra due corpi di uomo e di donna con il di lei feto394 con varie riflessioni che dovrà fare il Principe della Real Accademia dei medici D. Giuseppe Salerno alla presenza del Signor Vicerè, e pieno di ossequio si rassegna.
— «Dimostrazione angiologica!... Oh che vuol significare questo?» si chiedono inarcando le ciglia novantanove su cento profani, nel ricevere questo nodiglio; e nessuno degli invitati manca a questa dimostrazione, tanto stranamente per quanto grecamente aggettivata; altronde l'ora è comoda per tutti: e due ore prima dell'Avemmaria il più stentato chilo è già compiuto.
Ciascuno è al suo posto. S. E. il Vicerè Caramanico siede sopra un'alta predella; Pretore e Senatori, a destra e a sinistra, in semicerchio; dietro nel centro, la Nobiltà del sangue; ai lati del conferente, i medici ed i letterati (e letterati non soltanto erano i cultori di Lettere, ma anche coloro che avevano una certa cultura); nessuno si duole del posto che gli tocca. Di signore, neppure una, perchè il sesso femminile non usa a cosiffatte adunate, e questa poi è angiologica.
Il Principe dell'Accademia, salito sulla cattedra, legge e dimostra su due corpi artisticamente eseguiti il sistema circolatorio. Tutti guardano ammirati quella rete maravigliosa di arterie e di vene; ma qualche medico mormora: «Dopo trent'anni, tanto chiasso...!» E quando la perorazione (la chiama così il De Franchis) è finita, il Senato coi suoi paggi viene accompagnando giù per le scale fino alla carrozza S. E., mentre alcuni medici vanno facendo: «Oh state a vedere che i lavori anatomici di Paolo Graffeo, conservati fin dal 1758 a S.a Lucia, ce li vuol gabellare per novità!...».
— «Sempre lo stesso! esclama spazientito uno di essi. Non dimentichiamo che l'Ab. Salerno è quello che bandì un concorso a premi; distribuì in pubblica adunanza le medaglie ai vincitori, e poi, tornato a casa, se le fece restituire, secondo l'accordo che avea precedentemente preso con essi... Ecco l'uomo nato fatto per gettar polvere negli occhi e vivere in mezzo al fumo!».
I più prudenti tra i professori di medicina sorridono maliziosamente; ma D. Stefano Pizzoli, che oramai non ha più nulla da temere, nulla da sperare da nessuno, conclude: «Colleghi cari, volete il ritratto del D.r Salerno? Leggete Cornelio Gallo:
Laudat praeteritos, praesentes despicit annos.Hoc tantum rectum quod facit ipse putat.
CAP. XXIII.
ACCADEMIE E ACCADEMICI GENUS IRRITABILE...
Lasciata la casa dei Principi di S.a Flavia, nella quale era stata tenuta a battesimo (1718) dal March. di Giarratana, Girolamo Settimo, e da G. B. Caruso, e dove era cresciuta a correzione del brutto andazzo letterario dei tempi, l'Accademia del Buon Gusto nel 1791 veniva accolta, ospitata, sussidiata dal Senato, che ne diveniva così mecenate naturale. Gli osanna degli accademici al Vicerè Principe di Caramanico ed al Pretore Ferd. Monroy di Pandolfina, si confusero coi risentimenti contro il S.a Flavia, che col pretesto di doversi ritirare in Bagheria, avea chiuso loro la sua casa ospitale. Vicerè e Pretore furono generosi nello infondere nuovo vigore all'Accademia; il S.a Flavia parve smentire tutto il suo passato.
Eppure chi dice che qualche grave fatto non possa aver concorso alla risoluzione di lui? La condotta posteriore di alcuni socî non escluderebbe questo sospetto.
Il sodalizio venne riformato di sana pianta, pur tenendosi a base gli antichi statuti. L'aquila senatoria palermitana con uno sciame d'api nel petto ed il motto: Libant et probant, e la leggenda: Accademia palermitana del Buon Gusto. Sub auspiciis S. P. Q. P., ne divenne la insegna. Una lapide fu inaugurata nel Palazzo a memoria della larga ospitalità e dei nuovi auspicî395. Il Principe Gaetano Cottone di Castelnuovo, Presidente, col Direttore, D. Salvatore Di Blasi, il Duca di Vatticani, elogista di Cock, Camillo Gallo, M. Antonio Arena, D. Raffaele Drago cassinese, D. Diego Muzio, D. Vincenzo Torremuzza, l'ab. Meli e quanto di eletto vantasse allora la Capitale, ne furono le colonne più solide; e con essi il cav. Gaspare Palermo, che, carezzato dal Caramanico, non dimenticò, anche vecchio, di essere stato dal predecessore di esso, Caracciolo, chiuso al Castello, perchè creduto autore d'una pasquinata contro di lui.
Le loro letture rappresentavano gli studî in voga. Ad un passo fuori la via che tutti percorrevano nessuno pensava. La via, libera all'estero, era in Palermo ingombra di rovi e di sterpi. Solo ogni tanto qualcuno la batteva con un certo coraggio, e riusciva alla meta senza essersi fatto del male, anzi con la soddisfazione di aver potuto fare un po' di bene. Antonino Fulgo guardava i caratteri del secolo che si avvicinava alla sua fine, e Sergio affrontava il grave problema dell'aumento che avrebbe potuto prendere la rendita generale dello Stato dall'utile impiego delle braccia delle donne396: corsa ardita, che meriterebbe d'essere ricordata agli studiosi dell'attuale mondo economico.
Con le leggi che la governavano, con un prestabilito genere di argomenti per le materie scientifiche e per le letterarie, l'Accademia procedeva tranquilla a furia di dissertazioni su cose ecclesiastiche e discorsi eruditi e letterarî.
Nel regolamento del 1801 erano prescritte riunioni eccezionali con l'intervento del Senato e dei nobili: ma queste erano ripetizioni di altre consacrate nei regolamenti precedenti. La cicalata per l'ultimo sabato di Carnevale non poteva esser nuova se nella Peloritana di Messina essa assurgeva ad un avvenimento mondano di prim'ordine con D. Pippo Romeo. Di cicalate accademiche in poesia parecchie ne recitò il Meli dentro e fuori città, cioè nel Palazzo senatoriale e nel monastero di S. Martino397. Vi erano pure speciali adunanze per la Passione di G. C. e per S.a Rosalia, e vi si invitava non solo, come d'ordinario, il Senato, ma anche la Nobiltà. Una solenne se ne teneva in onore di S. Tommaso d'Aquino, nel convento dei PP. Domenicani, come omaggio degli Accademici al grande teologo di quell'Ordine; ma è curioso che nel riordinamento degli studî superiori della Università la morale venisse prescritta senza il testo di S. Tommaso.
Ora in queste adunanze la partecipazione dei poeti, cercata o profferta, era inevitabile. Questa partecipazione vuol essere intesa per tutte le ordinarie riunioni; e con l'andare degli anni, verso il declinare del secolo, prese il più strano indirizzo.
Come abbiam detto, pubbliche erano le riunioni, con largo intervento di signori nelle sale pretorie. Pel passato quelle sale echeggiavano di lodi a pretori ed a senatori: e molte ne furono dispensate a Regalmici ed ai Trabia. Niente di nuovo perciò che si rendessero ringraziamenti al Senato, emanazione della Nobiltà: ovvero alla Nobiltà medesima, onde il Senato emanava. Il Senato ospitava, il Senato trattava, il Pretore largheggiava di sorbetti verso gl'invitati398. Eppure, o che la misura fosse colma, o che avversioni latenti serpeggiassero, o che i tempi andassero maturando, avveniva tutto il contrario. Il 18 dicembre del 1796 l'ab. Angelo Vinciprova di Nicosia leggeva intorno agli ostacoli che si opponevano ai progressi della letteratura in Sicilia; e nella foga del dire usciva in «una dipintura della nostra Nobiltà la più mortificante, facendo vedere che nessuna sollecitudine si prendeva essa di proteggere i letterati, essendo data perdutamente ai vizî ed al lusso.»
Poche volte furon espresse opinioni con tanta violenza ed inopportunità, quanto stavolta. I feriti si contorcevano sui seggioloni in attesa impaziente che la impreveduta tempesta cessasse; ma ebbero un bell'attendere, chè appena essa accennava a finire che ricominciava più violenta che mai. L'uno dopo l'altro si levano in piedi non so quanti poeti, i quali «snodano le loro voci con sentimenti più satirici di quelli del discorrente, dimostrando coi loro versi che i nostri nobili solamente son dati all'ozio, al sonno e...»
Queste parole con la reticenza finale sono di uno ch'era presente alla scena, Vice-Segretario dell'Accademia, il sac. D'Angelo, che doveva farne e non ne fece verbale, contentandosi di prenderne nota nel suo diario ms. Aggiungeva egli che «un cavaliere era lì pronto a rispondere, ma che ne fu distolto da lui399.»
La notizia di tanto scandalo scende dal Palazzo nelle vie della città, nei caffè, nelle conversazioni, e mentre lo si commenta sfavorevolmente per i bersagliati, si biasima l'atto scortese. Si può esser severi, ma non oltre la misura; l'amore della verità non dispensa dall'ossequio alla buona creanza, specialmente in casa altrui, nel palazzo dell'Autorità cittadina.
Presto la Nobiltà, per mezzo del Pretore, prenderà le sue vendette impedendo la lettura d'un altro discorso, che fa presumere cose poco benevoli per essa. L'avv. Gaetano La Loggia si prepara a nuovi assalti, ma non vuol farsi scorgere; e se non riesce al suo intento, gli è che lo si è invitato a far leggere ad un altro il suo scritto, e poi ad un altro: e ad entrambe le ingiunzioni egli si è rifiutato di obbedire non volendo nè sopprimere nè modificar pensieri e frasi che pure non istà bene ripetere dopo quello che è avvenuto400.
Gli animi sono eccitati, anche da parte del Senato, ed il galateo non è il forte del genus irritabile vatum. L'11 settembre del 1797 ricorre una delle ordinarie sedute. Il Pretore, invitato, non interviene; anzi fa sapere al Presidente che nè ora nè mai, durante il suo pretorato, interverrà più. Lo avviso addolora, ma non istupisce dopo quello che è accaduto; stupisce sì che le sedie della sala siano scarse e che sull'imbrunire non si accendano ancora i lumi. La mancanza del solito trattamento di sorbetti è la necessaria conseguenza. Gli accademici vanno via pieni non meno di disgusto che di scandalo; e ci pensano sopra non sapendosi dar ragione di tanto mutamento per un torto che non è da attribuire a loro. Finalmente uno di essi viene a sapere, e lo confida ad un collega, che lo dice all'orecchio d'un altro, finchè lo sanno tutti in gran segreto: che il malumore del Pretore deriva da un fatto semplicissimo, a cui nessuno avea badato: il Segretario dell'Accademia non ha fatto il regalo che suol fare al Maestro di Casa del Pretore!... — «Sia lodato Dio! esclama come cascando dalle nuvole il Segretario. E non poteva dirlo prima!...» Il regalo fu subito fatto, e le sale pretorie vennero spalancate, le sedie accresciute di numero; il Pretore non mancò più, ed i sorbetti rinfrescarono gli scaldati accademici, lieti della soluzione dello equivoco, che però nessuno, per non recare offesa al Pretore, dovea mostrar di sapere.
L'anno non era ancora finito che altro grave incidente avveniva. Il 10 dicembre il messinese Dr. Giuseppe Palazzo Andronico dissertava sulla necessità della sfigmica in medicina. I soliti nobili non mancavano, non già perchè col sospetto di nuovi scandali a danno loro, volessero respingerli con la forza, ma perchè volevano vedere come andassero a finire queste bizzarre adunate accademiche, oramai avviate con sì cattivo gusto. Per eccezione, vi erano molti medici. Andronico legge; complemento della sua lettura è la recita di versi di poeti (chiamiamoli così per intenderci) presenti. Quasi si tratti della cosa più naturale di questo mondo, essi lanciano a bruciapelo contro la medicina e l'Andronico una filatessa di contumelie; e quando Onofrio Jerico, sempre inappuntabile nel suo giambergone verde, nel suo parrucchino, nel suo splendido anello dottorale, conchiude con una ultima brutale carica contro i medici, tutti rimangono come interdetti e non sanno che fare401.
Oh perchè questa piazzata?
C'è un certo dietroscena, che vuol esser messo in luce.
Questo Dottor Andronico nel 1795 chiese alla Deputazione degli studî la istituzione d'un insegnamento di Sfigmica come parte di quello più largo di Medicina interna. Era troppo anche allora, che si mancava di ben più utili insegnamenti: e la Deputazione si rifiutò. L'Andronico trovò chi si adoperasse a favore della sua Sfigmica: ed il Vicerè concesse, a titolo di esperimento, la sollecitata specialità402. Il neo-professore voleva persuadere della necessità di essa; ma del suo avviso non erano gli studenti, i quali molto studentescamente e poco studiosamente non sapevano rassegnarsi a distinguere settanta maniere di battiti del polso, quanti ne voleva ammettere od infliggere l'Andronico. Altronde, egli non era palermitano. E com'era supponibile, col vento che ancora spirava contro Messina, che un messinese venisse ad insegnare una scienza ai Palermitani? Inde irae. Un anno dopo della chiassata, l'Andronico veniva esonerato.
Passiamo ad un'altra Accademia.
Nella libreria pubblica, dove si fanno i Congressi Letterarii di storia siciliana, il dì 5 aprile 1793 ad ore 22, reciterà un discorso sopra le chiese di Palermo il sac. D. Giovanni d'Angelo.
Questo invito stampato e ms. ricevevano pochi giorni prima della data indicatavi i membri della Società per la Storia di Sicilia403: e tutti lo tenevano. Ad essa erano ascritti i più colti studiosi dell'Isola, i quali vi portavano fervore di patriottismo e pazienza di ricerca.
Alla lettura del D'Angelo furono presenti, oltre un buon numero di amatori, i due Di Blasi, il Gregorio, l'Angelini, Bibliotecario della senatoriale, il Barone Forno, il Morso, il Di Chiara, l'arcidiacono Dini, D. Camillo Genoese di Caltanissetta, il Conte D. Vincenzo Castello, figlio di Gabriele, il sac. D. Francesco Polizzi, Decano della Magione, ed il giovanetto Duchino di Camastra, assidui frequentatori della Società.
La erudizione del bravo letterato palermitano può ora ammirarsi nella Biblioteca, della quale egli fu per lunghi anni attivo impiegato e, come l'Angelini, consigliere sapiente di quanti la frequentassero. Quel che risulta dai verbali delle riunioni è questo: che per ventisei anni (1777-1803), meno brevi intervalli, essa attese ad illustrare le vicende della chiesa in Sicilia e delle chiese siciliane, e quelle delle lettere: punto di partenza per aggiunte e correzioni alla Sicilia sacra del Pirri e alla Biblioteca sicula del Mongitore. Perciò, quasi tutti ecclesiastici i cooperatori. Lunghe le loro memorie, inesauribili in una sola seduta, alcune protraentisi per cinque, sei, non sappiamo se tra la fissa attenzione di tutto l'uditorio, ma certamente con utilità della storia ecclesiastica e letteraria dell'Isola. Alla specialità degli argomenti, alla non sempre ornata trattazione di essi, come al non facile intervento del gran pubblico, devesi lo svolgimento sereno degli studî e delle adunanze, non turbate mai dalla presenza di volgari poetastri e di saputelli aggiusta-mondi. E chi volete che andasse a mescolarsi tra tanti ricercatori di vecchie carte? i quali dopo di avere sgobbato sopra registri di parrocchie, pergamene di conventi e monasteri, cartabelli di confraternite, marmi, iscrizioni, monumenti, portavano il frutto delle loro investigazioni, forse non sempre aliene da preconcetti e da illusioni, ad un paio di dozzine di ascoltatori?
Eppure essi se ne contentavano; amavano gli studî per gli studî, il bene per il bene; non cercavano plauso di nessuno, non sognavano gioie di pubblicità; e dopo di essersi tanto affannati in induzioni pericolosissime lasciavano inediti in mano dell'Angelini i loro manoscritti, paghi di averli compiuti e partecipati ai pochi che potevano comprenderli e tenerne conto. Zelanti cercatori del passato, che non guardavano alla miseria del presente, se interrompevano il corso dei loro congressi lo facevano solo perchè avvenimenti impreveduti e straordinari li impedivano, come la epidemia del 1793, i timori di pubblici disordini dopo la sventata congiura del Di Blasi; la notizia del trattato tra S. M. Siciliana e la Repubblica francese, la tristezza della raccolta forzosa dell'oro e dell'argento per le spese della guerra nel Napoletano (1796-98), e perfino i rigori invernali404.
L'ardore col quale si attendeva agli studî di storia di Sicilia saliva al parossismo per quella del dialetto.
Altra società di cultura l'Accademia siciliana sorgeva nel 1790 sotto gli auspicî del Meli e per iniziativa del giovane giureconsulto F. P. Di Blasi.
Il titolo non dice tutto. L'Accademia sosteneva non doversi scrivere nè parlare altrimenti che in siciliano: siciliane le poesie, siciliane le prose, siciliane — è tutto dire — le leggi dell'istituto; le quali venivano dettate dal Meli in persona. Il Principe di Trabia, il Conte di Torremuzza, il Marchese di Roccaforte, il Principe di Furnari, nei ventott'anni di fortunosa esistenza di essa vi presero parte attiva, e l'accolsero nei loro palazzi; giacchè sempre nuovo godimento era pei patrizî intelligenti trovarsi in mezzo a dotti, e riceverli nelle loro case.
Un cronista d'oggi farebbe sapere che questi bravi signori, volta per volta facevano servire di lauti rinfreschi gl'illustri intervenuti; noi, che non siamo cronisti e non iscriviamo per giornali, non ne diremo nulla. Peraltro è risaputo che a quei tempi non si riceveva mai dai nobili senza splendidi trattamenti eseguiti da servitori in livree fiammeggianti; non supporlo poi nelle sale di quei fiori di ospitalità e di dovizia, sarebbe un'offesa alla generosità loro.
Gueli ed Alcozer, Scimonelli e Francesco Sampolo, La Manna e Calì, Catinella e Mondino furono i campioni della nuova Società. Meli, Presidente, vi lesse a riprese varî sonetti, che rappresentavano le vicende non liete del sodalizio. Il seguente è l'indice di quel che pensassero i socî; tra i quali, per altro, ve n'erano, come il p. Michelangelo Monti, non isolani.
Il giovane Sampolo, in un discorso, s'intende, tutto dialettale, avea recitato le lodi della lingua siciliana; ed il Meli, entusiasta, recitava:
Viva la nostra lingua, Iddiu la guardi!Amàtila, e 'un circati 'na matrigna:Sia cura e triddu di muli bastardiLu zappari di l'esteri la vigna.L'istintu di natura anchi a li pardi,Anchi a li tigri stu duviri insigna;Urla lu lupu quannu à fami o s'ardi,Nè s'impresta lu gergu di la signa.Lu sulu pappagaddu 'nfurgicataS'avi 'na lingua pri parrari a matti,Facennu d'acedd'omu capriata.Multi Accademj eu sacciu accusì fatti,Grec'-itali-latini. AllurtimataChi aviti 'ntisu? 'Na sciarra di gatti405.
Il lettore che sa di storia letteraria di Sicilia può farci qui un appunto cronologico. Il sonetto del Meli è del 1805, e l'Accademia era nata quindici anni prima.
Accettiamo il disappunto, e torniamo indietro. Noi facevamo quella citazione solo per mostrare quali fossero gl'intendimenti dei «sicilianisti» di allora. Ma tornando indietro, non troviamo meno siciliana l'Accademia. Bambina di due anni, il 18 ottobre 1793, essa per bocca del più forte poeta del tempo dopo il Meli, benchè del Meli non entusiasta, non balbettava, ma con franca parola esprimeva i sentimenti che l'animavano. Questi sentimenti sono d'una profondità impareggiabile. In un'ode saffica Ignazio Scimonelli cantava:
Nun mettu peccu a Grecu o Germanisi,Nè a Turcu o Francu, a Latinu o Spagnolu,Ma bedda carta mi cunta in cannolu:Lingua e paisi.E pri sta lingua sugnu tantu vanu,Chi mortu, e prima d'essiri urricatuLu miserere lu vogghiu cantatu'n sicilianu.Sarrà in latinu ben fattu, ben dittu,Ma un miserere in lingua nostra misuL'arma mi la fa jiri 'n paradisudrittu pi drittu.
Si vede subito che qui neanche di straforo ci entra la politica e la teologia; perchè, anche per semplici allusioni nè il Re nè Dio dovevano esser nominati: qualche cosa di meno del parum de principe, nihil de Deo.
Nel medesimo tono rimanevano altri poeti. Il sac. Catinella, che abbiamo incontrato in altre occasioni, sfolgoreggiava di motti vivacissimi. Tra i più felici son quelli nei quali egli voleva dimostrare la superiorità della siciliana su qualunque altra lingua. In un sonetto mandato al sac. Giovanni Luisi, poeta anche lui, si sbizzarriva sulla ricchezza dei modi proprî e figurati onde può esprimersi il verbo fujiri = fuggire, in questi termini:
Li cani si chiamau; si la sbignau;Si la sulau; lu stigghiu si cugghiu;Già pruvuli di bottu addivintau;Santi pedi, ajutatimi; spiriu.Sticchia e vassinni; a curriri appizzau;Si l'allippau; marciau; si la battiu;Si la filau; la coffa si pigghiau;Addivintau diavulu; partiu.Sti modi ed autri lu SicilianuLi 'mpasta, li rimpasta, e cancia e scancia,Eh! chi lu diri nostru è supra umanu.L'havi sti cosi la Spagna, la Francia?L'havi lu 'Nglisi? l'havi la Tuscanu?Ch' hann'aviri! la pesta chi li mancia!
L'amico Luisi non si maravigliava affatto dei diciassette sinonimi cuciti dal Catinella; si maravigliava invece che egli ne avesse dimenticati parecchi altri: e in sonetto responsivo li enumerava a gloria della «sicula lingua»406.
Altri esempî non occorrono a confermare la piena convinzione di questi bravi accademici; i quali — per dir tutto — erano tra i più illustri letterati del tempo. Aggiungeremo non pertanto un fatto molto acconcio a confermare il culto singolare che si professava pel dialetto.
Nel Giornale di Sicilia del 9 dicembre 1794 un anonimo scriveva lodando il parlar materno (il siciliano), e raccomandando il toscano come lingua per tutti. Questa osservazione semplicissima provocava una violenta risposta nel medesimo giornale. Altro anonimo prendeva per nemico della patria il lodatore del toscano, e questo era costretto a scagionarsi dall'accusa407.
Non era argomento da pigliare a gabbo.
I componenti dell'Accademia siciliana non per nulla erano accademici. Essi avevano tutte le miserie della loro razza. Noi li abbiam visti a fare il chiasso, anche per un nonnulla, nel Palazzo senatorio. Ebbene: se non peggio, lo stesso facevano all'Accademia. Il bello è che i principali agitatori eran quelli che catoneggiavano per mettere il bavaglio ai tribuni. La è sempre così: quelli che si atteggiano a vindici delle violenze altrui sono i più violenti; così avviene che parlano sempre di onestà molti di coloro che della onestà non sono i migliori amici.
Quando, dopo la decapitazione del Di Blasi, la Società venne soppressa, di lei non si parlò più altro che per vederla ricostituita. Il March. di Roccaforte l'ebbe nella sua casa, ed il Meli ne trasse lieta ragione a prospero avvenire. Le sedute si ripresero; ma in qualcuna di esse si sicilianizzò troppo di allusioni e di equivoci408.
Questi accademici un giorno vennero fuori con una proposta letterariamente liberticida: qualunque componimento poetico da leggersi in pubblica adunanza doveva prima sottoporsi alla censura preventiva d'una commissione. Non bastava quella del Governo per la stampa, se ne voleva creare un'altra per la lettura!
Con questo colpo di stato anche i grandi dovevano passare sotto le forche caudine dei piccoli. Gli stessi Meli e Scimonelli non avrebbero potuto sottrarvisi. Meli, Presidente perpetuo, ne sorrise; altri vi si acconciarono. Gli screzî, già alle viste, entrarono in campo; le bizze degenerarono in liti da partito; e l'Accademia corse il pericolo di andare a monte. Il venerando Meli interponeva la sua autorità: e a questi raccomandava la calma, a quelli il rispetto: non esser possibile procedere di questo passo; andarci di mezzo la serietà degli studî, l'interesse della patria lingua; grande lo scandalo di tante pretese; necessaria la buona volontà in tutti per un accordo che cementasse la pace. Ma il buon vecchio avea da fare con gente irritabile, anche perchè composta di poeti novellini e presuntuosi, e non riusciva a riconciliarli nè a farsi sentire. Allora, perduta la pazienza, li manda a carte quarantotto con un ultimo sonetto intitolato al Conte di Torremuzza «contro alcuni poeti siciliani», i quali, irrequieti e villani, non sapevano stare in pace tra loro nè con gli altri:
Scuvai di puddicini 'na ciuccata;E allura li sintii ciuciuliariCu la scorcia a li frinzi 'mpiccicata,Mi lusingai chi mi nn'avia a prigari.Ma ora ch'ànnu la cricchia già spuntataSi mettinu 'ntra d'iddi ad aggaddari,Nè trovu a cuntintarli nudda strata,Nè 'nsemmula, nè suli vonnu stari.Cerca ognunu cumpagni a sulu oggettuDi putiricci dari pizzuluni;Dicinu chisti: Appara tu, ch'eu mettu.Cui s'arrisica starici in comuni,Si a mia chi pri accurdarli m'intromettu,Pri la facci mi tiranu a sautuni?O Conti miu patruni.La Censura, pri quantu iu viu e sentu,È di pizzuliari lu strumentu.Da chistu iu ni argumentuChi pri cuitari sti sautampizziLu menzu è ditagghiaricci li pizzi409.
Gli studiosi di calembours troveranno stupendo l'ultimo verso.
CAP. XXIV.
PATRIOTTISMO DEGLI STUDIOSI. L'AB. CANNELLA. DISPUTE FILOSOFICHE E TEOLOGICHE. STORICI, LETTERATI, POETI.
La vita ristretta che le condizioni d'allora imponevano non poteva non creare cultori di discipline di argomento siciliano. La Sicilia stava in cima ai pensieri, agli affetti d'ogni studioso; era la nazione e la patria. Al di là del suo mare, altre nazioni, altri popoli: il regno di Napoli, la repubblica di Genova, quella di Venezia, lo stato di Milano ecc., rappresentati nella Capitale, nella urbe, dalla nazione napoletana, dalla genovese, dalla veneziana, dalla milanese e da altre che mettevano capo ai rispettivi consoli, e con essi alle chiese di lor proprietà ed esercizio. C'era S. Giovanni pei Napoletani, S. Giorgio pei Genovesi, S. Marco pei Veneziani, S. Carlo Borromeo pei Lombardi, la confraternita dei quali avea sede nella parrocchia di S. Giacomo la Marina.
Carattere spiccato quindi la sicilianità della cultura storica, tanto nella sostanza, quanto nella forma.
Nel precedente capitolo abbiam veduta questa sicilianità spinta all'eccesso sul finire del secolo. Possiamo frattanto gli occhi sopra un libro qualsiasi di erudizione, di antiquaria, di storia propriamente detta, del tempo. Vi troveremo sempre la Sicilia nella sua geografia, nelle sue vicende passate e nel suo presente. I suoi monumenti pagani come le sue reliquie cristiane, i suoi castelli come le sue chiese, gli avvenimenti di tutta l'Isola come i fatti di una religione di essa, delle sue grandi città non meno che dei suoi piccoli comuni, delle sue istituzioni, delle sue leggi, dei suoi uomini insigni per carità, per ingegno, per valore: tutto era argomento di ricerche per un buon patriota.
Noti il lettore che il patriota d'allora non era il patriota d'oggi; il quale, se falso, vanta servigi non mai resi alla patria, o incombenze non mai ricevute o disimpegnate: vanti e lustre onde si sale ad alti e ben rimunerati ufficî. Era bensì patriota chi amava operosamente la terra natale, chi ne amministrava disinteressatamente gli istituti, chi beneficava i poveri, chi celebrava i fasti della sua terra, e chi di essa procurava in ogni maniera lo ornamento ed il lustro.
In questo significato giunsero a noi come patrioti di fama illibata un Monsignor Ventimiglia, che i suoi libri donava alla città di Catania, ed in Catania istituiva un ospizio pei poverelli; il Principe di S. Vincenzo Alessandro Vanni, che efficacemente cooperava alla fondazione della Biblioteca Comunale di Palermo; Mons. Gioeni dei Duchi di Angiò, che liberalmente fondava il Collegio nautico, assegnava quattordicimila onze (L. 178,500) all'Albergo dei poveri, ed istituiva una scuola di Filosofia morale e civile legando premî annuali ai giovani che in essa si segnalassero, ed un catechismo faceva scrivere e largamente e gratuitamente diffondere ad istruzione del popolo, ed i suoi libri donava alla Città (vedremo più oltre il lato debole di questo patriota). Patriota quel Pietro Lanza Principe di Trabia, che, come abbiamo veduto, primo concepiva (1786) una scuola di agricoltura con un campo agrario nell'ex-podere gesuitico della Vignicella: proposta tutta moderna, che poi con le proprie sostanze traduceva ad atto il Principe di Castelnuovo con l'Istituto agrario che prende nome da lui410. Patriota infine, per non perderci in una rassegna fortunatamente larga, il Marchese di Villabianca, che solo raccoglieva ed illustrava tanta e così diversa e svariata materia di erudizione siciliana quanta non ne poterono mai, se ne togli il Mongitore, parecchi studiosi, e che da tanto tesoro staccavasi in vita, facendone dono alla sua terra diletta.
La storia nostrana pertanto avea grande attrattiva per gli uomini più eletti. Ad essa come raggi che convergano al centro inclinava chi non preferisse coltivare una scienza, o chi non amasse perdersi dietro le evanescenze della fantasia. Anche poeti come lo Scaduto vi trovavano ispirazione a poemi epici ed a canti lirici. Le tradizioni del Fazello, del Barbieri, dell'Inveges, del Paruta, dei due Di Giovanni (Vincenzo e Giovanni); gli esempî degli Amico (Antonino e Vito), di G. B. Caruso, del Mongitore, erano stimolo a chi inclinasse a continuarli. In un medesimo tempo fiorivano, nella sola Palermo, col citato Villabianca il Testa, i fratelli Di Blasi, Gabriele Castello di Torremuzza e R. Gregorio: sei tra una pleiade di benemeriti delle sicule memorie.
Il Testa, premorto a tutti (1775), scriveva di Guglielmo il Buono e di Federico IIº d'Aragona, ed ordinava i Capitoli del Regno. Il Villabianca consacrava la sua attività giornaliera al suo Diario palermitano, che si chiudeva il mese della sua onorata esistenza (1802): e lasciava il Palermo d'oggigiorno, la Sicilia nobile e centinaia d'opuscoli siciliani, dove la pazienza delle investigazioni fa perdonare il difetto della critica e la vanità puerile.
G. Evangelista Di Blasi con la Storia dei Vicerè di Sicilia, preludeva alla ponderosa e troppo diffusa Storia di Sicilia (1811). Il periodico di Opuscoli di erudizione, in venti volumi, durato fino al 1778 a cura di Salvatore Di Blasi, veniva seguito dall'altro congenere di Nuova Raccolta.
Dalla teologia e dalla letteratura il Gregorio passava alla storia ed alla diplomatica, e nel tranquillo presbiterio di S. Matteo nel Cassaro, solo e senza maestri, sudava ad imparare la lingua araba, nella quale si levava maestro così esperto e sicuro da strappare la maschera all'Ab. Vella. Dai tempi del Caracciolo in poi, nell'annuale Notiziario di Corte scriveva di geografia e di storia naturale, di tasse e di traffichi, di derrate e di commerci, di monumenti e di artisti dell'Isola. Nessuno prima, nessuno dopo di lui seppe meglio adombrare il perfetto modello di una storia civile. Componendo in sè il giurista e lo storico, il letterato ed il filosofo, si preparava a dar fuori un'opera sul Diritto pubblico siciliano; ma come parlare di questo in un paese ove ministri servili trepidavano per tutto ciò che nella esaltata loro fantasia apparisse sospetto alla regia prerogativa? onde il censore del manoscritto ne mutava il titolo originale nell'altro di Considerazioni sulla storia di Sicilia, come se il titolo mutasse la sostanza! E non si guardava all'alto concetto di «una delle più profonde opere che in questi ultimi tempi fosse stata scritta in Italia»411.
Il Principe Gabriele Castello di Torremuzza dopo indagini pertinaci metteva fuori la sua Sicilia Numismatica e le monete delle isole adiacenti alla nostra. Ovunque egli passasse, lasciava traccia di sè: presso Porta d'Ossuna, nell'Orto del Barone Quaranta, dove scopriva antiche catacombe a tutti ignote; all'Ospedale grande, all'Accademia degli studî, al Tribunale del Commercio, tre istituti che l'ebbero deputato e giudice; a Segesta, dove restaurava il tempio; a Girgenti, ove disgombrava sovrapposizioni cristiane al tempio della Concordia e faceva restauri a quello di Giunone Lucina.
Questi ed altri dotti, tipi di cavalieri antichi, modelli perfetti di sacerdoti e di amministratori, noi li abbiam visti nei sodalizî intellettuali attendere alla illustrazione delle cose patrie, al progresso delle scienze e delle terre, allo studio del natio idioma. Noi siamo stati presenti a qualche loro adunanza, e abbiamo visto che anch'essi, ahimè! questi uomini egregi, aveano le loro debolezze. Ma anche fuori sodalizio, essi non erano esenti dai difettucci che un arguto scrittore sardo del sec. XIX, Giuseppe Manno, dovea battezzare: Vizi dei letterati. Il minore dei Di Blasi, regio storiografo, non seppe perdonare a Mariano Scasso la pubblicazione d'una versione italiana del de Burigny. L'opera per manco di sussidio di monumenti e di documenti, per errori di fatti che la scoprivano al critico più modesto, era a dir vero difettosissima; ma il Di Blasi oltrepassò il segno. Il suo altezzoso giudizio scese alle minuzie e trascese in biasimo astioso.
Quello spirito irrequieto che fu l'ab. Salvatore Cannella, tornando dalla Francia, dove l'arditezza delle opinioni avealo sbalestrato, in una opericciuola di Portraits espresse certi suoi giudizî sopra i maggiori scrittori siciliani della fine del secolo412. Quei giudizî sono un misto di buono e di cattivo; e lo Scinà, pur non nascondendo la sua simpatia per l'autore, ebbe a dire: «In questi ritratti il Cannella diede di mano alla metemsicosi e fece delle trasformazioni. Mise in Meli l'anima di Anacreonte e di Teocrito, e nel Gregorio quella dell'Algarotti; mutò il cieco Marini, professore di rettorica, in Suderson, Scasso in Montaigne, Fleres in Malebranche e Carì nel Fontanelle della Teologia»413.
Come venisse accolta la galleria di ritratti del Cannella non sappiamo. Certo, i contemporanei non ne parlarono quanto i posteri; i quali, a corto di notizie personali di certi uomini grandi e piccoli, presero i Portraits come documento di storia letteraria; però nè Meli, nè Fleres, nè Scasso, nè Carì, solo per quella apoteosi di persone, credettero toccare il cielo col dito: ed il Cannella rimase quel che era: guardato in cagnesco dall'autorità chiesastica (la quale non poteva dimenticare certo suo ardito discorso contro il celibato, fortemente combattuto dal p. Leone) e sospettosamente dalla governativa, che ne seguì la fuga in Francia; con diffidenza dal pubblico grosso e dai dotti, i quali videro in lui un corruttore della gioventù, un novatore infranciosato, un mal dissimulato volterriano. Ai dì nostri egli sarebbe stato un grand'uomo per la facilità dell'ingegno ed i principî avanzati, che son solida chiave ad aprire le porte d'un giornale, specie se il Cannella si fosse deciso a smettere l'abito talare, e più ancora a far pompa d'una moglie presa in barba al celibato. Tale però non fu di lui. L'avversa fortuna gli tolse di conseguire un bene qualsiasi; e quando egli si affissava speranzoso in essa; una trave dello steccato dei fuochi artificiali della Marina, per le feste di S.a Rosalia, gli troncò la vita. Un epigramma corse allora in bocca di lui:
Non fu la trave no che mi ferì:Fu la mano di Dio che mi colpì.
E fu ripetuto che Pio VI, infastidito delle bricconate di Cagliostro (G. Balsamo) e della fuga dello Ab. Cannella dalle mani dei gendarmi pontifici, usasse dire: La Sicilia mi ha regalato il balsamo e la cannella!
Ora qualche pagina di quel libriccino è una sicura sintesi delle condizioni letterarie del tempo; e l'ultima vuol essere riportata:
«La nostra piazza non è ancora accreditata: e da noi non si trova un libraio che voglia spendere. In Sicilia le Lettere non sono un mestiere come altrove. La Teologia, la Giurisprudenza, la Medicina assorbono tutto. I nostri accademici ci opprimono a furia di sonetti. Premî pubblici mancano: e noi ci occupiamo di bazzecole e di dispute scolastiche. Il giansenismo ed il molinismo ci han divisi in due fazioni e mentre fuori si ride dei due sistemi, qui diamo loro una grande importanza. Altra setta, quella dei Miceliani, ci faceva girare la testa: sicchè noi non c'intendiamo più; ed intanto che il Cento ed il Natale, sostenitori di Copernico e di Leibnizio, eran proscritti, ed il Carì tremava per avere scherzato sulla scienza moderna, il furore gesuitico lo perseguitava dovunque»414.
Per quanto breve e leggiera, questa pagina può servire a punto di partenza per comprendere l'ambiente letterario d'allora.
E anzitutto: è innegabile che in Sicilia non si conoscesse neanche di nome l'ufficio di editore nel senso moderno della parola e in quello che in Francia avealo trovato l'Abate Cannella. Uno studioso che avesse consumata la miglior parte della sua vita nella composizione d'un'opera, tutto poteva sperare fuori che questa gli venisse stampata da un libraio. Poteva bensì sperare, e trovava talvolta un protettore che generosamente ne pigliasse sopra di sè la spesa: ed allora era ben naturale che la dedica fosse fatta al mecenate; anzi è da credere che la dedica fosse leva della operosa benevolenza, o che la benevolenza preludesse alla dedica. Molti dei libri che nel frontespizio portano anche in caratteri modestissimi col nome dell'autore quello d'una persona alla quale il libro è dedicato con titoloni e lodi straordinarie, possono ritenersi fatti a spese di costui.
Giova però avvertire che non di rado interveniva il Governo e che libri d'indiscutibile valore, d'indole strettamente siciliana, o che facessero agli interessi del pubblico, vedevano la luce per sola ed efficace opera del Governo, nella Stamperia reale.
Vedevan la luce; ma viaggiavano? Ecco il punto che dovea disarmare gli autori. Giacchè, per quanto essi si adoperassero a far conoscere i proprî lavori fuori Sicilia, in Italia, non riuscivano se non a risultati molto meschini. Occorrevano larghe conoscenze e aderenze forti; le une e le altre, anche se conseguibili, frustrate dall'isolamento del paese, dalla lontananza dai grandi centri intellettuali, dalla poca inclinazione del gran pubblico alla cultura, dagli ostacoli che ad ogni passo sorgevano, mano mano che uomini e cose avvicinavansi alle barriere degli staterelli ond'era divisa l'Italia, e, nel finire dei secolo, dalle vertiginose vicende politiche.
Il tempo dei Vicerè spagnuoli era passato, ma anche in quello dei Vicerè italiani, del Fogliani p. e., di quanto si avvantaggiarono in proposito le condizioni letterarie? Solo sotto il Caracciolo le cose cominciarono a mutare aspetto, ed il Caramanico stimava gli uomini d'ingegno ed amava circondarsene. Non pochi poterono venire in fama per protezione del suo predecessore e di lui, che veramente faceva anche in letteratura, come gli altri Vicerè in politica e in amministrazione, la pioggia ed il buon tempo. Accennando al po' di bene che agli studî apportava il Caramanico, studioso tra studiosi, il Bartels però osservava: Se il Vicerè non riconosce la dignità delle opere dei dotti, se non cerca di mettere questi in relazione con quelli di altre nazioni, se non aiuta il commercio dei libri e non rende agevole la loro pubblicità, non ci sarà nulla da sperare. Aggiungeva poi una osservazione, che, presa assolutamente, è falsa; ma che può esser vera solo in parte, e con certe riserve. I baroni del Regno, diceva, temono le conoscenze filosofiche e storiche e cercano di distruggerle415.
Con la mancanza assoluta di editori, con la difficoltà di trovar favore presso il Governo, con la censura preventiva e le lungherie per l'approvazione di stampa, faceva contrasto il numero dei librai, che neanche oggi si hanno. Nicola Volpe presso la chiesa di S. Nicolò Tolentino; sotto il palazzo Comitini, la U. Stamperia, che avea un fondo di libri in vendita; i fratelli Martinon sotto il palazzo del Marchese Drago; poco discosto, presso il Monastero del Salvatore, D. Tommaso Graffeo; più in alto, di faccia al Collegio Massimo, il Rini; poi la Nuova Libreria all'Insegna della Verità, e quella del Giaccio ai Cartari, e quella di Filippo Perrotta ai Cintorinai, viveano di siffatto commercio (1794).
Interminabili le dispute filosofiche e teologiche, nelle scuole superiori di scienze umane e divine: le accademie, i seminari ecclesiastici, i conventi battagliavano in sostegno d'uno o d'un altro sistema. Le antiche ire suscitate tra i Gesuiti per la difesa di quello di Leibnizio, svolto in versi italiani dal March. Natale416, più presto che avversari avea tra gli studiosi creato amici alla trionfante scuola Wolfiana. Il colpo mortale dato dal giovane pensatore alla scolastica era stato improvvidamente riparato dal S. Uffizio con le vessazioni al poeta e con la condanna del libro di lui. Per dirne una sola: i Cassinesi di S. Martino nella loro chiesa di S. Spirito in Palermo aveano pubblicamente, solennemente affermato le loro opinioni leibniziane nei giorni appunto che il famoso Tribunale venivale riprovando. La lotta tra il vecchio ed il nuovo proseguivasi forte, anche dopo lo allontanamento della Compagnia di Gesù, e non pure in Palermo ma anche in Catania. Leonardo Gambino leibniziano, protetto da Mons. Ventimiglia, soppiantava il medico-filosofo Agostino Giuffrida, nemico implacabile di Leibnizio, del quale si facean campioni arditi nella Capitale Niccolò Cento, Vincenzo Fleres e Simone Judica.
La soppressione del S. Uffizio infondeva vigore novello alle menti di questi e di altri pensatori. Gli esemplari della Filosofia Leibniziana del Natale, sfuggiti fino allora agli occhi lincei degli Inquisitori, ricomparivano, non più timidamente, alla luce, ridestando assopiti entusiasmi, e con essi inveterati rancori; ma questi venivano da quelli soverchiati, ed il nome del già reprobo Natale, nei chiostri, nelle accademie, nei ministeri del Governo correva per le bocche di tutti.
Frattanto, mentre in Terraferma, smarritesi le tradizioni della filosofia italiana, si correva dietro al sensismo francese, in Monreale si facevano strada le dottrine di Vincenzo Miceli, condivise da compagni e da scolari devoti di lui. Ma quelle dottrine incontravano pure energica, gagliarda opposizione. Miceli, che in patria era un novello Pitagora, si confondeva in Palermo con Spinoza; Miceliani e Spinosisti, messi dagli avversarî in combutta, venivano, siccome nemici d'ogni principio morale, assaliti. L'accusa si estendeva anche a Niccolò Spedalieri, il quale come maestro di sacra Teologia in un seminario cattolico (Monreale) era posto in mala voce; il che dovea al futuro scrittore dei Diritti dell'uomo dar occasione della sua partenza per Roma. Preti e frati dentro Monreale e Palermo si arrogavano il diritto di privativa di sistemi con la relativa infallibilità di giudizî, convertendo così il campo sereno della discussione in arena di lotte infeconde. A S. Martino lo storico Evangelista Di Blasi si accaniva contro le teorie miceliane; le quali, d'altro lato, a Monreale il benedettino Gaspare Rivarola sosteneva totis viribus anche a pericolo di comparire ribelle ad una delle maggiori autorità. Tesi teologiche dibattute favorevolmente alla presenza di due Arcivescovi dagli scolari dello Spedalieri, vietate in Palermo, potevano stamparsi in Roma: contraddizione evidente, che faceva dubitare delle ragioni della verità. In Toscana, secondo gli umori dei critici, il Di Blasi era seguito o abbandonato: più d'uno appassionavasi alle polemiche vivaci; e coronava l'opera in Palermo l'Ab. Meli con un epigramma, divenuto celebre, il quale gettava il ridicolo sopra le file dei partigiani del forte pensatore, dopo la cui immatura morte essi avevano divulgato un ritratto col semplice cognome Micelius.
L'epigramma era una ricetta per la composizione del sistema miceliano:
Recipe di Miceli la sustanzaModificata beni cu l'essenza;Poi l'essenza, li modi e la sustanzaLi cummini, e n'estrai 'na quinta essenza;Poi 'mbrogghia arreri l'essenza e sustanza,Riduci la sostanza ad un'essenza;Cussì 'ntra modi, 'ntra essenza e sustanzaTruvirai d'ogni scibili l'essenza417.
Contemporanee a queste velleità nella ricerca del Vero son quelle della cultura del Bello. Non per un solo decennio (1770-1780), come porta la fama, ma per un periodo più lungo ancora, si fecero vive, per impulso del Principe di Campofranco, certe tendenze ad una letteratura leggiera, francesizzante. Avea essa carattere di galanteria e manifeste inclinazioni all'untume enciclopedico, buono a far comparire dotto chi non lo era, o molto istruito chi lo era poco.
Lo Scinà si mostra costantemente avverso a questa evoluzione letteraria; tuttavia non nega che l'allettamento della nuova maniera onde si presentavano scienze e lettere, dovea per la sua inusitata piacevolezza invogliare agli studî spargendo una superficiale cultura, che ripuliva ed ingentiliva la nazione418. Si sarebbe potuto occupare di cose serie, è vero, ma fu un bene che di qualche cosa si fosse occupato e qualche elemento d'istruzione e di cultura avesse cercato di far gradire.
Ma non perdiamo di vista i Portraits del Cannella.
Col Sergio e col Balsamo, con frate Bernardino da Ucria e col Chiarelli, col Controsceri e con lo Spedalieri troviamo da lui ammirati il Giarrizzo, il Sarri, il Piazzi ed un'altra dozzina di personaggi, non tutti egualmente illustri. Meli, degli altri poeti onore e lume, vola come aquila sui contemporanei: e gli vien dietro l'ab. Carì. Il teatino Sterzinger è onore della bibliografia; De Cosmi, dello insegnamento e della sacra oratoria.
Mentre da tutti si guardava come mestiere il commercio, Sergio lo studiava come scienza, e primo avea il coraggio di proclamare i pregi dell'agricoltura, e di parlare del lusso moderato delle nazioni, della necessità delle pubbliche strade, della polizia della marina di Sicilia, del modo di tirar la seta dai bozzoli del filugello con piccole ruote; e raccomandava ai magistrati le nuove arti da introdurre tra noi. Amico del Genovesi, scriveva a lui del vantaggio che le scienze esatte potevano trarre dal commercio. Bartels che lo conobbe ne lodava la mente aperta ed attiva, ma preoccupata: segno forse della coscienza che egli avea del suo valore, non da tutti compreso, da pochissimi eguagliato419.
Caratteristica la figura di Mariano Scasso, sulla quale piacquesi di barzellettare anche il Meli. Ingenuo nel credere, inabile a combattere le altrui opinioni, D. Mariano dava ragione all'ultima da lui udita, quando non cercava di conciliarle tutte senza accorgersi che non ne accordava nessuna; e cedea alla mobilità fantastica del suo spirito secondo l'ambiente nel quale si trovava; sicchè,
Sulu lu movìnuL'oggetti intornu:'Na donna, un cavulu,Un servu, un cornu.
Godeva fama di molto sapere e se ne invaniva come di merito eccezionale: il che nol privava di amici, che di lui stimavano la sincerità del cuore. Merito, che tutti discussero, fu la sua versione italiana, affogata in un mare di note (per l'epoca araba prese, nientemeno, dal Codice diplomatico Airoldi-Vella!) della Histoire générale de Sicile di de Burigny; versione che lo Scasso avrebbe fatta anche del Corano se, come osservava il Cannella, ne avesse conosciuta la lingua420.
Di Monsignor Gioeni può pensarsi ch'egli avesse la passione di fabbricare. Non prima, infatti, erano principiati o condotti innanzi i suoi edifici, ch'egli per pentimenti sopravvenuti voleva riformarli: lusso consentitogli dalle non comuni e quasi sempre ben impiegate ricchezze. Con la passione delle opere edilizie procedeva in lui quella della gloria; poichè se pochi lo somigliarono nello esercizio incessante della virtù, egualmente pochi si piacquero quanto lui di raccomandare la propria fama alle opere che da quell'esercizio traevano vita e calore in iscrizioni non prive di lunghezza e di ampollosità.
Pure bisogna esser giusti. Questo difetto di modestia non va preso come una specialità del Gioeni. Altri con lui lo ebbero, ma in lui era sopravvanzato da un patriottismo senza pari.
Ed in vero: gli ultimi decennî del secolo accusano nei nostri reggitori ed amministratori una febbre intensa di gloria. Non si compiva un monumento, una fabbrica, un ornamento che non lo si volesse raccomandato ai posteri; sì che le iscrizioni onorarie e commemorative si moltiplicavano a vista d'occhio, specialmente, quando per la trasformazione degli edificî, per lo sviluppo della città e per la modificazione dei vecchi istituti la edilizia veniva subendo frequenti riforme.
Regnava Ferdinando III, e le iscrizioni auspicavano da lui e dal Vicerè, e s'impinguavano con la lista dei nomi e dei titoli, non sempre classicamente latinizzati, dei Pretori e dei Senatori. Più d'una era pel Marchese di Regalmici, al quale le incessanti cure dell'ammiranda opera di abbellimento della città non toglievano il tempo di assistere a solenni accademie in onor suo, nel Palazzo Pretorio e in palazzi privati.
Coi tempi nuovi (1860) fu fatta man bassa sopra alcune di queste iscrizioni: e quando la resipiscenza degli amministratori le volle conservate al Municipio, e soprattutto in quella che è ora Sala delle Lapidi, un gran numero vi mancarono, perchè state rotte, smarrite, o invertite a vilissimi usi.
Il richiamo alla vanità dei passati ci condurrebbe a malinconiche considerazioni sui presenti, affetti più di quelli da vanità e da megalomania. Il secolo XIX si è chiuso con una specie di morbosità monumentale, non per sincero sentimento di ammirazione ai morti, ma per mal dissimulata bramosia dei vivi di attaccarsi alla fama di celebri e non celebri morti e vivi.
E passiamo oltre.
Tra tanto senno il Cannella fa sedere Carlo Santacolomba pel suo libro sopra la Educazione degli alunni del Buon Pastore; ma lo Scinà, che esercitò dittatura letteraria incontestata, lo ritenne una vacuità illustre, che riuscì a strappare la gradita Abbazia di S.a Lucia del Mela (prov. di Messina). Questa ed altre abbazie, pingui canonicati, erano l'aspirazione incessante, la caccia perpetua di centinaia di persone. Ebbe quella di S. Angelo lo Scopello in Trapani il cattedratico Giovanni Gianconte, medico del Vicerè; ma se volle conservarsela, dovette vestire sempre l'abito chiericale non ostante avesse un bel tocco di donna dopo un matrimonio in perfetta regola a tutti noto, meno che al Governo. Ebbe il maltese Vella e si godette fino al giorno della sua condanna l'Abbazia di S. Pancrazio, che il sommo Meli chiese sempre invano; ed il Gregorio potè conseguire quella di S.a Maria di Roccadia alla vigilia di scendere nel sepolcro.
Eccezione ammirevole le donne colte, e perchè tali, lodate da colti uomini. Lieto ricordo è nelle scienze morali la Principessa di Campofranco, sulla quale non ebbero mai presa le lodi smaccate degli adoratori. Valente era, ma non quanto i contemporanei, perchè donna, nobile e ricca, la proclamarono. Il turbinio della Corte di Napoli la condusse fuori del campo delle lettere. Il matrimonio distrasse dagli studî Anna Gentile, cui il padre avea educata a studî forti e della quale la bizzarria del Principe di Campofranco diede in luce certe Lettere filosofiche421. Pure nè l'una, nè l'altra di queste donne superaron la Principessa di Villafranca in quelli di Educazione: e di tutte e tre nessuno partecipò agli studî di Donn'Anna Maria li Guastelli, monaca dell'Assunta, che in due poemetti cantò di S.a Rosalia e di Palermo liberato dalla peste del 1625, e venne allietata o conquisa da una pioggia di sonetti; ma non lasciò cogliersi dalla epidemia poetica, allora più che mai insidiosa: il che fa supporre in lei virtù non comune in mezzo alla comune debolezza dei verseggiatori.
Siamo proprio al tempo in cui, infastidito delle continue richieste di odi e di canzoni per le più frivole cose, Parini esclamava:
Possibil che un dottor non s'incoroni,Non si faccia una monaca od un frateSenza i sonetti e senza le canzoni!
E se questo in Milano, non altrimenti era in Palermo. I migliori poeti non sapevano resistere alla pertinacia delle richieste come alla vanità d'infilar versi. Non facciamo il nome del Meli, perchè non vogliamo profanarlo; e non vorremmo fare neppure quello del Carì se di lui dovessero rispettarsi solo le improvvisazioni, aliene da tutte le convenzioni ufficiali. Ma anch'egli, il Carì fu vittima non sappiamo se della corrente di allora o di sua particolare inclinazione. Se per poco gli andremo dietro, lo vedremo poeta di tutte le ricorrenze, dalla morte d'un amico, al giuoco del pallone, dall'ascensione aerea del capitano Lunardi alla effimera guarigione del Vicerè Caramico, ed alla improvvisa morte di lui. Qualche volta però, anzi sovente, come ardito, libero padrone del campo poetico, meschinamente, forse bassamente, popolato di adulatori senza pudore e di scribacchini senza coscienza, nelle sue non misurate corse, talora ricalcitra alle regole del Galateo ed al freno dell'arte, tanto dal trascender nel lubrico; e pare confonda la franchezza con la licenza. Per questo il suo nome, Cireneo di cento croci, veniva preso come etichetta di merci avariate o di contrabbando; giacchè non v'era sonetto, non epigramma, non satira mordace della quale non si attribuisse a lui la paternità. Questo, se non è sempre onorevole per la sua fama, dimostra che nessuno si riteneva più franco di lui nel dire il fatto suo sui peggiori arnesi e sulle più brutte cose del secolo. La sua musa sorrideva e fremeva, sogghignava e plaudiva, quando velata e quando scoperta, attorno al card. Lorenzo Ganganelli che diventava Papa Clemente XIV (1769); a Voltaire che moriva (1778); ai frati Domenicani e Francescani che perdevano il privilegio del Generalato (1788); a Francesco Carelli, che partiva, esacrato ministro napoletano, da Palermo (1795); all'Ab. Vella che veniva condannato (1796). Uno scatto di questa musa contro il neo-eletto avvocato fiscale del R. Patrimonio, Monroy, bastava a trattenere il Re dal concedere il possesso dell'alto ufficio. Allorchè nel 1798 Carì cessava di vivere, il Meli lo piangeva a calde lacrime e cantava:
Mortu è Carì, lu granni, lu sublimiPrincipi di la lira e di li canti422.
Che fosse stato tale, lo dissero tutti i contemporanei; ma dell'opera poetica di lui labili ricordi restano, più che per le poche poesie edite, per le molte manoscritte, a ragione o a torto a lui attribuite; della oratoria scarsi, mediocri documenti; e della teologica, per quanto lodata, dissertazioni per le quali pochi ebbero ragione di annoverarlo fra i grandi maestri della scienza di Dio.
Questo il Carì, Nestore dei letterati del tempo che fu suo. Scolari, imitatori ed emuli di lui in Pindo: una turba di verseggiatori, argomentandosi di seguirlo, facevano mostra di sè in accademie, case private, solennità religiose, nuziali, onomastiche. Dozzine di ecclesiastici e di forensi, volendo grandeggiare, bamboleggiavano; e, sia detto per onore del vero, tutto poteva loro far difetto meno che la imperturbabilità nel corteggiare le muse; le quali non troppo benevole con essi, infastidite di tanti importuni, ora all'uno, ora all'altro voltavan le spalle, senza che nessuno degli accesi spiriti se ne accorgesse. Che anzi, nella beata illusione di lor valentìa, tutti s'infiammavano a celebrare avvenimenti pubblici, fatti di famiglia, cuccagne di popolo, nascite di bambini, morti di adulti, professioni di monache, feste di santi, arrivi di alti personaggi, elezioni di senatori, promozioni di beneficiali e di magistrati, trionfi di cantanti, senza un pensiero alla patria gemente, senza un motto che rivelasse coscienza dell'ufficio civile della poesia, o aspirazione a un ideale altissimo. L'eco dei placidi belati del sac. Urso e di Domenico Perdicaro, di Luigi Graffeo e di Benedetto Jerico, di Giuseppe Spinosa e di Domenico Cavarretta, di Salv. Di Liberto e di Gaspare Mangione si ripercoteva per intere settimane nei salotti, nei refettorî dei monaci e dei frati, nelle scuole dell'Accademia (Università) degli Studî, nei caffè; e si levavano a cielo quelli dell'Ab. Mancusi e dell'Ab. La Manna, nomi che ora appena si trovano in mezzo agli altri di canori pastorelli, ai quali se non ci fu un'Arcadia che li facesse suoi, non mancarono certamente sorrisi e plausi tra
Il dotto, il ricco ed il patrizio vulgo.
Non ci fu, è vero, un'Arcadia ufficiale; ma ne dominò un riflesso e più che un'eco: e quando (1773) Suora li Guastelli, figlia dell'ex-Senatore G. Battista, volle dare alle stampe il Palermo liberato, dovette chiederne l'autorizzazione al Preside ed ai Censori dell'Accademia degli Ereini, alla quale era ascritta. L'alto magistrato tenne consiglio, e, dopo maturo esame, deliberò di concedere la invocata autorizzazione. Il suo decreto, non ostante la comicità dei nomi accademici, olimpicamente solenne, chiudevasi con la seguente formola: «Dato in Collegio dei nostri Monti (Erei), nel giorno 4 della Luna di Munichione, Olimpiade 738, anno 1 a P. C. Olimpiade 11 a 4»: formola che ha tutta l'aria di certi problemi onde qualche moderno autore di aritmetica per le scuole si crogiola a tormento dei poveri fanciulli.
Gareggiavano poi coi migliori siciliani i poeti del Continente domiciliati in Palermo, chi tra le Comunità religiose dei Teatini e degli Scolopi, chi nelle case signorili a educare giovanetti. Per tale compagnia la produzione poetica paesana veniva accresciuta da quella toscana dello scolopio Carlo Lenzi, dell'Ab. Griggioni, del Dorisse (de Rossi) e degli illustri padre Salvagnini e p. Michelangelo Monti. I versi di questi ultimi, tenuti in molta estimazione, non prima venivano letti o uditi che erano imparati a memoria e recitati dappertutto. Tempi beati, nei quali un'ode faceva il giro trionfale della città!
Di incidenti ed aneddoti personali utili alla conoscenza di questa brava, ma spesso fastidiosa gente, ve n'è quanti se ne vogliono. Ne sceglieremo per la sua amenità uno soltanto.
Una mattina l'Ab. Carì dopo di aver celebrato messa nella chiesa di S. Matteo, si stava spogliando degli abiti sacerdotali nella sagrestia. Nel frattempo gli si presenta un uomo, che lo prega di volere udire due suoi sonetti, o di dirgli quale gli sembri degno di vedere la luce. L'ab. Carì china benevolmente il capo ad ascoltare. Mentre lo sconosciuto legge il primo sonetto, il Carì si fa brutto in faccia. Finita la lettura, gli dice secco secco: «Stampate l'altro». — «Ma come! risponde quello; se Vostra Reverenza non l'ha sentito ancora?» — «Sicuro: aggiunge l'Ab. Carì, perchè peggiore di questo primo, il secondo non può essere».
CAP. XXV.
L'ACCADEMIA (UNIVERSITÀ) DEGLI STUDI E GLI STUDENTI.
Dopo la soppressione dei Gesuiti la istruzione non ebbe quel rinnovamento che era da impromettersi. Come suole avvenire nelle improvvise rivoluzioni d'ordine politico civile, morale o religioso, non si era preparati al da fare, e si credette di aver provveduto alle prime e più urgenti bisogne abbattendo in fretta e in furia gli emblemi della espulsa Compagnia e supplendo alla meglio qualche istituzione buona alla gioventù maschile e femminile.
Dieci e più anni passarono senza un piano prestabilito di riforme, senza un concetto sicuro di ciò che convenisse sostituir proficuamente all'insegnamento che era venuto a mancare. Si sapeva quel che si era lasciato; non si sapeva quel che si dovesse prendere.
Discipline neglette per le condizioni d'allora, impotenti aspirazioni al progresso si trascinavano in mezzo a fiacche velleità di riforme.
Nelle mani dei Gesuiti erano state le scuole che ora si direbbero classiche secondarie e le superiori. Nel loro Collegio Massimo si erano conferite lauree in alcune facoltà. Col loro allontanamento quel privilegio era venuto meno; quindi non più dottorato in Teologia, meta suprema degli studî ecclesiastici; non più laurea in Filosofia, materia comune alla Giurisprudenza ed alla Medicina.
Eppure ben altri erano stati i voti della Città nei secoli passati! Quando nella rivoluzione del 1647 il popolo palermitano, adunato nella chiesa di S. Giuseppe, avea presentato i Capitoli che per opera del Senato voleva concessi dal Vicerè, non avea dimenticato quello a favore della istruzione, inteso ad ottenere che «studi pubblici di tutte le professioni in loco ben visto alla città» si aprissero, e la città ne scegliesse i maestri423.
Ora il Senato, vigile custode del decoro della Capitale, implorò dal Re il privilegio dei Gesuiti; ed al suo voto si unì più tardi, dissenziente il Braccio militare, il Parlamento. S'invocò a favore del Diritto Civile e Canonico e della Medicina e Chirurgia il privilegio per secolari concessioni goduto, a scapito di Palermo, dalla città di Catania. Lunghi i tentennamenti: ripetute le ripulse, dovute a difficoltà di erario ed a malinteso rispetto a vieti diritti e, che è più, ad apatia del Governo di Napoli. Si temeva che una concessione in questo senso a Palermo potesse nuocere a Catania, facendo nascere in essa malumori contro i ministri: e frattanto alla istruzione di Catania nocevasi, come vedremo, assai più che concedendo il chiesto privilegio.
Imperciocchè è da sapere che se Catania aveva la prerogativa dell'insegnamento superiore e delle lauree, Palermo avea l'incarico dei concorsi alle cattedre di quella città: e di questo le sue commissioni esaminatrici con sottile astuzia si giovavano per regalare alla privilegiata Università i men degni maestri. La notizia è nuova, ma ci viene da un uomo degno di fede, indispettito del brutto giuoco a danno della città a lui cara.
«Palermo, dice il De Cosmi, ha riguardato sempre con gelosia questa Università, e sempre e per tutte le vie ha procurato di fiaccarla coll'erezione di nuove scuole, con dispense dal triennio, col procurare che i professori di Catania fossero sempre persone di poco sapere, come si vede dagli attuali (1801) professori interinarj provveduti dal Ministero di Palermo, che, senza esagerazione, furono la spazzatura di tutta la gente inutile di Palermo: sordi, vecchi decrepiti, attratti, per non parlare delle qualità dello spirito e del costume, e che in otto anni hanno finito di discreditare le scuole di quella infelice Università»424.
Fatta la legge, del resto, è trovato l'inganno: e molti giovani dell'Accademia degli studî in Palermo maliziosamente si sottraevano al triennio di Catania mercè dispense che con futili pretesti facilmente ottenevano.
Pure i tempi maturavano.
L'ultimo ventennio del secolo si svolgeva a vantaggio della cultura scientifica della maggiore città dell'Isola. Sotto l'impulso di eletti ingegni, con un po' di buona volontà del Governo locale, alle aure di un rinnovamento intellettivo da tutti sentito, si cominciava a respirare in campi meno angusti di quelli nei quali era stata o si era trincerata la istruzione superiore. Un piano venne presentato per raddoppiarne le materie; nuove discipline vennero ad assorellarsi con le antiche rafforzandone la efficacia. Il modesto titolo di «Accademia degli Studî» prese a rappresentare una vera e propria Università, che poi, nel 1805, potè sorgere incontrastata a fronte di quella di Catania. Trenta cattedre avea proposte (1779) la Deputazione degli Studî, e solo venti ne ottenne: tre per la Teologia, quattro pel Giure, sei per la Medicina, sette per la Filosofia: concessione irrisoria, se si guardi ai tempi nostri; non priva d'importanza allora, che poco o punto si era riusciti ad avere.
Alla laurea teologica si potè aspirare frequentando per cinque anni (era il corso più lungo) le lezioni di Storia ecclesiastica, Teologia Dommatica e Morale non tomistica; alla legale, quelle di Istituzioni canoniche e civili, di Diritto naturale e pubblico, di Economia, Agricoltura, Commercio. Si conseguiva la laurea in Medicina per corsi di Anatomia, dissezioni anatomiche, Chirurgia pratica, Chirurgia ed Ostetricia, Chimica e Farmaceutica, Medicina teoretica e pratica. Questi corsi superava la laurea filosofica, la quale in un amalgama che oggi deve parere indigesto componeva Logica e Metafisica con Botanica e Storia naturale, Fisica sperimentale con Lingue greca ed ebraica, associandovi Geometria ed Algebra, Matematiche, Idraulica ed Architettura civile! Di Pandette, Diritto feudale e criminale, Storia civile, Antichità e Diplomatica non si parlava neppure, benchè la Deputazione, ispirandosi a quel che s'insegnava a Catania, ne avesse fatto proposta.
A questi, altri insegnamenti vennero aggiungendosi più tardi; sì che ai primi del nuovo secolo poteva ben contarsi sul numero dei trenta della Deputazione medesima, pure essendovene diversi da quelli da essa vagheggiati. Lettori furon detti coloro che oggi chiamiamo professori, titolo che assumono modesti insegnanti elementari come titoli nobiliari si arrogano vanitosi audaci che non vi han diritto. Agli antichi venne conservato il salario annuale di cent'onze (L. 1275); ai nuovi quello di sessanta ad ottanta (L. 1070), che al settecento valeva qualche cosa.
In tutto questo tempo l'Accademia ebbe maestri rinomati: l'Ab. Carì per la Dommatica, G. Venanzio Marvuglia per l'Architettura, Controsceri per l'Etica, Sergio per la Economia pubblica, R. Scuderi per la Patologia. Meli tribolava insegnando Chimica senza gabinetto; Garajo chiedeva invano di dettare il suo corso di Istituzioni civili e di rito civile in casa; Frate Bernardino da Ucria, condannato al modesto ufficio di dimostratore, faceva per la Botanica assai più del lettore Giuseppe Tineo. Man mano che altre cattedre si fondavano, maestri valorosi venivan chiamati ad occuparle: l'Ab. Balsamo l'Agricoltura, il can. Gregorio il Diritto siculo. Con larghe offerte si fecero pratiche per avere allo insegnamento della Letteratura il Marmontel, delle Matematiche il Lagrange, della Fisica lo Spallanzani, dell'Astronomia l'Oriani: più oltre non poteva andarsi, ed il Caracciolo vi si spinse con lo ardore di un riformatore; ma le pratiche riuscirono infruttuose; e fu somma fortuna che il Piazzi si decidesse a lasciar la sua Valtellina per la Sicilia, ove fu compagno ad altri ecclesiastici del Continente italiano quali il Salvagnini da Padova e P. Michelangelo Monti da Genova.
Tra essi, circondato della falsa aureola di sapienza arabica, si assise superbo il più gran ciarlatano del secolo dopo Cagliostro in Sicilia, l'Abate Vella, le cui sfacciate creazioni storiche ci siamo provati a riassumere in un precedente capitolo.
Tolto in siffatta maniera ogni impedimento alla laurea, il numero degli studenti si accrebbe, e con essi il bisogno di un regolamento di disciplina. Verso la fine del secolo questo numero rappresentava una media di 850; nel 1800 preciso era di 896, cioè: 84 nella Facoltà teologica, 152 nella medica, 324 nella filosofica, 336 nella legale425.
Dalle carte dell'Accademia non si rileva se tutti facessero il loro dovere; si rileva bensì che era molto attiva la sorveglianza del Rettore del cortile sullo studio e sulla condotta loro. Si prendeva nota dell'intervento degli scolari alle lezioni, del buon costume, degli atti di pietà ai quali essi erano tenuti: ed atti obbligatorî di pietà erano la messa ogni Domenica nell'Oratorio, il catechismo, le preghiere e via dicendo. I giovani leggitori di questo libro — se tant'è che esso ne avrà — sorrideranno a queste notizie: ma la cosa era proprio così. Gli spiriti che oggi compiangono i poveri di spirito di ieri, maestri e discepoli, devono pur pensare che essi hanno risoluto il grave problema della credenza nella peggior maniera: non credendo nulla.
Le vecchie insegne dottorali rivennero dal Governo autorizzate: fu permesso l'anello e l'uso della cintura sopra gli abiti civili ed il fiocco al cappello; la toga ed il fiocco color cremisi per la Teologia: color verde per la Filosofia426.
Pure di scappatelle ne facevano anche allora gli studenti: se no, perchè certi articoli disciplinari? Pei disubbidienti e pei protervi non v'era solo la ammonizione e la espulsione, ma anche qualche argomento convincente della polizia. Bisognava arare diritto, e non permettersi atti di ribellione di sorta. Come più tardi, fino al 1860, dentro la Università attuale, così allora dentro l'Accademia, cioè nell'ex-Collegio dei Gesuiti, era una stanza per ufficio di un funzionario incaricato di reprimere con la forza qualunque tentativo di eccesso. Quando per la morte di D. Stefano Pizzoli, Lettore di Medicina Pratica, venne chiamato il modicano D. Baldassare Cannata (16 ott. 1797), gli studenti di Medicina si prepararono ad ostile accoglienza. Cannata, non palermitano, non di alta levatura, poco buon parlatore, faceva sentire la perdita del venerando Maestro palermitano, sapiente nella pratica, carezzevole nella parola. Il Cannata inoltre aveva un difetto grave pel momento (il che è curioso per la storia dei sistemi medici tra noi): non campeggiava a favore della dottrina di Brown, per la quale gli studenti, probabilmente perchè nuova, parteggiavano. Erano cencinquanta, e tirarono dalla loro tutti gli altri compagni delle varie Facoltà. Il Cannata venne fischiato; ma la Deputazione degli studî tenne fermo. Il Presidente Asmundo Paternò non era uomo da lasciarsi imporre dagli schiamazzi; e Mons. Airoldi, Giudice della R. Monarchia, e Tommaso Natale, sapevano bene il Fatto loro: e non cedettero. I fischi si ripeterono, e la Deputazione fece entrare nella scuola del Cannata un buon nerbo di birri. Ancor, altri fischi: ed i tumultuanti furono arrestati. «Così — conchiude soddisfatto un testimone — l'ordine venne ristabilito»427.
Le Facoltà di Patologia, di Medicina e di Filosofia rappresentavano l'insegnamento superiore; l'inferiore comprendeva le scuole di Rettorica, di Umanità di prima, seconda e terza classe: e poteva dirsi quello che oggi è in parte il liceo, in parte il ginnasio, senza essere («fortunati scolari d'allora!» ci par di sentire esclamare gli scolari di oggi) nè liceo, nè ginnasio.
Si era quindi in pieni studî classici italiani e latini.
A centinaia vi accorrevano gli alunni; pei quali era vanto l'apprendere dalla bocca del P. Gaspare Pecoraro e di Mich. Monti le lezioni d'infima latinità e di alta italianità. Così grande ne era il numero che di ciascuna classe doveano farsene due: e le cinque classi ne contavano oltre a mezzo migliaio. L'anno 1800 dianzi citato essi ammontavano a 660.
I saggi pubblici degli alunni del Monti facevano inarcare le ciglia e p. Vesco, dotto, ma privo di gusto e di slancio, che vedeva disertare la sua scuola ed affollare quella del Monti, si sfogava in insipidi epigrammi, ai quali il buon genovese opponeva dignitoso silenzio428.
CAP. XXVI.
SCUOLE INFERIORI PUBBLICHE E PRIVATE, MASCHILI E FEMMINILI. CASTIGHI. MONELLERIE. USANZE VECCHIE E PRATICHE NUOVE.
D'altro ordine e con espedienti diversi l'insegnamento medio e inferiore.
Oggi si fanno distinzioni e sotto-distinzioni di scuole classiche e tecniche, professionali e normali. Allora non se ne facevan punto.
Le scuole che si dicevano normali, corrispondevano alle elementari; le altre, alle classiche. Non difficile, benchè non sempre comunemente accetto, il potere frequentare gl'insegnamenti; i quali per vecchio e nuovo istituto venivano, come vedremo, impartiti dai frati.
In ragione dei sessi e dei ceti, differenti fra loro erano le scuole, tanto pei ricchi quanto pei poveri, provvedendosi alla istruzione ed al mantenimento di esse coi beni dell'abolita Compagnia. Giammai in tempi di libertà furono impiegate più sapientemente e provvidamente le ricchezze: esempio che si sarebbe dovuto tener presente quando i beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose andarono quasi perduti per l'erario, non messi a profitto per centinaia di migliaia di Siciliani bisognosi.
Un decreto reale del 1779 aveva ordinato l'apertura di scuole pubbliche in tutte le case monastiche della Capitale. A questo decreto fu ottemperato nei principali conventi. Vi furono ricevuti i fanciulli della bassa gente, i quali vi imparavano a leggere, scrivere, far di conto, grammatica latina, catechismo: tutto gratuitamente. Ogni scuola avea due classi, l'una di lettura, scrittura e aritmetica volgare; l'altra di elementi grammaticali latini da non potersi spingere al di là delle prime regole di sintassi secondo l'unico Limen grammaticum. Spedita si voleva la lettura, chiara e grande la calligrafia, precise le regole, buoni gli esemplari dello scrivere; preferite le operazioni aritmetiche «più facili e brevi e più necessarie agli usi del popolo e degli artisti», cioè degli operai.
Con questo fu intendimento del Governo offrire ai frati i mezzi di uscire dall'ozio degradante che li consumava e di sollevarli a dignità di maestri.
Le lezioni duravano due ore la mattina, due ore dopo desinare. Un solo mese le vacanze, dal 4 ottobre al 4 novembre; vacanze settimanali, il mercoledì e tutte le feste di chiesa. Questo volevano le istruzioni di Mons. Airoldi, che sulle fraterie aveva la giurisdizione.
Secondo la diligenza ed il merito, i gradi e gli onori tra gli scolari.
Severamente proibiti i regali dei parenti ai maestri: vietato ai maestri il riceverne alcuno, chè menomata ne sarebbe potuta uscire la libertà loro con parzialità verso gli alunni. Nessuna lezione doveasi incominciare senza la invocazione del divino aiuto; nessuna finire senza un ringraziamento a Dio429.
Dieci anni dopo (1788) venivano introdotte in Palermo per opera di G. A. De Cosmi, ch'era andato a studiarle a Napoli presso i Celestini di Germania, le scuole normali. Le prime tre ebbero posto ai Crociferi, al Palazzo reale ed alla parrocchia di S. Antonio. Dicevasi la nuova istituzione di non esser proprio la tedesca; il De Cosmi avervi apportate tali modificazioni da mutarne lo stampo originale, anzi averne senz'altro snaturato lo scopo, ch'era quello di dirozzare ed istruire il popolo. Malgrado queste ed altrettanti dicerie, le scuole vennero prese d'assalto. Nei soli Crociferi si contarono fino a cento e più alunni. Quaranta frati siciliani, che col De Cosmi erano andati ad istruirsi nel nuovo metodo a Napoli, furono tutti collocati nell'Isola, paghi del modico loro salario: e De Cosmi ne tenne la Direzione generale in Palermo, così come la Deputazione superiore teneva quella dell'insegnamento alto: due direzioni indipendenti l'una dall'altra, dipendenti solo dal Governo430. Il solito leggere, scrivere, far di conto e l'indispensabile catechismo ne era la base. Il latino, ritenuto allora indispensabile a qualunque studente, e che per una assurdità non altrimenti s'insegnava che in lingua latina, era bandito; ma, sicuro del fatto suo, il De Cosmi volle fare esperimento del metodo anche con esso. Sorprendenti ne parvero i risultati, perchè in un solo anno poterono gli scolari spiegare le Favole di Fedro e le Vite di Cornelio e darne le ragioni grammaticali.
Si comprendono perciò i diversi pareri del momento intorno alle scuole normali, prese dove con sincero favore, dove con manifesta antipatia. I partigiani del vecchio, le videro come una ridicola novità, buone solo a gettar polvere agli occhi e fare spender denaro. Tra questi fu il Villabianca, che avendone voluto visitare una, quella del p. Caravecchia ai Crociferi, trovò i ragazzi a far la birba (23 sett. 1789); e non ci fu verso che si volesse ricredere, neanche dopo una visita che andò a fargli in casa il De Cosmi (1800)431.
D'altro lato gl'insegnanti privati videro per esse disertate le loro scolette: e doveva esser così se contro le loro a pagamento, le normali eran gratuite. La scuola d'un certo sac. Quattrocchi è l'esempio degli immediati effetti economici della nuova istituzione.
I Baroni, obbligati dal Governo ad istituirne a proprie spese nelle loro terre vassalle, fecero una opposizione così gagliarda, che il Re ne mosse loro, a mezzo del Vicerè, acerbo rimprovero.
Ci si consenta di tornare un poco indietro per osservare che la soppressione dei Gesuiti aiutò lo sviluppo dello insegnamento privato. Tra le scuole più note d'allora ce n'era una nel quartiere di Ballarò. Nel giorno che inaugurossi la nuova Biblioteca senatoriale (25 apr. 1775), il Vicerè volle entrare nella vicina chiesa di S. Michele Arcangelo per ricevere la benedizione. «Quivi fecero una vaga, deliziosa mostra li scolarelli di G. B. Romano, pedante, prete, che teneva scuola presso la detta chiesa, quali vestiti da soldati con armi e bandiere, formando uno squadrone di battaglia, fecero corte ed onore al Principe: e la banda degli strumentisti di questa truppa di ragazzetti accrebbe il brio e lo spirito di questa festa»432. Immaginiamo la gioia del p. Romano a questa funzione militare, e come dev'essere stato felice quando il Vicerè Marcantonio Colonna gli avrà sorriso e forse lo avrà ammesso a baciargli la mano. Certo i padri degli alunni ne piansero di tenerezza.
Di grado più elevato e più serio fu un'altra scuola del rione della Pietà, tenuta da un altro ecclesiastico e protetta dal Principe di Villabianca. Per molti e molti anni essa chiamò a grande concorso i fanciulli della classe civile, e fu in singolar favore della nobile. Del profitto degli alunni era dato pubblico, solenne saggio annuale, che si protraeva per due giorni interi. Vecchie carte di famiglia ci han conservato i programmi di questi saggi. In un angolo della piazza Vigliena veniva affisso un cartellone a penna corrispondente agli attuali placards a stampa. Quello dell'ottobre 1796 diceva così:
Il programma invece era stampato e portava il titolo:
Prospetto di quanto si praticherà nell'esercizio letterario solito in ogni anno tenersi al fine degli studj dagli scolari del sacerdote D. Michele Castiglione, che ha la scuola dirimpetto il Convento di S. Agostino, dedicato all'Ill.mo sig. Duca Lucchesi distribuito in due giorni433.
Queste mostre erano dei veri avvenimenti pubblici. La parte più eletta della città v'interveniva e se ne piaceva, prodigando lodi al Precettore Castiglione, i cui alunni tanto profitto ricavavano. Interprete del comun plauso facevasi poeticamente P. Catinella434.
Se non che, una brutta occasione venne a togliere alla città questa tra le migliori, se non la migliore scuola privata. Perseguitato dai timori della recente rivoluzione di Francia e dagli effetti delle novità, Re Ferdinando in persona proibiva in Palermo negli istituti privati lo insegnamento delle scienze. Era per lui un partito efficace ad impedire la introduzione di teorie pericolose in iscuole che, fino a certo punto, si sottraevano al controllo governativo ed eran tenute, perchè frequentate dalla classe civile, le più facilmente inchinevoli alle fecondatrici dottrine dei novatori. P. Castiglione disubbidì: ed il Governo ne chiuse la scuola (27 marzo 1799)435 con sensibile danno della gioventù, che da quella ritraeva solido profitto.
L'argomento del quale ci occupiamo non è molto allettevole: e noi ci permettiamo d'interromperlo con un aneddoto un po' ameno.
Un maestro di scuola in Palermo, gran chiacchierone, ci vien presentato dall'ab. Antonino Galfo, siracusano, amico intimo del Metastasio, nel seguente arguto sonetto:
Un panormita Precettor, che spessoIl pranzo, per ciarlar, lascia e la cena,Sfogava nel ginnastico consessoLa sua loquace, inesiccabil vena.Il segno alfin sonò, per cui concessoÈ al misero fanciullo uscir di pena,Nè si avvedea, che da le ciarle oppressoChi grattavasi il capo, e chi la schiena.Manca intanto col sol, che ormai s'involaAl dì la luce; ma non pria, che manchiA quello o la materia, o la parola.I putti allor di più ascoltarlo stanchiL'un dopo l'altro uscirono di scuola,Ed ei fu inteso a ragionar coi banchi.
L'Ab. Galfo — lo diciamo a proposito del suo sonetto — non si rifiutò di pagare un tributo all'Arcadia del tempo, ed uno di questi pagamenti fu la descrizione della maniera onde «Nice invita Filano a bever seco la cioccolata»436, occasione eccellente per un'altra descrizione: la preparazione della deliziosa bevanda, che d'inverno e nelle ore nelle quali non era dalla moda consentito il sorbetto, veniva servita presso le migliori famiglie.
Sicchè la musa del tempo avea anche delle benemerenze culinarie.
Un seminario di nobili giovanetti avea prosperato in Monreale per opera di F. Murena. Questo seminario passò a Palermo, presso i padri Scolopi, che però dovettero cederlo al Governo e contentarsi di trasformarlo in istituto di ragazzi civili, ricevendo in compenso un annuo assegno di seicent'onze (Lire 7650).
Sorse così il «Collegio Real Ferdinando», tutto di aristocrazia provata con cent'anni almeno di nobiltà, sia di feudi, sia di nobili ufficî. Il Governo vi volle a sua disposizione venti posti, ma più generosamente del solito concedette sui beni gesuitici cinquemila scudi ogni anno. Se la retta annuale pei civili era di 24 onze, qui pei nobili fu di 40437. La istruzione loro impartita non poteva essere più larga e completa. Oggi stesso non si ha per la parte cavalleresca nulla di simile. Dalla grammatica inferiore e superiore si giungeva alle umane Lettere ed alla Rettorica: l'Aritmetica volgare si alternava con i primi rudimenti delle scienze. Per lungo volger d'anni v'insegnò francese un francese autentico, Mr. l'abbé Jacques Richard; disegno, Fr. Sozzi. La scherma, impartita da un San Malato d'allora, il Maestro Trombetta, si variava col maneggio dei cavalli, ed il violino con gli strumenti da fiato e col ballo438. Fino a sessanta ragazzi fornivano così la loro educazione: ma quanti uscivano educati a retti principî? I casati onde provenivano, quella convivenza, giovevole ad impregnar di fumi l'ambiente, le periodiche visite di certe famiglie, non sempre concorrevano a preparar bene giovanotti che nella vita privata e nella pubblica doveano portare la impronta della elevata loro origine e della insigne cultura avuta. I buoni esempî non difettavano, nei quali la nobiltà del sangue veniva confermata dalla nobiltà delle opere; ma non iscarse erano le riuscite infelici: e questo libro malauguratamente ne offre esempî dolorosi.
Oggi per opera di benemerite persone nostrane e forestiere prospera in Palermo una caritatevole «Società siciliana umanitaria per la Infanzia abbandonata». Questa istituzione non è nuova. Nell'agosto del 1781 una «Casa d'Educazione per la gente bassa» veniva aperta proprio ai fanciulli poveri, abbandonati dai loro genitori ed agli orfani. Quella benemerita Casa venne in parte costruita, in parte accomodata ad ospizio. Per provvedimento sovrano, sopra i beni dei Gesuiti non meno di ottanta fanciulli vi furono raccolti, vestiti, nudriti, ammaestrati alla lettura, alla scrittura, all'abaco, al disegno. Più tardi questa casa si aprì a quanti potessero pagare vent'onze all'anno. Quando si pensi che il piano di questa istituzione fu concepito e proposto dal Sergio, non si ha ragione di maravigliare dei buoni risultati di esso439.
Frattanto, antichi istituti beneficavano i fanciulli dispersi, che, distinti in bianchi e in turchini, venivano ospitati ed istruiti nel seminario di S. Rocco e in quello del Buon Pastore. Ma coi dispersi erano anche i figli delle persone civili, che pagavano una annuale retta.
Qualche notizia degli istituti femminili e della istruzione ed educazione che in essi impartivasi è necessaria.
I soliti tre quarti di nobiltà si esigevano per le donzelle del recente R. Educandario Carolino: e nei primi del sec. XIX fu grave scandalo l'ammissione d'una fanciulla alla cui famiglia mancava uno o due di quei quarti. Che importava che potessero pagare cinquant'onze (L. 637) e magari il doppio della retta quando non c'era quel titolo essenziale? Nè importava che le cinquant'onze non si potessero pagare, perchè alle ristrette fortune provvedevano posti di regia erezione.
Completa eravi la istruzione, e tale da non restare molto addietro alla presente. Lì erano «tutte le scuole di leggere, di ben formare il carattere (calligrafia), di aritmetica, di lingua latina, di lingua francese, di geografia, di storia e di musica». Lì «maestre fisse di lavorar calzette (che scandalo ai dì nostri l'insegnar la calzetta ad una ragazza!), di cucire alla francese, di ricamare e in bianco e in oro o argento, ed in colorito a fiori, di travagliar merletto o di filo o di seta o d'oro ed argento, e di tutte insomma le manifatture femminili». Monsieur Bernard era il modello della più fine pronunzia del francese che insegnava; pronunzia tenuta sempre di conto, e perfezionata per la viva voce delle suore salesiane (governatrice, suora Lionetti) e di tre cameriere francesi, addette con un'altra del paese alle venti educande ordinarie. Severi i divieti di oggetti di lusso e di moda, chè irresistibile era per questi la inclinazione delle fanciulle. Ma, al contrario, non adatti alla buona educazione del corpo e dello spirito i lauti pasti giornalieri440; i quali preludevano a quelli che ad istruzione finita sarebbero esse andate a trovare nelle loro case.
Buone le istituzioni dei collegi di Maria, intesi, secondo la Regola del Card. Corradini, «al gratuito insegnamento delle ragazze nei lavori donneschi, nella istruzione letteraria elementare, nell'aritmetica, nonchè nella educazione morale, nella cristiana religione», come diceva il Iº articolo del Collegio della Sapienza (1740), modellato su quello della Carità all'Olivella (1721).
E non si cerchi altro dopo il molto che davano questi eccellenti seminari di educazione femminile. Ovunque si andasse per la città, in qualsivoglia ritiro o reclusorio femminile volesse penetrarsi per osservarvi la istruzione che vi s'impartiva — dove se ne impartiva, — non si sarebbe trovato se non una parte appena di quello onde i Collegi di Maria largheggiavano.
Houel trovò caratteristica la trascuranza, sovente volontaria, della istruzione delle fanciulle anche più elette nei piccoli paesi di provincia, e racconta un aneddoto del quale fu testimonio in Girgenti.
«Io, dice Houel, andavo spesso in casa del Barone.... dove intervenivano molti titolati. Un giorno sorse un dubbio circa la maniera di scrivere una parola italiana: e poichè nessuno si trovava in grado di scioglierlo, ne fu chiesto a due distintissime signorine della compagnia; le quali con aria di gran soddisfazione risposero che non sapevano leggere. E perchè? perchè altrimenti avrebbero potuto comunicare con gli uomini. Un canonico, sopravvenuto, giustificò l'uso, bastando solo che le donne sapessero recitare le loro preghiere col rosario. Tutti mi parvero dell'avviso del canonico»441.
Certo non si andava tant'oltre da coloro che volevano intendere alla educazione delle figliuole: ma chi scrive queste pagine conobbe prima del 1860 signore egregie, le quali sapevano leggere ma non sapevano scrivere, perchè il leggere soltanto era stato consentito dai loro genitori: e potremmo fare i nomi di tre di esse, le quali furtivamente avevano imparato a scribacchiare sogguardando una loro sorella destinata ad un Collegio di Maria, nelle ore che un maestro di scuola veniva a darle lezioni in casa.
Non sempre la istruzione andava in armonia con la educazione, la quale a cagione dei difetti del tempo difettava anch'essa. T. Natale osservò che tra noi non si conosceva «il vero e retto metodo di educare i nostri figliuoli onde divenissero buoni ed utili membri della Società»: ed attribuì il male alla insufficienza delle persone che educavano e al non proporzionare l'educazione loro alla condizione delle persone in particolare, e in generale a quella del paese442.
Siamo sempre alle solite recriminazioni ed ai soliti rimpianti!
Quando si guarda ai castighi che allora s'infliggevano a coloro che venivano meno ai doveri di studio e di disciplina, non si ha diritto di dubitare di questa osservazione.
Parecchi assiomi popolari giunti a noi fanno fede delle teorie educative d'una volta. Si diceva che i fanciulli imparano a leggere non per il maestro, ma per via delle sferzate443; e ripetevasi per sentita dire il verso del Veneziano:
La ferla 'nsigna littri, nomi e verbi.
La sferza era il dio della istruzione, e fuori di essa impossibile sperar bene.
Certo queste teorie non nacquero nel settecento; ma nel settecento correvano, formando, diremo così, il catechismo di certi maestri e di certe famiglie.
Comuni i castighi di obbrobrio pei negligenti: la solita mitra di cartone con un somaro dipintovi sopra pei fanciulli delle scuole inferiori; un cencio rosso buttato sulle spalle ed una canna in mano per quelli delle superiori, dalla Umanità in poi. Ci era, come al tempo dei Gesuiti, la gridata d'un giovane di bella voce, ordinata dal maestro perchè tutti sapessero che il tal dei tali non voleva studiare, e perchè egli cangiasse vita. Questa gridata cominciava e finiva con l'intercalare: Studeat! Studeat! e tutte le classi facevano silenzio per sentire di chi si parlasse.
Non meno comuni le spalmate, inflitte quando dal maestro, quando, per non iscomodarsi lui, da un uomo ad hoc, che si diceva bidello, ed era un vero aguzzino: due, quattro, sei, otto, sempre in numero pari alternando nel paziente i colpi sulla mano destra e sulla sinistra. C'erano i cavalli. Uno scolare aitante e vigoroso della persona, o un aiuto del bidello, era chiamato a caricarsi addosso il gastigando, ed il maestro, o chi per lui, gli appioppava su quel di Roma delle sferzate, per le quali il miserello scalciava e gridava a perdifiato (se era un bel tomo, taceva): ed il cavallo tentennava alle scosse.
Quando la colpa esigeva maggior pena, c'era il pubblico esempio: tutti gli scolari di tutte le classi, in un atrio, messi in quadrato, assistevano al cavallo come i soldati d'oggi alla degradazione d'un loro camerata indegno.
Il Buon Pastore era l'istituto scolastico dove la mitezza era bandita; i regolamenti, in tutto il significato, eran disumani. Nelle trasgressioni, dalle palmate e dai cavalli si andava al digiuno in pane ed acqua, dal digiuno al carcere, dal carcere ai ceppi. I ceppi peraltro erano l'argomento più comunemente usato nei seminari, negli istituti di educazione e perfino nei conventi. Ad un alunno orfano che fuggisse dal Buon Pastore, appena ripreso, veniva applicata la pena di quindici giorni di ergastolo e di venti sferzate al giorno; alla prima recidiva era aggiunto il digiuno; alla seconda, l'esilio con l'imbarco sul primo bastimento che facesse vela dal nostro porto444.
Ed il Cielo non avea fulmini per l'inventore di pena così scellerata?!...
Allorchè vi andò Rettore il Santacolomba, e vi trovò quelle tradizioni tiranniche, ne rimase tanto disgustato che non volle più saperne. Diceva egli: «Quando un ragazzo arrossisce, per me è punito. Quella tinta che si estende sul di lui volto, mostra il colore della virtù, e come questa non può far lega col vizio, così non ho alcun dubbio che rossore e ravvedimento camminano sempre in ottima compagnia: l'impegno del Rettore non dovrà esser quello di rendere infelice il figliuolo (del Buon Pastore), ma di ricuperarlo dolcemente emendato»445. E proscrisse quei crudeli trattamenti. Tuttavia nel 1832 i ceppi erano ancora parte della educazione cotidiana.
Anime gentili come il Santacolomba molte ne vantava il paese. L'Airoldi, p. e., nell'impartire le istruzioni ai superiori dei conventi per le scuole da aprirsi, facevasi eco di quelle anime raccomandando «fosse la disciplina scolastica mantenuta meglio per via della ragione, dell'amore e della vergogna che per quella dei castighi e delle sferzate, con che si suole l'animo abbassare e fare un abito vilissimo di durezza e di servitù». Una massima siciliana poi, che vale tant'oro, sentenziava:
Lu suverchiu castigariFa spissu 'mpijurari (peggiorare).
La disciplina, com'è da credere, con questi castighi non era sempre la migliore. Dove sono fanciulli sono anche monellerie: e le monellerie di quelle generazioni ci fanno ricordare non pur le birichinate sorprese dal Villabianca a' Crociferi, non pur le solite pallottole di carta e le burle alle spalle del maestro; ma altresì il chiasso e gli schiamazzi. Le scenate universitarie innanzi descritte danno una lontana idea dei non infrequenti disordini di certe scuole o di certe classi.
Di questo nessun cronista fa cenno, perchè sono appunto le cose ordinarie quelle che sfuggono a chi rileva le straordinarie. Ma gli archivî del Governo ne serbano documento e, che è notevole, anche fuori la Capitale. Nelle regie scuole di Trapani la Commissione suprema della Istruzione ed Educazione in Sicilia dovette occuparsi seriamente della indisciplinatezza di alunni divenuti assolutamente incorreggibili. Un rapporto ufficiale li dipinge insolenti, insubordinati. A capriccio salavano la scuola (facevanu Sicilia), a piacere stabilivano vacanze. Invitati a far circolo, sistema allora molto in voga per la ripetizione che precedeva la entrata in classe, sotto la direzione d'un compagno detto centurione, si rifiutavano; di esercizî letterarî non volevan sapere; e rimbaldendosi l'un l'altro scioperavano passeggiando per l'atrio e cantando canzoni446.
Affermare quindi che tutti studiassero, è menzogna. Come sempre e dappertutto, c'era chi studiava molto e chi non istudiava nè molto nè poco; ma, indizio notevole, i pochi libri da studio, anche sciupacchiati, religiosamente si conservavano. Sottolineiamo la parola pochi, perchè dai molti che ora s'infliggono a scolari ed a genitori dipende una parte dei mali dell'istruzione presente. In quei pochi libri, nella prima e nell'ultima pagina, gli alunni si affrettavano a scrivere di propria mano formole tradizionali che rivelavano l'attaccamento loro alla piccola proprietà447.
Mutati i tempi, con la guadagnata libertà, le cose radicalmente mutarono. Per interessi di autori e di editori, con grave danno delle famiglie di ristretta fortuna, i libri scolastici si cangiarono di anno in anno, con ingiustificabili sostituzioni.
Dove una volta si studiava per imparare, e dell'imparato dar pubbliche prove, venuto il 1860 si cominciò a sbadigliare sulle tesi che dovean servire agli esami, niente importando se si fosse appreso o no. Superati i quali, e lasciatasi la scuola, si barattano ora con pochi soldi i libri che dovrebbero costituire i cari ricordi dell'adolescenza. Con pochi soldi, diciamo, non perchè questi possano servire a bisogni della vita a soddisfazione di capricci di gioventù, ma per dispetto della ingrata materia e per avversione alla scuola, ragione di lunghi, angosciosi palpiti. Laonde si assiste allo scandaloso spettacolo di botteghe di compra-vendita di libri scolastici, rifiuto di stanchi vincitori di licenze tecniche, ginnasiali, liceali, o di bocciati, che non sapendo fare altro, poichè ad altro non sarebbero buoni, si danno al facile mestiere di giornalisti, insolentendo audacissimi contro gl'insegnanti che li han riprovati.
Nè lascerò di dir, perch'altri m'oda,
che le antiche sferzate di maestri irritabili e maneschi a scolari indisciplinati o riottosi vengono sostituite, poco dopo una bocciatura, con revolverate agli esaminatori, o violenti attentati alla propria vita: manifestazione morbosa, della quale tutti debbono ritenersi egualmente responsabili: governanti, insegnanti, famiglie e scolari. Che per malintesa avversione al passato, tutto di quello volle mettersi in bando, il cattivo ed il buono, rinunciandosi alla esperienza più volte secolare. Non si guardò alle condizioni speciali delle singole regioni, nè alla storia locale; e si fecero, disfecero, rifecero, per tornarsi a disfare, non sempre migliorando, leggi, regolamenti, programmi, la osservanza dei quali ridusse i maestri ad uomini senza libertà d'iniziativa, in lotta continua con la propria coscienza, agitata dalla severità di certe leggi, dallo stato d'animo di chi le applica e dagli effetti perniciosi di applicazioni inconsulte. Così fanciulli e giovani presero a odiare gli studî, e nei maestri videro, non già padri affettuosi e consiglieri sapienti, ma nemici senza cuore. Dall'esempio cristiano dei loro genitori di rado trassero ragione di rassegnarsi alle piccole contrarietà della vita, o di levarsi a considerazioni di morale evangelica; giacchè come non la udirono sempre dai loro educatori, così non sempre la trovarono in famiglia. E quando dopo di aver sorpreso in un loro maestro un gesto, un motto imprudente, legato ad una inconsulta allusione religiosa, tornarono in casa, e nei loro genitori, nei loro nonni trovarono gesti e motti ben diversi da quello, non seppero comprendere se la ragione fosse di costoro o del maestro medesimo, il quale, appunto perchè preposto ad istruire e ad educare, dovea saperne più dei genitori e dei nonni.
Di più direi, ma di men dir bisogna!
CONCLUSIONE.
Nella lunga corsa per la vecchia Palermo abbiam dovuto lasciare argomenti di molta importanza economica, civile, ecclesiastica: lo scarso commercio e le ingegnose manifatture, il movimento del porto ed i pubblici mercati, il sentimento religioso ed il culto esteriore, le opere di carità e gl'istituti di beneficenza. Ragione di particolare attenzione apparivano agli occhi nostri le condizioni della Chiesa, le quali trovammo descritte in una ardita lettera fin qui inedita dell'Ab. Cannella. Se non che, preoccupati del faticoso cammino fatto e della possibile stanchezza del lettore, non meno che delle esigenze tipografiche, dovemmo rinunziare anche a questo, così come ai banditi del tipo classico, risorgenti, come la mitica fenice, dalle loro ceneri anche dopo la cattura e la impiccagione del famigerato Testalonga.
Eppure codesti argomenti, non poco utili alla conoscenza del sec. XVIII, ci offrivano materia curiosa e, nella sua curiosità, istruttiva.
La incerta morale del Clero avea le sue radici nella fiacca disciplina che la moderava; le velleità profane dei preti e dei frati ritraevano dal libero costume dell'alto ceto. Il sentimento religioso, vivo, intenso, benchè nelle sue manifestazioni alle volte scomposto, dell'umile gente, intiepidiva nei chierici, si offuscava in alcuni del ceto medio più intelligente, e pompeggiava con funzioni solenni nel superiore. Qualche idea volteriana, che in questo mai o quasi mai osava entrare, a quando a quando incontrava timide simpatie tra i civili, ed affacciavasi alle celle dei frati non tutti inchinevoli ad ascetiche contemplazioni e a devoti ragionari.
Mentre nella sola chiesa di Casa Professa, in un solo giorno, si comunicavano (stupefacente, ma vero!) ben trentamila persone, e per un'aurora boreale si correva all'impazzata in cerca di confessori, i letterati si bisticciavano sonettando chi pro, chi contro Voltaire448. Le anime timorate spendevano per l'acquisto dell'annuale Bolla della SS. Crociata; ma nessuna di esse stava a guardare chi mangiasse carne in giorni non permessi dalla Chiesa: ed alla mensa di due Arcivescovi (Lopez e Adami), proprio nei giorni di magro, venivano servite anguille di Messina e vitella di Sorrento. Attiva la caccia ai libri proibiti, ma frustrata dalle inclinazioni di molti, sì che ad un forestiere, commensale dei due prelati, offerivasi la celebre Lettre de Trasibule e l'Examen important449; ed in quella che ogni luogo echeggiava di severe censure alle nuove fogge di vestire, molti sacerdoti, quasi frustini sfaccendati, andavano bighellonando per la città in abiti borghesi a colore, stivaloni e capelli incipriati450.
Gli è che alla santità della fede talora riusciva inefficace la disciplina ecclesiastica; e sommamente dannosa fu la gestione dell'ultimo Arcivescovo del secolo (Lopez y Royo), più delle apparenze curante che della sostanza, più dei suoi personali interessi che di quelli ben più gravi della religione. Non uno slancio da mente illuminata in costui, non un impeto che rivelasse la genialità di sentimenti generosi ond'egli primo avrebbe dovuto farsi banditore. La mondanità delle forme era in esso pari alla mal celata ambizione; e se Palermo non degradò dal culto sincero delle cose divine, si dovette alle convinzioni profondamente radicate nelle coscienze, e neppure sfiorate dal soffio degli enciclopedisti.
Ma fra tanti e sì stridenti contrasti la carità non difettava mai. Numerose opere pie componevano il tesoro dei poveri e dei derelitti. Se a tutte le miserie non riuscivano a provvedere, perchè immense quanto il mare son le sventure, a molte recavan sollievo, e più ancora ne avrebbero recato se alcuni beneficî fossero stati informati a principî diversi da quelli dominanti nel tempo in cui nacquero.
La Società moderna rimane impassibile o sorpresa a certi scopi di legati d'allora; ma ha torto nel giudicarli coi criterî che si son venuti formando da mezzo secolo in qua. Bisogna ricordarsi che una delle grandi preoccupazioni, se non la più grande, era l'anima, nella cui salute si erogavano sostanze, la legittimità delle quali nessuno metteva in discussione. Quindi i legati a favore di ordini religiosi e di cappelle, dove come in propria casa i confrati si adunavano. Le cosiddette congregazioni o compagnie erano un completamento della famiglia; famiglia più larga, intesa a considerazioni sull'ultimo fine; e tra i legati ve ne avea così per esse come per le chiese, tanto per consanguinei poveri quante per orfane estranee. Nel solo anno 1790 si ebbero fino a nove istituzioni di cosiffatti legati.
La ricerca del nuovo patrimonio dovuto alla divozione ed alla carità nelle ultime decadi del settecento a confronto del patrimonio dei secoli precedenti darebbe oggi sorprese confortevoli alle anime bennate; ma, checchè ne sia, mentre in codeste maniere si affermavano le supreme volontà dei benefattori, centinaia di beneficî vigoreggiavano.
La lista delle opere pie palermitane parla dolcemente al cuore, e conferma come nulla si trascurasse per venire in soccorso degli infelici: donne traviate, fanciulle pericolanti, infermi mancanti di cure, bambini senza sostegno, carcerati privi di pane, condannati laceri e scalzi. Carità sublime quella, alla quale nessun giornale profondeva lodi smaccate a scapito della verecondia dei benefattori. La bramosia di rumore intorno al proprio nome poteva forse, perchè umana, affacciarsi all'animo loro; ma non lasciava svaporare la fragranza del fiore gentile della carità, olezzante perenne e benedetto. Non si sognava la teatralità delle opere buone, non il compenso materiale del bene spontaneamente concepito e santamente condotto; unico movente, unico compenso del bene, il bene stesso.
E frattanto, per lunga inerzia, sonnacchioso il paese trascinava la vita alla quale era stato abituato da Vicerè stranieri, avidi di pompe e di danaro, e da ministri, ciechi o avveduti strumenti di quei Vicerè.
Tra molli ozii intorpidivano i ricchi, d'altro non curanti se non di ciò che meglio assicurasse il quieto lor vivere col godimento, per chi ne avesse, di titoli e di fasti. Carezzavali il Governo e, come per compenso, ne ricavava forza, che alla sua volta su di essi rispecchiava e profondeva. Del ceto civile, gl'impiegati sbarcavano placidamente il lunario guardandosi dal far cosa che potesse dispiacere ai superiori o compromettere l'ordine interno; ed i professionisti grossi e piccini dalle dovizie delle case nobili, dai piati dei litiganti e dalle amministrazioni delle comunità religiose ritraevano chi sussistenza, chi agiatezza.
La innata passione di gareggiare in lusso con la classe elevata imponeva loro spese che consumavano le ordinarie entrate: gara che per imitazione ne tirava dietro un'altra: quella degli operai.
La grande massa del popolo, purchè il pane costasse poco (ed il Senato lo dava a buon mercato, anche a scapito dell'erario del Comune) e le feste non mancassero, si sfamava e restava contenta.
Potente come la Nobiltà il Clero secolare e regolare, rispettato se alto e dotto, tollerato se basso; ma pur sempre tenuto di conto, se non altro pel numero.
Non una parola di fuoco che accendesse gli spiriti; non un atto che sorreggesse le fedi vacillanti, che sollevasse alla visione d'una Sicilia forte, libera e indipendente. Il tentativo del Di Blasi fu un'allucinazione generosa al miraggio della libertà francese, tirannide di folle boccheggianti attorno agli alberi della libertà, in Italia grottescamente parodiati.
Qualche anno dell'ottocento dovea passare perchè si uscisse dall'eterno torpore. La Società incominciava una lenta, insensibile evoluzione. La forza di volontà dei maggiorenni, già viva e gagliarda in tutte le sue esteriorità, svigorita pel prolungato consumo dell'organismo sociale e pei continui ritagli di privilegi e preminenze operati dagli ultimi Vicerè, volgeva a completo esaurimento.
Il patriziato era caduto in istanchezza: e quando con l'atto memorando del 20 luglio 1812 il Braccio baronale del Parlamento siciliano faceva spontaneo sacrificio di quei privilegi e di quelle preminenze, esso compieva sì un nobile atto di patriottismo, ma rinunziava ufficialmente al resto di ciò che avea parte perduto, parte dimenticato. Le energie d'una volta, spossate, si trasformavano in nuove energie come per prepararsi a combattere il dominio del passato ed a sostenere le lotte dell'avvenire.
Nei primi sessant'anni del secolo XIX, in mezzo a turbinose vicende, la storica Capitale seguì una via ascendente di progresso: debole progresso, è vero, ma reale e palpabile. Tra giuramenti di principi fedifraghi ed aspirazioni e sommosse di popoli, tra violente repressioni di governanti e fremiti sdegnosi di vittime, tra concessioni coraggiosamente reclamate e riforme ineluttabilmente imposte dal fatale incalzare degli eventi, il paese con la coscienza dell'esser suo e con la forza della sua storia acquistava dignità novella.
L'asservimento forzato al Governo di Napoli, l'antigeografico titolo di Regno delle due Sicilie al quale l'Isola dovette sottostare, non impedirono il rinnovamento della Città.
Il 1860 trovò Palermo pronta ad immolare sull'altare della Unità d'Italia la sua autonomia. Pur di conseguire la libertà, che, ben intesa e mantenuta, è base e guarentigia di civile floridezza, unì incondizionatamente le sue sorti a quella degli altri Stati della Penisola e diventò provincia del nuovo Regno.
Abolite da mezzo secolo ma non dimenticate le antonomastiche Costituzioni, la storia di Palermo, che è storia di Sicilia, si confuse e si perdette nella storia d'Italia; ma Palermo si fece più grande, più bella, degna in tutto e per tutto delle principali città sorelle di Terraferma.
Le sue mura di città crollarono; i suoi bastioni di giorno in giorno cedettero il posto ad infinite abitazioni private e pubbliche; le sue porte restarono solo di nome. L'antica Capitale si triplicò fuori di se stessa: e le quattro miglia di suo circuito divennero tre volte tanto, e sulla immensa pianura di orti, giardini, oliveti e spiagge gli abitanti si riversarono in cerca di aria, di luce, di verde, di cielo, di mare.
Ogni giorno che passa è una casa, un edificio che cade sotto il piccone inesorabile del muratore, e con esso un ricordo che si dilegua dalla memoria di chi resta. E non pure il passato, ma anche il presente cade a brandelli. I fatti avvenuti ieri s'involano agli occhi nostri precipitando nel baratro delle memorie irrevocabili. Nel tempo che fugge s'incalzano con rapidità fulminea uomini e cose. Solo resta immutato, vecchio e perennemente giovane, il popolo; sul quale due, tre secoli non son per altro passati che per modificare vestiti non più compatibili col continuo rinnovamento della moda. I suoi catodî, minacciati da periodiche velleità di trasformazioni edilizie, son sempre lì, per naturale inclinazione della genterella che li abita, uniformi, puliti, ma angusti, sovente scarsi più sovente privi di luce; e si legano e stringono, o si dividono e discostano per formare vicoli tortuosi, gradinate sostituite a rampe di antichi dislivelli, piazzuole irregolari, cortili ciechi, reconditi, sinistri, ignoti perfino ai popolani del quartiere. Quivi formicolano parecchie centinaia di migliaia di uomini, donne, fanciulli con tradizionali usanze e leggende che richiamano a consuetudini scomparse.
Ma il ceto medio e l'alto, non del tutto smorbati dal tradizionale spagnolesimo, con mirabile prontezza si sono assimilati quanto di nuovo offre la vita moderna del continente: il grande, il bello, che non può sfuggire agli ammiratori delle cose grandi e belle.
Possa tu, o Palermo, vanto della Sicilia, con l'Italia forte, avanzare in prosperità! Possano le più miti aure carezzarti di dolci baci, ed il cielo giocondarti di perenne sorriso! Possano i tuoi figli renderti beata di domestiche e civili virtù!
Ecco l'augurio, che l'ultimo dei tuoi devoti fa per te, vecchia Palermo ringiovanita,
Patria, diva, santa genitrice!
RAGGUAGLIO
Una salma = ad ettolitri 2, 74.Un quintale (rotoli 100) = chilogr. 80.Un rotolo = ettogr. 7, 9 decagr.Un'oncia = decagr. 7.Un'onza = lire 12, 75.Un tarì = lire 0,42.Un grano = lire 0,02.Uno scudo = lire 5,10.Un ducato = lire 4,25.
NOTE
| [1] | Villabianca, Diario palermitano, in Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia, di G. Di Marzo, v. XXVI, p. 294. |
| [2] | Pitrè, Usi e Costumi, v. I, pp. 26-27. |
| [3] | Novelle Miscellanee, p. 19. — Villabianca, Diario, in Bibliot., v. XXVI, pp. 8-12; Diario ined., a. 1787, p. 58; a. 1793, p. 59; a. 1800, p. 399. |
| [4] | Creuzé de Lesser, Voyage en Italie et en Sicile, p. 107. A Paris, MDCCCVI. |
| [5] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 8, 12, 121-122. |
| [6] | Dolci composti di pasta di mandorle, che prendono ancora nome dal monastero, dove particolarmente si manipolavano. |
| [7] | Villabianca, Diario ined., a. 1800, pp. 94-100, 151-63. |
| [8] | Diario, in Bibl., v. XIX, pp. 198-99; v. XVIII, p. 244; v. XXVI, p. 157; v. XXVII, pp. 243-44. |
| [9] | Diario ined., a. 1793, p. 59 e così negli anni 1795 e 1796. |
| [10] | Vedi in questo volume il cap. sulla Giustizia; e nel precedente il cap. XXIII. |
| [11] | Pitrè, Usi e Costumi, v. I, pp. 98 e 107. |
| [12] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 175, 285, 316; Diario ined., a. 1797, pp. 109-110. |
| [13] | Houel, Voyage pittoresque des îles de Sicile, de Malte et de Lipari, t. I, pp. 72-73. Paris, 1782. |
| [14] | Villabianca, Diario ined., a. 1786, p. 493; a. 1792, p. 295; a. 1793, p. 37. |
| [15] | Pitrè, Spettacoli e Feste, pp. 288, 313, 324, 339, 342 e segg. |
| [16] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 321-22; v. XIX, p. 35. — Palermo d'oggigiorno, v. II, p. 111. — Rezzonico, op. cit., v. II, p. 106 e segg. — Raccolta di Notizie, 9 Sett. 1801. |
| [17] | Nel 1835 la commemorazione era già ridotta ad una semplice scarrozzata lungo la via che conduce alla Rocca. Oggi nessuno ricorda più nè l'antichissima gita — s'intende dell'8 settembre — a Monreale, nè la passeggiata alla Rocca. |
| [18] | La frase interrogativa: A lu Spitali veni pri pezzi? (tu vieni a cercare pezze all'ospedale?) a chi ci chieda cose delle quali abbiamo difetto, parla chiaro. |
| [19] | Quattromani, Lettere su Messina e Palermo, n. LVII, pp. 213-14. Palermo, 1836. |
| [20] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 23-24; v. XXVII, pp. 299-300. Per la festa del 1800 si può vedere la descrizione nel Diario ined., 12 giugno, pp. 296-301. |
| [21] | Vedi v. I, p. 128. |
| [22] | Pitrè, Spettacoli e Feste, pp. 419-23. |
| [23] | Mmiscu, era ed è un liquore a base di rosolio, alcol e erbe aromatiche. Petrafènnula, dolce duro, composto di cedro tritato, cotto nel miele e condito con aromi. Zammù, anice, fumetto. |
| [24] | Brydone, A tour through Sicily a. Malta, lett. XXV. London, 1773-76. |
| [25] | Houel, op. cit., t. I, p. 73 e segg. |
| [26] | De Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile, t. IV, pp. 144-48. Paris, 1784. |
| [27] | Goethe, Italienische Reise, lett. 13-14 Aprile 1787. Queste ed altre testimonianze e descrizioni particolareggiate di quelle feste vennero raccolte, tradotte ed annotate da Maria Pitrè, Le Feste di S.a Rosalia in Palermo e dell'Assunta in Messina. Palermo, 1900; e nella Appendice, Pal. 1903. |
| [28] | Provviste del Senato, a. 1791, pp. 398 e 412. |
| [29] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, p. 134. |
| [30] | Ciò avvenne particolarmente l'a. 1768, come si rileva dal Diario del Villabianca, in Bibl., v. XIX, p. 124. |
| [31] | Houel, op. cit. — Maria Pitrè, Le Feste di S.a Rosalia ecc., p. 47. |
| [32] | Erano le fontane, oggi abbandonate, fatte eseguire dall'Arcivescovo dal Testa. |
| [33] | Rezzonico, Viaggio della Sicilia e di Malta, in Opere raccolte e pubblicate dal prof. Fr. Mochetti, t. V, pp. 106 e segg. Como, 1817. |
| [34] | Raccolta di Notizie, n. 36, Palermo, 4 Maggio, 1801. |
| [35] | Des Ballons aérostatiques, de la manière de les construire, de les faire élever ecc. Orné des planches en taille douce. A Lausanne, chez J. P. Heubach, MDCCLXXXIV. |
| [36] | Ragguaglio dei palloni aerostatici lavorati con felice successo da D. Ercole M. Branciforti e Pignatelli ecc. In Palermo, MDCCXXXIV. Dalle Stampe del Bentivegna. |
| [37] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, p. 213. — Torremuzza, Giornale ined., p. 313. |
| [38] | Brydone, op. cit., lett. XXIX. |
| [39] | Opuscoli palermitani, n. 2, p. 53. Ms. Qq E 94 della Bibl. Com. di Palermo. |
| [40] | G. Lanza e Branciforti, Diario storico, anno 1798. Ms. inedito della Biblioteca dell'on. Principe Pietro Lanza di Trabia e di Butera. |
| [41] | Sarebbe forse D. Gioacchino Torre, a cui tra gli altri si rivolge con un brindisi il Meli? (vedi Opere poetiche, p. 286. Palermo 1894). |
| [42] | G. Lanza e Branciforti, Diario cit. |
| [43] | Alcuni furono soscrittori del Memoriale che segue. |
| [44] | G. Lanza e Branciforti, Diario cit. |
| [45] | Vedi Penes Acta, nell'Archivio Comunale, an. 1799: Memoriale dei dilettanti e giocatori del gioco del Pallone di questa città di Palermo al Re. |
| [46] | Bartels, Briefe über Kalabrien und Sizilien, v. III p. 723. |
| [47] | Penes Acta, nell'Arch. Comunale, a. 1799. |
| [48] | De Saint-Non, op. cit., p. 143. |
| [49] | Provviste del Senato, a. 1799-80; a. 1786, p. 135. |
| [50] | Per la storia da scriversi del nostro teatro è utile notare che qualche volta in questo teatro agivano dei filodrammatici. Abbiamo sott'occhio un Argomento della Commedia del Marchese di Liveri intitolata Il Solitario, la quale si rappresenta nel domestico Teatro dei Signori Marchesi di S. Lucia, da una Brigata di Nobili, e Dilettanti. In Palermo, MDCCLXVII. Nella Stamperia dei Santi Apostoli in Piazza Vigliena presso D. Gaetano M.a Bentivegna. In-4º, pp. 7. |
| [51] | Un uomo altolocato in Palermo diceva al Bartels queste gravi parole: «Si vocifera che il denaro esatto (per le strade) sarà forse impiegato per la fabbrica di un nuovo teatro in Palermo. Non è da credersi; ma il Governo di Sicilia fa vedere cose più mostruose». Bartels, Briefe, n. XXXIII, vol. II, p. 519. |
| [52] | Villabianca, Diario ined., a. 1787, p. 163; a. 1793, p. 59; a. 1798, pp. 25-26. — Santacolomba, L'Educazione della Gioventù ecc. pp. 421-22. In Palermo, MDCCLXXV. |
| [53] | Palermo, 4 febbr. 1800. |
| [54] | Reali Dispacci, an. 1784, registro n. 1510, fogli 152-53 dell'Archivio di Stato di Palermo. |
| [55] | C. Dassori, Opere e Operisti, Dizionario lirico universale (1541-1902), p. 666. Genova, 1903. |
| [56] | Anni 1787, 1788, 1798-99 ecc. |
| [57] | Nota presa nella Biblioteca del Principe di Trabia e nel Giornale di Sicilia del 5 agosto 1794. |
| [58] | Dassori, op. cit., p. 799, attribuisce a Silvestro Palma quest'opera, che dice primamente rappresentata in Napoli, nel 1792. |
| [59] | Probabilmente è Il trionfo di Giuditta, azione sacra di Pietro Guglielmi, stata eseguita più tardi nell'Oratorio di S. Filippo Neri. Se non che, una edizione se ne ha di «Palermo MDCCCVI, nella Stamperia del Solli». |
| [60] | Diario ined., a. 1798, pp. 25-26. |
| [61] | D'Angelo, Giornale ined., a. 1797, p. 142. |
| [62] | I Puntigli per equivoco, commedia per musica da rappresentarsi nel R. Teatro S. Cecilia. In Palermo, MDCCXCVII. |
| [63] | Meli, Poesie, p. 65. |
| [64] | Ms. Qq E 88, p. 2, della Bibl. Comunale; e Diario, in Bibl., v. XIX, p. 141. |
| [65] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, p. 269. L'aneddoto, un po' travisato, con un'aggiunta senza base storica, è stato riportato dal giornale L'Ora, a. II, n. 231, da un recente libro di memorie di un artista ultimamente pubblicato a Parigi (1901). |
| [66] | Gennaio 1798. R. Segreteria, n. 5290. Archivio di Stato di Palermo. |
| [67] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, p. 243. |
| [68] | Villabianca, Diario ined., a. 1798, pp. 28, 58, 68. — D'Angelo, Giornale ined., p. 179. La stampa della poesia è senza indicazione tipografica. |
| [69] | Palermo, Gagliani, 1798. |
| [70] | Poesie, p. 374. |
| [71] | La notizia è accennata dal Palmieri de Miccichè, Pensées et Souvenirs, t. II, ch. XLII; ma per errore portata verso il 1792-93, quando la Corte era invece a Napoli. |
| [72] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 97, 353. |
| [73] | Vedi lettera del Vicerè Colonna al Maresciallo Don Gaetano Sances de Luna, in data del 15 agosto 1780, in Reali Dispacci, registro n. 210, foglio 20, dell'Archivio di Stato di Palermo. |
| [74] | Risposta del 26 maggio 1797. |
| [75] | Di Semiramidi, fino al 1800 se ne contavano 24, principiando da quella di M. A. Cesti (1667) e finendo all'altra del Cimarosa, la quale però venne la prima volta eseguita in Napoli nel 1799. Probabilmente si voleva quella, altre volte udita, del Paisiello, eseguita primamente in Roma nel 1773. |
| [76] | Il viaggiatore R. de Saint-Non lasciò scritto: «L'opera comincia a un'ora di notte e finisce a mezzanotte e anche più tardi». |
| [77] | Lettera del 28 luglio 1795. R. Segreteria, n. 5290. Archivio di Stato di Palermo. |
| [78] | Capitoli, o siano Statuti dell'Unione dei Musici sotto il titolo di S.a Cecilia ecc., cap. XVIII. |
| [79] | Vedi il cap. seguente. |
| [80] | R. Segreteria, n. 5290. |
| [81] | Rescritto sovrano, datato da Napoli, 22 gennaio 1797. R. Segreteria, n. 3290. Arch. di Stato di Palermo. |
| [82] | Hager, Gemälde von Palermo, pp. 85, 91. Berlin, 1799. |
| [83] | Galt, Voyages and Travels, pp. 33-36. |
| [84] | Galt, Voyages and Travels, p. 36. |
| [85] | Hager, loc. cit., p. 94. |
| [86] | Vedi v. I, cap. II, p. 26-27. |
| [87] | «Commedie improntate burlesche dette bastasate, le quali però non ostante che ignobili sono le più frequentate». Villabianca, Diario ined., a. 1794, p. 420. |
| [88] | Il parrocco G. Alessi ci lasciò questa nota, che non vien confermata da nessuno: «Oggi (1795) la voce farsa è andata in disuso; chiamasi zanni e suol farsi nel piano della Marina ed in quello dei Bologni.» Aneddoti, n. 35, Ms Qq H 43 della Biblioteca Comunale. Il Villabianca in uno dei dieci ricordi che nel suo Diario inedito fa, dal 1785 al 1800, dei Casotti, sotto la data del 1790 scriveva: «In Piazza Marina, nel Casotto, commedie ordinarie, cioè improntate, fatte da nostrali comici, bastasate in lingua siciliana, che sono opere buffe, nelle quali fa (agisce) il celebre Giuseppe Marotta». Ms. Qq D 111, p. 365. |
| [89] | Reali Dispacci, n. 1514, foglio 141 retro, nell'Archivio di Stato di Palermo. |
| [90] | R. Segreteria, Incartamenti, n. 5290, a. 1793-99. |
| [91] | 1. Onofrio ed Elisa, cavaliere e dama per forza, ossia il fanatismo dei facchini. — 2. Onofrio ladro in campagna e galantuomo in città. — 3. Onofrio disertore. — 4. I due anelli magici. — 5. I contratti rotti. — 6. Testalonga e Guarnaccia. — 7. La nascita di Onofrio dall'ovo. — 8. Le metamorfosi di Onofrio. — 9. Onofrio finto sordo e muto per non pagare i debiti. — 10. L'equivoco del manto. — 11. La pentola. — 12. Le torce dei diavoli. — 13. La magia di Corvastro e Fagiani. — 14. Onofrio finto principessa. — 15. Lo spirito folletto di Elisa. — 16. Il fuori fuori. — 17. Onofrio servo sciocco. — 18. I quattro rivali in duello. — 19. Quattro Onofrii in un punto. — 20. I vecchi burlati. — 21. Il cortile degli Aragonesi. — 22. La anatomia di Onofrio. — 23. Onofrio re dormendo. — 24. Onofrio marito geloso. — 25. Le 99 disgrazie di Onofrio. — 26. Onofrio finto imperatore del gran Mogol. A questi bisogna aggiungere: 27. La Calata di Baida. — 28. Lo Spedale dei pazzi. — 29. La venuta dello sposo dalla tonnara. — 30. Venuta di Lappanio da Cianciana. Vedi un articolo di Ag. Gallo nell'Indagatore siciliano, a. I, v. I., fasc. I. Pal. 1834, e un altro di P. Lanza nelle Effemeridi scientifiche e letter., t. X, a. III, p. 345-46, Pal. 1834. Cfr. Caminneci, Brevi Cenni storici, ecc. Pal. 1884. |
| [92] | Villabianca, Diario ined., 1796, p. 282. |
| [93] | Gemälde von Palermo, pp. 93-94. |
| [94] | Galt, op. cit. |
| [95] | Risposta del 21 giugno 1793 in R. Segreteria, Incartamenti, n. 5290. Vedi anche passim in questo volume. |
| [96] | Meli, Riflessioni, p. 18. |
| [97] | Nella domanda con la quale egli vuol rifarsi delle perdite sofferte, era detto press'a poco questo: L'annata è stata orribile; i caffettieri stessi, che nella Marina sogliono alzare baracche in estate per i sorbetti, a cagione del caro degli zuccheri abbandonarono il posto; io vi rimasi per divertire il pubblico. Concedetemi il casotto anche pel 1794 per farvi rappresentare «la coppia della bastasata». Ricordiamoci del resto della carestia, delle febbri e della moria di quell'anno, non solo in Palermo, ma anche in gran parte dell'Isola. |
| [98] | Palermo, Per De Luca. (Foglio volante). |
| [99] | Lettere su Messina e Palermo, lett. XXXI, p. 129. |
| [100] | Cfr. il cap. Accademie {p. 375}. |
| [101] | Villabianca, Diario edito ed inedito, anni 1773, 1777, 1789, 1790, 1794, 1797. Vedi anche i mss. di Casa Trabia. |
| [102] | Torremuzza, Giornale ined., p. 450. |
| [103] | R. Segreteria, Incartamenti, n. 5290. |
| [104] | Guerra, Stato presente della Città di Messina, Napoli, 1781. |
| [105] | Possediamo un bel volume, contenente una trentina di queste sacre azioni. La collezione porta la data del 1806 e del 1807 (vi sono oratorî anche nel 1810); ma si tratta di ristampe. La sola Iª parte del Trionfo della Religione è «per le stampe del Barravecchia, 1807». |
| [106] | La morte di Sansone, dramma per musica ecc. da cantarsi nell'Oratorio dei RR. PP. della Congregazione di S. Filippo Neri. Parte I. In Palermo, nella stamperia del Solli. |
| [107] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 331; XXVIII, p. 30. |
| [108] | Capitoli o siano Statuti dell'Unione dei Musici sotto titolo di Santa Cecilia, nuovamente raccolti ed ordinati, e dopo le conferme di molti Viceregnanti approvati dall'Ecc.mo Sig. Vicerè Giovanni Fogliani, cap. XIX. In Palermo, MDCCLXII. Nella Stamperia dei SS. Apostoli presso P. Bentivenga. |
| [109] | G. Gargarosso, La fidilissima Sicilia e lu so invittu Munarca Filippu V, p. 8. In Palermo, pri Filici Marinu, 1711. |
| [110] | Riforma fatta dalla Regia Giunta, p. 21. In Palermo MDCCXCI. |
| [111] | Santacolomba, La Educazione della Gioventù ecc. p. 44. |
| [112] | Vedi nota seguente. |
| [113] | Cap. XVII, p. 39. |
| [114] | Vedi il nostro opuscolo, Modi Proverbiali ecc. di Palermo, n. 13. Palermo, 1902. |
| [115] | Si consulti l'esemplare dei Capitoli cit., posseduto dall'Unione dei Musici, per dono fatto il dì 21 sett. 1894 da Giovanni Pitucco. Questo esemplare per le note a penna che contiene ha valore di documento originale. |
| [116] | Capitoli cit., p. 5. |
| [117] | Un giornale del 1794 parla d'un cembalo di Grimaldi ad ottava stesa, che arriva nei cantini al delasolrè. |
| [118] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, p. 109. |
| [119] | Per tutta l'estate questa musica costava al comune 130 onze (Riforma cit., p. 23). Essa cominciò, nella medesima Marina, nel 1591, quando, aperta la strada Colonna, il Senato vi fece passare pei mesi di giugno-settembre, esclusi i venerdì, i virtuosi che solevano sonare nel palazzo pretorio nei giorni di lunedì o mercoledì. Ciascuno di essi godeva un salario di onze 30 e n'ebbe aggiunto un altro di onze 6. E qui giova notare che prima di quell'anno, fino al 1583, in cui rovinò, luogo di diporto e di svago estivo, specialmente o forse esclusivamente per le signore, era il terrapieno sulla Cala, rimpetto il Castello a mare, dalla parte settentrionale, dove ora è S. Spirito, chiamata la Sala delle dame. Vedi A. Flandina, La Sala delle Dame in Palermo (Pal. 1879). |
| [120] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, pp. 172-173. |
| [121] | Vedi v. I, cap. XXV. |
| [122] | R. Segreteria, Incartamenti, n. 5290. |
| [123] | Forno, Opuscoli cit., II, p. CCLVI. |
| [124] | Ortolani, op. cit., p. 49. |
| [125] | Gorani, op. cit., t. I, p. 47. |
| [126] | Provviste del Senato, a. 1783-84. p. 429. |
| [127] | Storico anche questo; l'abbiamo raccolto dalla bocca di vecchi canonici della Cattedrale di Palermo, uno dei quali vive ancora. |
| [128] | Riforma cit. (a p. 106 del v. I di quest'opera), p. 60. — I. Sala, Dimostrazione dello Stato del Patrimonio del Senato di Palermo, presentato alla Giunta eretta pella fissazione del detto Patrimonio. Ms. dell'Archivio Comunale di Palermo. |
| [129] | D'Angelo, Giornale ined., a. 1799., pp. 269-71. |
| [130] | «Il Predicatore quaresimale della Madrice Chiesa di questa città per le prediche della Quaresima e panegirici e viene tenuto a fare, onze 80; e ciò in seguito di ordine di S. E., per via del Tribunale del R. Patrimonio, li 13 maggio 1692, colla condizione che il detto Predicatore essendo regnicolo abbia da conseguire onze 60; ed essendo forestiero onze 80, come dalla Riforma del 1788.» I. Sala, Dimostrazione cit. dello Stato del Patrimonio del Senato di Palermo p. 213. |
| [131] | Villabianca, Diario ined., a. 1800, p. 66. |
| [132] | Da pochi anni l'Olivella tace; riparlerà forse, e ricominceranno i termini di paragone. |
| [133] | G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo, 2ª edizione p. 698. |
| [134] | Provviste del Senato, a. 1793-94, pp. 135 e 226. |
| [135] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, p. 8. |
| [136] | D'Angelo, Giornale ined., p. 329. |
| [137] | Breve Ragguaglio di quanto praticano in questa Capitale le Figlie della Carità, ecc. n. 12, p. XXXIV. In Pal., Felicella, MDCCLXXII. — G. Palermo, Guida cit., p. 537. |
| [138] | L'Utile col Dolce, ovvero quattro Centurie di argutissimi detti e fatti di saviissimi uomini del p. Carlo Casalicchio d. C. d. G. In Napoli, MDCCLXIV. Dal 1671 a 1764 in Napoli e Venezia se ne fecero undici edizioni. |
| [139] | Vedi i nostri Spettacoli e Feste, p. 206, e Modi proverbiali cit., n. 44. Sulle nomine dei predicatori per opera del magistrato municipale, vedi Provviste del Senato, a. 1791, p. 6; 1794, pp. 16 e 67; 1795, p. 127; 1796, p. 155; 1797, p. 42; 1799, p. 32. |
| [140] | Convento in Sicilia vale abitazione di frati. |
| [141] | Erano i Riformati, presso i quali è ancora nel convento della Gància un posto col titolo di Terra Santa. Costoro andavano in giro pei comuni dell'Isola portando le bolle dei Luoghi Santi, composte e stampate dentro il Commissariato di Terra Santa in Palermo, dove i tipografi si chiudevano, e stampavano scrupolosamente il numero prestabilito di bolle: non una di più. Codeste bolle contenevano privilegi e indulgenze agli acquisitori, e si portavano addosso, preservativi di assalti di ladri, di naufragi in fiumi, infortunî d'ogni genere nei viaggi per la Sicilia. |
| [142] | Il solo Gorani, Mémoires, I, 471, nel 1793, scriveva: «I conventi dell'Isola possiedono beni incalcolabili. Palermo ha monasteri con annuali rendite di 100,000 ducati d'argento» (L. 425,000). |
| [143] | Villabianca, Diario ined., a. 1788, pp. 677-78. |
| [144] | Mémoires, t. I, p. 471. |
| [145] | Gemälde von Palermo.... |
| [146] | Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 350; Diario ined., 28 febbraio 1799; 22.... |
| [147] | Voyage pittoresque, v. I, p. 71. |
| [148] | Bartels, Briefe, v. II, p. 658. |
| [149] | Bartels, Briefe, v. II, p. 657. |
| [150] | Mescolanze dei secoli XVI, XVII, XVIII, n. LXXXIII. Ms. Qq H 158 della Biblioteca Comunale. |
| [151] | Cfr. in questo vol. il cap. I, p. 24. |
| [152] | De Borch, Lettres, lett. XV, pp. 71-72. |
| [153] | L. Palomes, Dei Frati Minori e delle loro denominazioni. Illustrazioni e Documenti. 2ª ediz., lib. III, pp. 269-70. Palermo, 1798. |
| [154] | Dispacci di S. M. Ferdinando III. In Pal., per il Solli MDCCXCVII. |
| [155] | Letterino (fr. luterin) dicesi la tribuna, la cantoria dei musici nelle chiese. È anche il palco nel quale sta l'organo, o si affacciano persone per vedere e non esser vedute. |
| [156] | Le particolarità tutte di questa funzione concordano pienamente con quelle del Ceremoniale e le Costituzioni benedettine del Padre Tornamira e Gotho. In Palermo, Dell'Isola, MDCLXXVI. |
| [157] | Comunichino, è nelle chiese dei monasteri il luogo pel quale dalla chiesa si amministra alle monache interne la comunione. |
| [158] | Ben altro che questo troviamo nel medesimo anno e, per documento storico irrefragabile, nella seconda metà del secolo XVIII. Di una professione celebrata nel settembre del 1755, un cavaliere palermitano (che potè anche essere un ecclesiastico) scriveva: «Preceduto prima l'invito stampato, si fece con sì sontuosa e dissoluta profanità, che tutti restammo scandalizzati. Fu sino piantata avanti la porta del parlatorio una baracca di tavole, dalla quale, come si fa nei teatri, si dispensavano pubblicamente i rinfreschi; e durò questa profana solennità per tre giorni continui, fino alle cinque passate della notte. Il giuoco e il ballo, per non dir altro, vi mancarono solamente, perchè si potesse dire di stare in un festino carnale.» Altro che cuccagna! E non parliamo delle ore favorite per cosiffatte funzioni, le quali erano pomeridiane e sovente notturne! (Ragguaglio, pp. 30-31, citato più oltre, nelle pp. 175-176 {p. 166} del presente volume.) |
| [159] | «Gli sforzi dei genitori tendono ad arricchire il solo primogenito, motore precipuo l'interesse. Le povere ragazze, prendendo il velo, son costrette a rinunziare a tutti i loro beni a favore del padre, il quale alla loro morte li trasmette intatti al maggiore della famiglia.» M. Palmieri de Micciché, Pensées et Souvenirs, t. I, ch. XX. |
| [160] | Vedi circolare del 22 genn. 1782 del Vicerè Caracciolo, che richiamava il real ordine relativo alla esatta esecuzione della circolare del 6 luglio 1775 sull'argomento. Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, pp. 231-37 e v. XXVI, pp. 329-31. Mons. Michele Schiavo, giudice per modo di provvisione della R. Monarchia, nel 1763 lasciava una memoria: Per la Deputazione del Regno affin di limitarsi le doti, e le enormi spese che si verificano nei monacati delle figliuole. Ms. Qq D 146. n. 8, della Bibl. Comunale di Palermo. |
| [161] | Poesie, p. 368. Sagristana, impiegata agli uffici interni della sagrestia della chiesa; purtunara, portiera del monastero, incaricata di aprire e far accompagnare chi entri nel monastero: il medico, i fornitori di generi alimentari ecc.; cucinera, addetta a sovraintendere ai servigi della cucina; spiziala, dolciera; cillarària, economa per la cibaria; bursaria, cassiera interna; rutara, che sta in portineria, pronta alle chiamate delle persone che vengono alla ruota. Ad alcuni di questi impieghi le monache eran chiamate ad una certa età. |
| [162] | Penitente, colui o colei che abitualmente si confessa con un sacerdote. |
| [163] | «Contro la determinazione del Concilio di Trento avea quasi ogni monaca un particolare e perpetuo confessore, origine delle continue dissensioni, le quali pur troppo si sentono spesso in questi monasteri.» Ragguaglio che citeremo innanzi, pp. 175-76 {p. 166}. |
| [164] | Pupu cu l'ova, nei monasteri e nell'alta pasticceria siciliana, specie di colombina, fatta di pasta dolce con un rialzo ad un lato, con isquisita conserva. — Viscottu chinu, biscotto molle in forma convessa ed a ghirigori di sopra, e piano sotto, ripieno di conserva o crema. — Mustazzola, dolce molto duro, di farina, zucchero ed altri ingredienti, a forma di focaccia irregolarmente schiacciata, ed a ghirigori biancastri su fondo color mogano. — Pantofalu, specie di mustazzola vuota e piena di conserva di pistacchio o d'altro. |
| [165] | Mescolanze dei secoli XVI, XVII, XVIII. Ms. Qq. H 158 cit., n. XIV, della Biblioteca Comunale di Palermo. |
| [166] | Editto di D. M. P. Cusani ecc. in data dell'11 ottobre 1755. In Palermo MDCCLV, Stamperia Valenza. |
| [167] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 350. |
| [168] | Alle severe inibizioni dei seppellimenti in città (1783-8) i Vicerè non cessavano di contravvenire essi medesimi. Le chiese di Suor Vincenza, della Magione ecc. erano aperte ai cadaveri. È poi ricordo di chi scrive, come di qualsivoglia persona nata nella prima metà del sec. XIX, la inumazione nelle sepolture private o sociali di chiese appartenenti a monasteri, collegi di Maria, reclusorî, conventi, confraternite. Rinomata fra tutte, specialmente per la Nobiltà femminile, la sepoltura delle Cappuccinelle presso il Papireto. Vedi v. I cap. XXIII. |
| [169] | Villabianca, Diario ined., a. 1796, pp. 346-47. |
| [170] | A giudicare con piena conoscenza in proposito si legga la Descrizione di ciò che operarono le monache del vener. monastero dell'Immacolata Concezione di questa città di Palermo sotto il governo della Reverenda Madre suora Rosa Felice Ventimiglia normanna e sveva, Abbatessa la terza volta, per la venuta di Carlo III in Palermo. In Palermo, Amato, 1735. E sì che la Concezione non era il primo dei monasteri di Palermo! |
| [171] | Digiuna, o monaca, fa' penitenza; sconta il lusso che tu sei procurato facendo debiti! |
| [172] | Tornamira e Gotho, op. cit., p. 50. |
| [173] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXI. p. 334. |
| [174] | Houel, v. I. p. 67. Vedi il cap. Dame e Cavalieri. |
| [175] | Cfr. i nostri Canti pop. sic., 2ª ediz., v. II, n. 749. |
| [176] | Meli, Poesie: Sarudda, ditirambo. |
| [177] | Vedi: Biglietto viceregio per cui a nome di S. M. si partecipava alla Rev. Madre Priora del ven. monastero di S. Caterina l'ordine dato ecc., Palermo, 7 luglio 1764. |
| [178] | Meli, Poesie: Sarudda. |
| [179] | Hager, Gemälde, p. 117. |
| [180] | Mss. della Biblioteca Comunale di Palermo, segnati Qq 44, nn. 6, 7, 8; v. 136, n. 1, pp. 1, 58; v. 148, n. 4; v. 150, ecc. |
| [181] | Meli, Poesie: La Monaca dispirata. |
| [182] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, pp. 309-10. Versione italiana: Mille levrieri sopra una coniglia (coniglio femina), che s'era dedicata a Diana, correvano a parapiglia dietro ad essa, la quale però se ne stava ammacchiata (chiusa in monastero). Ma un cagnolino (oh gran maraviglia!), non ostante che tenesse la posta ad una lepre, lascia la lepre e con un salto prende la coniglia, e fa a tutti una canzonatura (lascia tutti con un palmo di naso). |
| [183] | G. Alessi, Prontuario (cit. a p. 223 {p. 211} del presente vol.) pag. 9. |
| [184] | Scarpe grosse e senza tacchi, con bottoni e laccetti, senza fibbie all'orecchiolo, perchè (le fibbie) si considerano come (segno di) vanità (mondana). |
| [185] | La distrae. |
| [186] | Meli, Poesie, pp. 361-71. Si cfr. anche un frammento soppresso dalla censura del tempo alla canzonetta: Nun chiù a porta filici (p. 89), e testè esumato e pubblicato (p. 396). |
| [187] | L. Sampolo, La Casa d'Istruzione e d'Emenda di Palermo, 2ª ediz., p. 21. Palermo, 1892. |
| [188] | Villabianca, Diario ined., a. 1899, p. 32. |
| [189] | Le spese che i monasteri facevano pei dolci, possono in parte vedersi dalla Relazione delli coacervi decennali delli zuccheri presi dalli monasterj di questa città dall'a. 1771 a tutto 1780, nell'Archivio Comunale di Palermo. Atti del Senato, p. 118. Nel Raziocinio (bilancio consuntivo) del triennio della Badessa del Salvatore S. M. Vittoria Arezzi, oltre 124 onze per «pietanzelle solite nell'anno», 267 per frutte, 200 per la «fiera alle religiose», sono 425 onze per «ricreazioni di zucchero ed altri dolci», non contandosene 171 di «spese di speciaria». Vedi Ms. Qq D 136, n. 12 della Biblioteca Comunale di Palermo. |
| [190] | Della prima metà del sec. XIX abbiamo a stampa un Poemettu in lodi di li Vener. Monasterj di Palermo pri li durci squisiti chi travagghianu, cumpostu di un dilittanti di durci. In-8º, pp. 16. |
| [191] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXI, pp. 212-213, 218, 224, 231. |
| [192] | D'Angelo, Giornale ined., p. 462. |
| [193] | D'Angelo, Giornale ined., p. 467. — Atti del Senato, a. 1792-93, p. 11. |
| [194] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX. pp. 20 e 26-27. |
| [195] | Provviste del Senato, a. 1787-88, p. 310. |
| [196] | Vedi v. I, cap. IV, p. 89. |
| [197] | Villabianca, Opuscoli. Ms Qq E 94, n. 3, p. 107 della Biblioteca Comunale di Palermo. |
| [198] | Provviste del Senato, a. 1780-81, pp. 639 e 1004. |
| [199] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 16-20. |
| [200] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 351. |
| [201] | D'Angelo, Giornale ined., p. 473. |
| [202] | Allegazioni nella sede vacante ecc., Vicario Mons. M. Schiavo. Ms Qq D 135. pp. 305 e 207 della Bibl. Com. di Palermo. |
| [203] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, p. 325. |
| [204] | Santacolomba, L'Educazione, pp. 194 e 360. |
| [205] | Villabianca, Diario ined., a. 1787, p. 239. |
| [206] | Villabianca, Diario ined., 18 sett. 1786, p. 666; settembre 1793, pp. 56 e 242; 7 agosto 1799, p. 188. |
| [207] | G. Lanza e Branciforti, Diario storico. |
| [208] | Villabianca, Diario ined., 12 dic. 1799, pp. 667-670. Alessi, Prontuario di alcune noterelle, ammassate brevemente alla rinfusa, concernenti alcuni fatti ed occorsi nella nostra Capitale. Ms. Qq 15 7. p. 18. della Bibl. Com. di Palermo. |
| [209] | Villabianca, Diario, in Bibl., a. 1781, v. XXVII, pp. 154-56. |
| [210] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 97; Diario ined., 12 Giugno 1785, p. 183; a. 1795, p. 239. |
| [211] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 147 e 328-29. |
| [212] | Alessi, Notizie della Sicilia, n. 74. Ms. Qq H 44 della Biblioteca Comunale di Palermo. — Pitrè, Spettacoli e Feste pop. sic., p. 198. |
| [213] | Villabianca, Diario ined., 14 agosto 1797, p. 50; 28 agosto 1798, p. 413; 7 agosto 1799. p. 188; 23 ott. 1800, p. 389. |
| [214] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, gennaio 1784, p. 190; v. XXVI, 14 aprile 1778, p. 174. |
| [215] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 218; v. XXVII, p. 22; Diario ined., a. 1794, pp. 344-45. |
| [216] | Cfr. v. I, cap. XIV, p. 267. |
| [217] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 97; v. XXVII, p. 356; e nel vol. edito del 1779 (ms. Qq D 102) p. 86. |
| [218] | G. Alessi, Prontuario di alcune noterelle ecc., p. 2. n. 14. Il Duca moriva molto più tardi, nel 1811, a 49 anni, di diabete, nella sua villa Sperlinga (attuale Ricovero Palagonia); la Duchessa nel 1816. Vedi L. M. Majorca Mortillaro, La Cappella Sperlinga, pp. 78 e segg. Palermo 1892. |
| [219] | Parte di queste circostanze sono mss. in Villabianca, Diario ined., a. 1787, pp. 4, 136-37, e a. 1800, p. 443; parte le abbiamo raccolte dalla bocca del Senatore Duca Giulio Benzo della Verdura, che ci ha autorizzati a pubblicarle. |
| [220] | Villabianca, Diario ined., agosto 1798, pp. 412-13. |
| [221] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, pp. 377-78; XXVIII, pp. 322-23, 181, 227 e segg., 208. — Alessi, Prontuario cit., p. 13. |
| [222] | Leggere nella Biblioteca Commun. di Palermo il ms Qq F 67, n. 12; Consulta della Giunta dei Presidenti e Consultore ne' titoli dei Marchesi di Geraci (Pal., 30 Apr. 1700) e l'altro Qq F 82, n. 8, p. 168: Consulta su i titoli che godono i Marchesi di Geraci. Cfr. pure in quest'opera il v. I, cap. IV, p. 87. |
| [223] | Villabianca, Diario ined., a. 1792, pp. 271-72. — D'Angelo, Giornale ined., pp. 23 e 33. |
| [224] | Meli, Poesie, p. 391, n. XLIX. |
| [225] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, p. 135. |
| [226] | Diario ined., a. 1793, p. 22; Diario, in Bibl., v. XXI, p. 181. |
| [227] | Provviste del Senato, a. 1793-94, p. 35. |
| [228] | Villabianca, Diario ined., a. 1793, p. 23. |
| [229] | Atti del Senato, a. 1800-1801, p. 158. |
| [230] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, pp. 370-71. |
| [231] | Provviste del Senato, a. 1779-80, pp. 387 e 679; a. 1783-84, p. 451; a. 1784-85, p. 281. |
| [232] | Provviste del Senato a. 1779-80, p. 643; a. 1781-82, pp. 63 e 918; a. 1783-84, p. 741. |
| [233] | Provviste del Senato a. 1787-88, p. 411. |
| [234] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 60. |
| [235] | Torremuzza, Giornale Istorico ined., p. 217 retro. Villabianca, Diario ined., a. 1785, pp. 44-46 e 78. |
| [236] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XX, pp. 111-12. |
| [237] | Torremuzza, Giorn. Ist. ined., p. 217 retro. — Villabianca, Diario ined., a. 1785, pp. 44-46 e 78. |
| [238] | Atti del Senato a. 1798-99, p. 245. — Villabianca, Diario ined. a. 1798, pp. 541-45; a. 1799, pp. 466, 473, 493; a. 1790, pp. 327 e 470. |
| [239] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, pp. 23-24. |
| [240] | La misura partiva dalle mura della chiesa. Un passo costava di cinque piedi; un piede di quindici dita. Vedi Fr. Gastone, De spatio asyli ecclesiastici: Canonica Dissertatio in causa immunitatis edita, art. II. Panormi, ex Typographia A. Epiri. 1699. |
| [241] | P. Gambacurta, De Immunitate Ecclesiarum in constitutionem Gregorii XIV, P.M., Libri octo. Lugduni, 1622. — M. Cutelli, De prisca et recenti Immunitate Ecclesiae et ecclesiasticorum libertate generales controversiae. Matriti, ex Typographia regia 1647. |
| [242] | Discorso sopra l'Asilo ecclesiastico, p. I.ª, § XX, XXIII, in Firenze, MDCCLXV. |
| [243] | Santacolomba, L'Educazione, pp. 361-62. |
| [244] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, p. 266. |
| [245] | Provviste del Senato, a. 1785-86, pp. 548 e 588. |
| [246] | Vedi il cap. Teatro. |
| [247] | Villabianca, Diario ined., a. 1794, p. 619; ed a. 1796, p. 379. |
| [248] | Penes Acto del 1799, nello Archivio Comunale di Palermo. |
| [249] | Villabianca, Diario ined., a. 1785, p. 70. |
| [250] | Gastone, De spatio, art. II. |
| [251] | Diario ined., a. 1785, p. 286. |
| [252] | Istruzioni per l'Amministrazione della Giustizia nelle occorrenze delle cause e materie criminali, nn. XXXIV e XXXV. Vedi Pratica per la formazione dei processi criminali composta dal Dr. D. Zenobio Russo e Diana. Nuova edizione, pp. 294-96. In Palermo, Felicella. |
| [253] | Istruzioni, n. XXII, p. 121. |
| [254] | Pitrè, Giuochi fanciulleschi sic., nn. 144, 188, 192; e p. LXIII. Palermo, 1883. |
| [255] | Un voyageur italien, Lettres sur la Sicile, pp. 5-6. |
| [256] | Santacolomba, L'Educazione, p. 376. Vedi anche Bartels, Briefe, v. III, pp. 579-80. |
| [257] | Meli, Riflessioni, p. 5. |
| [258] | Hager, Gemälde, p. 121. |
| [259] | Meli, Riflessioni, pp. 10-11. |
| [260] | Ciraulu, cantambanco, cerretano. |
| [261] | Bando del Vicerè d'Aquino, Principe di Caramanico, 20 giugno 1789. |
| [262] | Bartels, Briefe, v. III, p. 582. |
| [263] | Bando cit. del Vicerè Caramanico, 27 maggio 1793. |
| [264] | Santacolomba, L'Educazione, p. 375. |
| [265] | Avviso della R. Segreteria di Giustizia e di Alta Polizia in data del 21 Ottobre 1799. |
| [266] | Pinnata, tettoia. |
| [267] | Bando cit. del Vicerè Caramanico. |
| [268] | Avviso cit. della R. Segreteria di Giustizia ed Alta polizia. Sull'argomento vedi pure il vol. I, cap. II di quest'opera, e Cutrera, Storia della prost. in Sicilia. Palermo, Sandron, 1903. |
| [269] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 45-46. |
| [270] | Poesie: Ode a S. E. Signor D. Francisco d'Aquinu Principi di Caramanica e Vicerè di Sicilia. |
| [271] | Villabianca, Diario ined., a. 1793, pp. 196-200. Di ciò vedi pure vol. I. cap. VII. |
| [272] | «A dodici grani», ecc. cioè a cent. 25 di lira grammi 800 di pane; cosicchè una forma di guastidduni, del peso di chilogr. 1 e gr. 400, od anche di 1 e 600, veniva a costare cent. 42 di lira. |
| [273] | Villabianca, Diario ined., a. 1793, pp. 70-71, 82-84. |
| [274] | A. Candiloro, Historia medico-practica cephaludensis epidemicae constitutionis et morborum intercurrentium anni 1793, 94 et 95. ecc. Panormi, apud Solli, M.DCC.XCVII. pars IIª, paragrafo XXII. |
| [275] | Teixejra, Origine, cap. XV, paragrafo 236, p. 263. |
| [276] | L'Italia tradotta dal francese, p. 231, 1778. |
| [277] | Galt, Voyages, p. 26. |
| [278] | Meli, Riflessioni, pp. 9-10. |
| [279] | Rezzonico, Viaggio, pp. 133 e 139. |
| [280] | Galt, Voyages, p. 77. |
| [281] | Vedi i nn. 29 e 30. Palermo, 17 e 24 febbraio. |
| [282] | Hager, Gemälde, p. 223. |
| [283] | Bartels, Briefe, v. III, p. 586. |
| [284] | Proverbi siciliani, v. II, cap. XLV. |
| [285] | Vedi vol. I, cap. II, pp. 22-23. |
| [286] | De Saint-Non, Voyage. IVme vol., Ire partie, p. 156. |
| [287] | L'abuso, mal tollerato sempre, fu per ordine sovrano tolto il 16 maggio 1799. |
| [288] | De Saint-Non, op. e loc. cit. |
| [289] | Bartels, Briefe, v. III, p. 160. |
| [290] | Gemälde, p. 229. |
| [291] | A. Guarnieri, Alcune notizie sovra la gestione d'una casa baronale ecc., verso la fine del sec. XVIII. in Arch. stor. sic., c. XVII, pp. 121 e 143. Pal. 1892. |
| [292] | Pillole coperte di patina di vergogna. |
| [293] | Meli, Poesie, p. 102. |
| [294] | Scorrendo da alcuni anni gli archivi del «Nobile e Salutifero Collegio degli Aromatari» di Palermo, troviamo larghe prove di queste affermazioni dolorose. Nel solo a. 1785, per violazione di diritti, il Collegio, a ragion di liti, e per sole mance pagava di continuo i servi dei causidici Orlando, Ferraloro, Denti, Ardizzone e lo staffiere di Nicolò Schiavo, e i creati del Pretore, del Vicerè, del Presidente Leone, del Presidente Paternò, del Presidente Airoldi, e i seggettieri del Protomedico e perfino quelli del Procuratore del Collegio. |
| [295] | Meli, Riflessioni, pp. 6, 13, 15. |
| [296] | Ma l'apone ronza e lo manda giù (il miele raccolto dall'ape). Meli, Poesie: Don Chisciotti, c. VI, ott. 34. |
| [297] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XX, p. 18. |
| [298] | Capitoli delle costituzioni del pio Monte delle vedove dei Ministri, Avvocati, Procuratori causidici e di tutti quei che vivono nel Foro. Approvato (sic) da S. M. con R. Dispaccio de' 17 Maggio 1777. In Palermo, MDCCLXXVIII. |
| [299] | Villabianca, Diario ined., a. 1789, p. 631. |
| [300] | A. Guarnieri, loc. cit., pp. 122-23. |
| [301] | Vedi Archivio del Nob. e Salutifero Collegio degli Aromatari in Palermo, a. 1785 e segg. |
| [302] | Autobiography of Miss Cornelia Knight, Lady companion to the M.e Princess Charlotte of Wales ecc., second edition, v. I, p. 132. London, 1861. (Dobbiamo questa indicazione alla cultissima signora Contessa Jeanne Saint-Amour di Chanaz). |
| [303] | Com'essi fossero stati puniti ed in persona di chi e con quale affluenza racconta il Villabianca nel suo Diario, in Bibl., v. XXI, pp. 72-76. Nel v. XX, p. 255, è la notizia della pila ricordata in questa nostra pagina. |
| [304] | Pitrè, Modi proverbiali e motti storici di Palermo, n. 17. Palermo, 1902. |
| [305] | Lo stesso, Il Vespro siciliano, p. 85. Palermo, 1882. |
| [306] | Villabianca, Diario ined., a. 1787, p 142. |
| [307] | Un Vincenzo Pisanti nell'agosto del 1797 pregava il Pretore che volesse liberarlo dal carcere, dove l'aria era puzzolente e fetida. Penes Acta: Memoriali del 1797 nello Archivio Comunale di Palermo. |
| [308] | Il Meli, Riflessioni cit., p. 6, nel 1800 compiangeva: «Quanti miserabili marciscono nelle carceri per non venire abilitati dall'inesorabile creditore ad una razionale dilazione del loro debito? O pure per essersi il loro processo, per la frequente trascuraggine di chi doveva conservarlo, o per la calca degli affari, scordato o smarrito? O per esser poveri e non aver perciò i mezzi da scuotere l'indolente pigrizia de' giudici e de' fiscali»? Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 69, ricordando il taglione dato ad un giovane uxoricida di origine civile, dice che il Barone Andrea Inguaggiato gli dovette fare di suo il vestito, perchè «nella Vicaria era egli quasi ignudo». |
| [309] | Atti del Senato a. 1788-89, p. 63. |
| [310] | Ne aveva 4 grani il giorno. Il Re accrebbe di altre 240 onze all'anno l'assegno, e le quattro furon portate a sei grana (cent. 13). |
| [311] | Leggesi nel Giornale di Sicilia del 19 agosto 1794 (n. 3): 13 ag. 1794. «Il Principe della Trabia Cap. Giustiziere si condusse in gran pompa coll'intera sua corte alle pubbliche carceri, ove, com'è il costume, fece la visita per liberare alcuni di quei delinquenti in occasione della festa dell'Assunzione di M. V. Furono 26 quei che goderono di tal grazia, perlochè erogò egli la somma di onze 23 oltre di aver regalato gli Uffiziali di essa Corte.» |
| [312] | Triste documento il proverbio: Fa limosina la Vicaria: jetta..., con quel che segue. Di data anteriore, ma pur comunissima nel sec. XVIII, era la canzone:
|
| [313] | Villabianca, Opuscoli palermitani, Ms. Qq H 94, n. 2, p. 85, della Bibl. Comun. di Palermo. |
| [314] | La Vicaria mancava di spedale, e gli ammalati da curarsi venivano portati all'Ospedale grande in sedia volante e fiancheggiati da birri. Nello scorcio del secolo ad essa venne unita una infermeria. Fino al 1790 era medico maggiore della Vicaria, D. Giuseppe Catanese; dal 1791 in poi, per certo tempo, il celebre D. Francesco Berna. |
| [315] | Istruzioni, n. XXXVI. |
| [316] | Pratica per la formazione dei processi criminali composta dal Dr. D. Zenobio Russo e Diana. Nuova Edizione ecc. coll'aggiunta delle Istruzioni criminali ordinate dalla M. S. in relazione del signor D. Giuseppe Guggino ecc. In Palermo, Felicella. |
| [317] | Ciò significa che il reo dovea trascinare due catene pel peso complessivo di chilogr. 19 e gr. 200. |
| [318] | Istruzione, nn. XXVI, XIII, XII. |
| [319] | Villabianca, Diario ined., 22 febbr. 1798, p. 92; 14 giugno 1790, p. 467; 11 maggio 1797, pp. 151-52. |
| [320] | Questa divisa fu ordinata dal Presidente Airoldi, nel 1773, per distinguere il carnefice da qualunque altra persona di giustizia. |
| [321] | Opera pietosa nella sua ferocia era quella del boia maggiore, che dopo aver passato il laccio al collo del reo, si precipitava istantaneamente sopra costui, per abbreviarne gli spasimi ed affrettarne la morte. Di che pare si compiacesse il Villabianca, il quale sapeva che in Inghilterra i giustiziandi appena afforcati, si abbandonavano penduli nello spazio a strangolarsi da loro. Diario inedito, a. 1793, 12 ott., p. 251. |
| [322] | Villabianca, Diario ined., 24 sett. 1794, p. 613. |
| [323] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XX, p. 167; v. XXI, pp. 114, 140, 214. |
| [324] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, pp. 300-301; Diario ined., a. 1798, p. 537. |
| [325] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVIII, pp. 59-61. Questi trattati furono: De judiciis causarum feudalium (Panormi, 1596), e De Concessione feudi (1578). La medesima sorte aveano incontrato nel 1766 le Aureae Decisiones R. Curiae Regni Siciliae di Fr. Milanese da Catania (Venetiis, 1595). |
| [326] | Diario ined., 5 nov. 1791, pp. 184-85. |
| [327] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 197-98. |
| [328] | Giornale ined., p. 456. Questo P. Arceri passò in proverbio, come può vedersi nei nostri Modi, n. 63. |
| [329] | Storia del Reame di Napoli, l. IX, cap. 13. — F. G. La Mantia, Sui libri legali bruciati in Palermo, in Archivio storico siciliano, N. S., a. XII, pp. 458-464. Pal. 1888. |
| [330] | Torremuzza, Giornale Istorico, 13 genn. 1781, p. 200. |
| [331] | Il cav. Eduardo Rivarola di Roccella, Archivario della Nob. Compagnia dei Bianchi, promette una pubblicazione in proposito. |
| [332] | Vedi vol. I, cap. II: Su e giù per Palermo, p. 18. |
| [333] | Brydone, op. cit., lett. XXI. |
| [334] | Diario ined., a. 1788, e disegno dell'una e dell'altra a p. 496. Il medesimo Villabianca, Palermo d'oggigiorno, v. II, p. 226, aggiunge: Questa forca (lo Sperone) «nel 1788 fu in questo luogo spiantata per non più recare in appresso il disgusto di vederli appesi a quei ferri, fatti in pezzi, i cadaveri di quei feroci montanari ch'erano stati giustiziati come assassini di strada. |
| [335] | Villabianca, Diario ined., 27 sett. 1798, pp. 493-95. |
| [336] | Nel marzo del 1778 eran trasportate nella chiesetta della Madonna del Fiume, ossia delle Grazie, o del Ponte, le teste dei decapitati del serbatoio della piramide nel Piano di S. Erasmo. Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 285. |
| [337] | Vedi v. I, p. 20. |
| [338] | La condanna e la esecuzione di questo paggio, Em. Caniggia (ottobre 1789), fu un colpo fatale pel Vicerè Principe di Caramanico, che l'avrebbe voluto assolto dai giudici e, condannato, proposto per la grazia dai Bianchi. In suffragio del giustiziato fece egli celebrare funerali more nobilium e 200 messe (11 ott.). Indignato della condotta dei Bianchi, abolì la secolare loro prerogativa; che però in forma di proposta fu mantenuta ed accettata dal Governo fino al 1819. |
| [339] | Lanza e Branciforti, Diario, a. 1797. |
| [340] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 71. |
| [341] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 792-793. |
| [342] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, pp. 155-56, 216. Vedi pure v. XX, p. 142; v. XXI, p. 185; v. XXVI, pp. 71, 15-16; v. XXVII, pp. 356-57. |
| [343] | Italianische (sic) Reise. Stuttgart u. Tübingen, 1816, weiter Theil, 1817. |
| [344] | Il primo, posseduto dal Cav. Carlo Crispo-Moncada; il secondo, custodito dal Cav. Rivarola nell'Archivio dei Bianchi, entrambi messi dagli egregi amici a nostra disposizione. |
| [345] | Vedi Villabianca, Diario ined., 15 giugno 1793, p. 189; 4 giugno e 6 dicembre 1796, pp. 461 e 659; 14 dic. 1797, pp. 142-43; 8 luglio e 2 dic. 1799, pp. 294 e 582. — D'Angelo, Giornale ined., 2 dic. 1799, p. 733. |
| [346] | Versione letterale: (A) chi dice male del carcere — io darei coltellate sul viso; — chi dice che il carcere gastiga, — povero a lui, come s'inganna! — Il carcere è viottolo che vi avvia — e che vi conduce alle strade ed alle purteddi (luoghi nei quali i ladri attendono i passeggieri). |
| [347] | Diario ined., a. 1792, p. 420. |
| [348] | Sopra I Giornali e la Pubblicità in Palermo nella seconda metà del sec. XVIII fu da noi inserito uno studio nell'Archivio storico siciliano, a. XXVII, pp. 300-319. |
| [349] | Gazzetta poi significava anche notizia, talvolta strepitosa o strana. Il Meli nel Viaggiu in Sicilia di un antiquariu parla di gazzette che venivano da Fuligno e da Firenze. La Gazzetta fulignate era settimanale a fogli da 4 pp. a due colonne, della dimensione un terzo più grande del nostri giornali d'allora, e con la testata, p. e., così: Num 38 Fuligno, 18 settembre 1767. (In Fuligno: Per Feliciano, e Filippo Campitelli, Stamp. Vesc.). |
| [350] | Una notizia preziosa pei poveri malati di Lotto: Questo giuoco, la cui officina era ed è sempre detta Impresa, chiamavasi prima di Napoli, poi di Palermo. D'Angelo, Giorn. ined., p. 257, scriveva: «26 gennaio 1799 nella Loggia della R. Accademia dei pubblici studi si fece la prima estrazione del Lotto con gran concorso di popolo, dei ministri a ciò destinati. Numeri sortiti: 35, 2, 34, 48, 71.» Cfr. Alessi, Prontuario ms., n. 90, p. 17. |
| [351] | Goethe, Italienische Reise, lett. dei 13 e 14 apr. 1787. |
| [352] | Frantz Funck-Brentano, L'affaire du collier d'après de nouveaux documents recueillis en partie par A. Régis. Cinquième édition. Paris, Hachette, 1903. |
| [353] | Ci richiamiamo alla pag. 45 del vol. I, per togliere con questa l'equivoco nel quale eravamo caduti a proposito della visita di Goethe. |
| [354] | Goethe, Italienische Reise, lett. 13-14 aprile citata. È strano che J. R. Haarhaus, Auf Goethes Spuren in Italien, III Theil: Unter-Italien, proponendosi di seguire il sommo scrittore nelle sue peregrinazioni anche in Sicilia, non abbia avuto una parola nuova, neanche per far conoscere la casa nella quale stavano i Balsamo (cfr. p. 117). |
| [355] | Questa circostanza nuova, non è guari acquisita dalla storia del Balsamo, risulta dal Codice Vaticano, n. 10192: Avvenimenti sotto il pontificato di Pio VI dall'a. 1775 al 1800 raccolti da Fr. Fortunati, carta 107. Cfr. Archivio stor. sic. N. S., a. XV, p. 154. Palermo, 1900. |
| [356] | Compendio della vita, e delle gesta di G. Balsamo denominato il Conte Cagliostro, che si è estratto dal Processo contro di lui formato in Roma l'anno 1790, ecc. In Roma MDCCXCI ed in Palermo, MDCCXCI. Nella stamperia di D. Rosario Abbate. |
| [357] | Testamento di Cagliostro, morto ultimamente di apoplessia nella fortezza di S. Leo; 4 sett. 1795. |
| [358] | Notizie più o meno conosciute del Cagliostro han fornite: Cantù, Italiani Illustri, v. II, pp. 1-29, che pure cita (p. 29) alcune pubblicazioni in proposito; Henri d'Almeras, Cagliostro (Paris, Société d'Imprimerie 1903); L. Tommasi, Il Conte Cagliostro a Trento, in Tridentium, IV, 8; F. Pasini, Ancora del Cagliostro nel Trentino, 1788-89, in Tridentum, V, 1, 1902. — A. Dumas e Franco Mistrali ne fecero argomento dei loro romanzi: l'uno, Giuseppe Balsamo; l'altro Frammassoni e Gesuiti, ovvero il Conte Cagliostro e Fra Lorenzo Ganganelli (Milano, Terzaghi, 1862): una delle più solenni sconciature. |
| [359] | Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi pubblicato per opera e studio di Alfonso Airoldi Arcivescovo di Eraclea, Giudice dell'Apostolica Legazia e della R. Monarchia del Regno di Sicilia. Palermo, nella R. Stamperia 1789-92. In 4., voll. III in parti 6. |
| [360] | Ben diversamente racconta questo e l'altro aneddoto di Cefalù, Hager, Nachrichten, pp. 30-31. |
| [361] | Libro del Consiglio di Egitto tradotto da Giuseppe Vella. Cappellano del Sacro Ordine gerosolimitano, Abate di S. Pancrazio. Palermo, dalla R. Stamperia, 1793, T. I. in folio. |
| [362] | Reise cit., III, pp. 322-23. |
| [363] | Hager, Nachrichten, più oltre citati. — Scinà, Prospetto della Storia Letteraria di Sicilia nel secolo XVIII, t. III, cap. IV. Palermo, Dato, 1827. |
| [364] | Geschichte der Araber in Sicilien ecc. Aus dem Italienischen. Von Ph. W. Hausleutner. Königsberg, 1791-92. Voll. 4 in 8º. |
| [365] | Hager, Gemälde, p. 198. |
| [366] | Meli, Poesie, p. 97. |
| [367] | Diario ined., a. 1795, pp. 164-90. Vedi pure un volume miscellaneo di mss. e stampe pro e contro Vella, XLVI, F 53 e XLVI, G 87 della Biblioteca Comunale di Palermo. |
| [368] | Hager, Nachrichten von einer merkwürdigen literarischen Betrügerei auf einer Reise nach Sicilien im Jahre 1794. Erlangen, Palm. 1799. — Relation d'une insigne Imposture Littéraire découverte dans un Voyage fait en Sicile en 1794. Traduit de l'Allemand, à Erlang. Palm. 1799. |
| [369] | B. Lagumina, Il falso Codice arabo-siculo, in Archivio stor. sic., N. S., a. V, fasc. III-IV, pp. 233-314. Pal. 1881. |
| [370] | Sull'argomento vedi pure V. Di Giovanni, Filologia e Letteratura sic., p. I, pp. 354-57. Pal. 1871. — G. Di Giovanni, La vita e le opere di G. A. De Cosmi, pp. 195-97. Pal. 1888. Il Codice arabo di S. Martino è esposto in una delle vetrine del R. Archivio di Stato; il ms. originale del così detto Consiglio di Egitto, presso l'avv. Pietro Varvaro. Il grande romanzo edito come versione del Codice diplomatico arabo dal buon Airoldi, consta di quasi 4000 pagine e se ne ha un esemplare nella Biblioteca Comunale. |
| [371] | D. Ignazio Salemi, Educazione medica, t. I. Palermo, 1812. |
| [372] | Provviste del Senato, a. 1790-91, p. 373; a. 1787, p. 178. |
| [373] | Lettere inedite, nn. XXVIII e VI, in Nuove Effemeridi siciliane, serie III, v. XI. Pal. 1881. |
| [374] | Filangeri, La Scienza della Legislazione, l. IV, c. XXX, Nota. |
| [375] | Cfr. Scimonelli, Poesie: L'aromatario degli andati tempi. — Pitrè, Medicina pop. sic., pp. 23-25. |
| [376] | Conversazione Istruttiva cit., n. 1, p. 3. |
| [377] | Rimandiamo, per le citazioni in proposito, ai nostri Usi e Costumi, v. II; Il Viatico. Pal. 1889. |
| [378] | Salemi, op. cit., t. I, art. XVI. |
| [379] | F. E. Cangiamila, Medicina sacra, v. II, p. 43 e seg. In Palermo, Solli, 1802. |
| [380] | Vedi un opuscolo che comincia: Beatus vir ecc. In Palermo, MDCCLVIII. Nella stamp. della Divina Provvidenza presso l'Erede d'Accardi. In fol., pp. 6. |
| [381] | Reali Dispacci, n. 1506, fogli 31-82, nell'Archivio di Stato. |
| [382] | In Palermo, Felicella MDCCLXII. |
| [383] | Breve Ragguaglio, pp. VII, XL, nn. 5 e 13. |
| [384] | Breve Ragguaglio, pp. 19-20. |
| [385] | Pitrè, Medicina pop. sic., pp. 238-41 e 250. |
| [386] | Stampa annessa al Diario inedito del Villabianca, an. 1787, p. 371. |
| [387] | Villabianca, Diario ined., a. 1788-89 agosto, p. 437. |
| [388] | Villabianca, Diario, a. 1771. Ms Qq D 97, p. 423 della Biblioteca Comunale di Palermo. |
| [389] | Fundatio publici Coemeterii, p. 83. Anno 1783. |
| [390] | Delle febbri che travagliaron la città di Palermo nel 1793. Pal. 1793. |
| [391] | G. Logoteta, Dissertazione fisico-medico-politica sulle febbri putride presenti. Siracusa 1793. — S. Fallica, Descrizione delle febbri epidemiche accadute in questa città di Catania l'a. 1792 e 1793. In Catania, MDCCXCIV. |
| [392] | Vedi Candiloro, p. 272 del presente volume. |
| [393] | Opuscoli di autori siciliani, t. XII. Palermo, 1771. |
| [394] | Speciosa la forma grammaticale: con il di lei feto! |
| [395] | Sull'argomento, che lasciamo intatto, dell'Accademia del Buon Gusto potranno leggersi, oltre quello che ne scrisse Scinà nel suo Prospetto, le memorie di V. Di Giovanni e di Luigi Sampolo negli Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo, serie III, a. 1891, v. I (Palermo 1891), a proposito del centenario di essa Accademia del Buon Gusto. Il Sampolo tornò sull'argomento nel Bullettino della medesima Accademia, a. 1894-99, pp. 6-9. |
| [396] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, p. 317. |
| [397] | Meli, Poesie, p. 127: In lodi di lu purci; p. 129: In lodi di la musca; p. 143: Contra li cirimonii e lu Galateu. |
| [398] | D'Angelo, Giornale ined., 22 nov. 1791, p. 1. |
| [399] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 116-17, 126-27. |
| [400] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 136-38. |
| [401] | D'Angelo, Giornale ined., pp. 172-74, 179. |
| [402] | Un R. Dispaccio del 22 febbraio 1796 lo chiamava a leggere nella R. Accademia «il sistema di Sfigmica da lui formato», e gli assegnava onze tre il mese di stipendio. Commissione Suprema della Istruzione ed Educazione in Sicilia, Repertorio amministrativo, vol. n. 4, a. 1795-96, foglio 8, dell'Archivio di Stato. |
| [403] | Si era costituita nel luglio del 1777 col titolo: Nuova Società di Letterati per la Storia del Regno di Sicilia. |
| [404] | V. Di Giovanni, La prima Società di Storia patria in Palermo, nell'Archivio storico sic., N. S. a. VIII, pp. 491-510. Palermo, 1884. |
| [405] | Meli, Poesie, p. 106. |
| [406] | Pitrè, Fiabe, Novelle e Racc. pop. sic., v. I, pp. 186-87. |
| [407] | Giornale di Sicilia, n. 23, Pal., 6 genn. 1795. |
| [408] | Meli, Poesie, p. 107. — D'Angelo, Giornale ined., p. 93. |
| [409] | Meli, Poesie, p. 112. — Sull'argomento, vedi L'Accademia sic. di Pal. In Pal. MDCCCXCIV; e Sampolo, L'Accademia sic. Nuove ricerche. Pal. 1896. |
| [410] | Cfr. v. I, pp. 227-28. |
| [411] | Leo, Storia d'Italia nel medio evo, lib. X. c. L, IV. |
| [412] | Lettre de M. l'Abbé Cannella à M. le Baron N. N. sur la Littérature de Palerme, c'est à dire des Portraits des Savans Palermitains de nos Jours. A Naples, Russo, 1794. |
| [413] | Scinà, Prospetto, t. III, c. II. |
| [414] | Cannella, Lettre, pp. 43-44. |
| [415] | Bartels, Briefe, v. III, pp. 706-707. |
| [416] | La Filosofia Leibniziana esposta in versi toscani, t. I, l. I. In Firenze (Palermo) 1758. |
| [417] | Meli, Poesie, p. 102. |
| [418] | Scinà, Prospetto, t. II, cap. II. |
| [419] | Bartels, Briefe, v. III. p. 703. — Cannella, Lettre, pp. 36-37. |
| [420] | Bartels, Briefe, v. III, p. 699. — Meli, Poesie, p. 50. — Cannella, Lettre, pp. 35-36. — Scinà, Prospetto, t. III, c. III. |
| [421] | Vedi v. I, cap. XVIII. |
| [422] | Meli, Poesie, p. 148. |
| [423] | La Lumia, Giuseppe d'Alesi e la Rivoluzione di Palermo del 1647, Documenti, n. 3. — I. Carini, L'Università di Palermo nell'a. primo del corrente secolo, in Arch. stor. sicil., a. II, p 235. Pal. 1874. |
| [424] | G. Di Giovanni, La vita e le opere di G. A. De Cosmi, pp. 152-53. |
| [425] | Carini, op. e loc. cit., pp. 236-38. |
| [426] | L. Sampolo, La R. Accademia degli Studi di Palermo, cap. VI e segg. Palermo, 1888. — Scinà, Prospetto, t. III. |
| [427] | D'Angelo, Giornale ined. pp. 170-79. |
| [428] | A. Gallo, in Poesie scelte di M. Monti, p. X, Palermo, 1839. |
| [429] | Istruzioni preliminari emanate da Mons. Airoldi, il 17 gennaio 1779. Pal. 1779. |
| [430] | La Favilla, appendice al n. 21. Palermo, giugno 1858. |
| [431] | Diario ined., a. 1799, pp. 64-65; a. 1800, p. 528. |
| [432] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXI, p. 324. |
| [433] | In Palermo MDCCXCVI. Per le stampe del Gagliani. In fol., pp. IV. |
| [434] | Miscellanee diverse di Sicilia presso il Principe di Trabia, vv. 9 e 10. |
| [435] | Commissione Suprema della Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia. Ripartimento amministrativo, a. 1799, vol. 4. Nel R. Archivio di Stato di Palermo. |
| [436] | Saggio poetico del sig. ab. D. Ant. Galfo. T. I. p. 184. Roma, MDCCLXXXIX. |
| [437] | Villabianca, Diario, in Bibl., v. XIX, pp. 331-34; v. XXI, p. 139; v. XXVI, pp. 232, 278-79. |
| [438] | Stato della Deputazione de' Regj Studj del Regno di Sicilia, e del Convitto Real Ferdinando ecc. per l'a. MDCCLX-XXI. Palermo, R. Stamperia. Questo Stato si pubblicava ogni anno, ed era quindi un Annuario della Pubblica Istruzione di Sicilia. |
| [439] | V. E. Sergio, Memoria per servire ad un piano di una nuova casa di educazione per la gente bassa. Palermo, Bentivenga, 1779. |
| [440] | Avviso ai signori nobili che vorranno collocare le loro figliuole nel R. Educandario Carolino. In Pal., MDCCLXXXIII. — Stato della Deputazione de' Regj Studj ecc. (anno 1785). — Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVI, p. 261. |
| [441] | Houel, Voyage, t. IV, p. 54. |
| [442] | Natale, Riflessioni politiche. Palermo, 1772. |
| [443] | Pitrè, Proverbi siciliani, v. I, cap. XXII. |
| [444] | Costituzioni del Conservatorio del Buon Pastore dei Figliuoli dispersi di questa Capitale, cap. XXII, pp. 44-45. In Palermo, MDCCXLVIII. |
| [445] | Santacolomba, L'Educazione, p. 482. |
| [446] | Commissione Suprema della Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia, anno 1782-1788, v. II, p. 31 retro. Nel R. Archivio di Stato di Palermo. |
| [447] | Una, la più comune, diceva:
G. Pitrè, Una formola scolaresca, nell'Archivio delle tradiz. pop., v. VIII, pp. 377 e segg. Palermo, 1889. |
| [448] | Vedi sonetto siciliano inedito nel ms. segnato 2 Qq D 30 della Biblioteca Comunale di Palermo, e Villabianca, Diario, in Bibl., v. XXVII, p. 4, e v. XXVI, pp. 198-200. |
| [449] | Hager, Gemälde, p. 192. |
| [450] | Avviso a stampa in data del 18 marzo 1796, a firma del Vicario generale della Diocesi di Palermo. |
FINE DEL VOLUME SECONDO
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, così come le grafie alternative (Arcieri/Arceri, sotto-regole/sottoregole, avversari/avversarî, mormorio/mormorìo e simili), correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Per comodità di lettura sono stati inseriti nelle note, dove non presenti o errati, i numeri di pagina relativi al testo richiamato nelle note stesse, nella forma {p. nn}. Sono stati corretti i seguenti refusi (tra parentesi il testo originale):
47 — Il giuoco [guoco], non v'inganno, a me67 — Che [Cre] dalla ruota e dal martel cadente205 — e di egregio [egrerio] casato218 — non il mellifluo [mellifuo] Caramanico271 — Per convincersi [convircersi] di questa verità279 — Principessa Carlotta di Wales [Walls]347 — la opinione [opione] del Tychsen358 — non sacerdote [sacedote], ma semplice chierico361 — e qualche operazione chirurgica [chirurigica]447 — si ebbero fino a nove [nuove] istituzioni
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA VITA IN PALERMO, VOLUME 2 ***